 «Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri nonna Clara! Tanti auguri a te!».
«Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri nonna Clara! Tanti auguri a te!».
Il festoso canto fuoriuscì dalle ugole dei quattro nipoti che, affettuosamente, circondavano la minuta figura dai capelli argentei. Visibilmente commossa, la donna, al termine del canonico brano di compleanno, soffiò, con non poca fatica a causa dell’emozione e del Parkinson, quest’ultimo avanzava lento ma costante nel suo gracile corpo, sulle due cifre di cera colorata che insieme formavano il numero 80.
Gran parte dell’emozione, però, era dovuta a quella scena che vedeva, dopo non ricordava neanche più quanto tempo (forse dal funerale di Peppe, il marito morto sette anni prima), tutta la famiglia al gran completo: i due figli Anna e Michele, con i rispettivi coniugi, e i quattro nipoti, tre discendenti della prima e uno del secondo.
E mentre i quattro ragazzi, dalle età spalmate tra i sedici e i ventiquattro anni, scattavano foto con la festeggiata, con i due “non consanguinei” che osservavano contenti, in disparte, Anna e Michele parlottavano sottovoce.
«Non possiamo dirglielo ora. Lo vedi com’è felice?» disse lui fissando il gruppetto di famiglia.
«E quando allora? Noi domattina dobbiamo ripartire e non posso rifarmi settecento chilometri solo per parlarle chiaramente» rispose con un pizzico di acidità la sorella.
«Sì, ma almeno aspettiamo che finisca la festa e che i ragazzi vadano via».
«Va bene, ma non un minuto di più. Prima glielo diciamo e meglio sarà per tutti. Lei capirà che è per il bene della famiglia».
«Speriamo» rispose poco convinto Michele.
«Mamma, dobbiamo parlarti».
Terminato anche l’ultimo brindisi, e dopo aver aiutato la nonna a scartare i regali, i quattro ragazzi avevano lasciato quella casa con un “Nonna, ci vediamo domattina, prima di partire”. Con loro erano andati via anche Arturo e Francesca, i coniugi di Anna e Michele, d’accordo con i propri consorti sulla necessità di avere un incontro esclusivo a tre.
«Che sono queste facce? È successo qualcosa?» chiese preoccupata la donna, mentre con la mano sinistra tentava invano di frenare il tremore dell’altra.
«Mamma, c’è una cosa importante che dobbiamo dirti. Per il bene della famiglia» rispose Michele sommessamente.
«Michele, Anna, cos’è che non va? Sono vostra madre, ditemi tutto».
«Ecco, mamma, vista la situazione, la tua età che avanza, così come i tuoi acciacchi, la nostra lontananza e l’impossibilità di essere sempre presenti, d’accordo con Michele pensavamo che per il tuo futuro e per la tua salute sarebbe meglio se ti affidassi ad una struttura medica che possa aiutarti in tutto e per tutto costantemente» disse Anna tutto d’un fiato.
Come un macigno le parole colpirono Clara in pieno petto, impedendole di rispondere. La donna serrò gli occhi per qualche secondo, poi li riaprì e fissò quelli dei propri figli. Michele non ebbe la forza di sopportare quel “peso” e abbassò il capo, Anna, da sempre la più forte, accettò invece quella sfida.
«Lo sapete che mi state mandando a morire?» disse d’un tratto Clara celando ogni emozione.
«Non dire così, mamma. È per il tuo bene. Li riceverai tutte le cure che ti servono, con il personale che sarà con te ventiquattro ore su ventiquattro» rispose Anna.
«Non ti mancherà nulla, vedrai. Ti sentirai a casa» aggiunse Michele.
«È questa casa mia. Voi, i miei nipoti, queste mura».
«Sì, ma vedrai che lo diventerà anche quella struttura. È un ottimo centro, farai amicizia con altra gente e non sarai sempre sola come capita spesso ora».
«Non mi interessa, io voglio morire a casa mia».
Alla parola “morire”, pronunciata per la seconda volta, un brivido attraversò la schiena di Michele.
«Mamma, ascolta me. Lo sai che viviamo dall’altra parte del paese e non possiamo venire qui una volta a settimana, per ogni problema che si presenta e che sempre più spesso si presenterà, viste le tue condizioni fisiche» riprese diretta Anna.
«E quindi mi state scaricando in quell’ospizio».
«Nessuno ti sta scaricando, mamma. Lo facciamo per il tuo bene. E non è un ospizio» intervenne Michele.
«Il mio o il vostro?».
«Di entrambi. Non vogliamo metterti in casa una badante, servirebbe a poco e poi il paese penserebbe che ti abbiamo abbandonata ad una sconosciuta».
«E a me cosa dovrebbe importare delle voci del paese? Mi state comunque abbandonando in una casa di cura, non con una ma con dieci badanti» rispose la donna mostrando tutta la sua lucidità.
«Mamma, mettiti nei nostri panni. Continuare questo su e giù per l’Italia sta diventando sempre più difficile e costoso. È la soluzione migliore per tutti» disse quasi con le lacrime agli occhi Michele.
«È dunque questo che avete deciso per la fine di vostra madre?» chiese infine.
I due non risposero ma i loro occhi dissero “sì”.
«E allora sia. Portatemici. Ma sappiate che mi state portando a morire».
«Mamma, ci vediamo presto».
Una settimana dopo quell’incontro, Anna e Michele erano tornati nuovamente in paese per accompagnare la propria mamma presso la casa di cura. Nel tragitto in auto solo un freddo silenzio che, anche una volta arrivati e varcata la soglia della struttura, non era stato infranto da Clara.
«Non fare così, vedrai che ti troverai bene» le disse Anna salutandola con un bacio sulle guance.
«Ti prego, perdonaci» disse, invece, con gli occhi lucidi Michele abbracciandola forte.
Poi un’infermiera, giunta per accompagnare la donna nella sua camera, le porse il braccio e i due la videro sparire lentamente oltre una porta bianca.
«Pronto, sono Michele Fulchini, il figlio di Clara Patucci. Come sta mia madre oggi?».
«Buongiorno signor Fulchini. Purtroppo, la situazione non è cambiata molto rispetto ai due giorni scorsi, se non in peggio».
Sin dai primi istanti trascorsi nella struttura la donna aveva rifiutato il cibo e i medicinali e la famiglia era stata immediatamente messa al corrente della situazione. Dopo tre giorni, i medici avevano deciso di sedarla e di somministrarle delle flebo, almeno per tenerla idratata.
«Il prossimo tentativo che possiamo fare, ma speriamo sempre in un suo ravvedimento, sarà la somministrazione di cibo per via endovenosa» aggiunse la voce femminile dall’altra parte del telefono con un tono fermo e professionale.
«Capisco» rispose avvilito.
«Non è la prima volta che accade e, di solito, ciò dipende dalla non accettazione della scelta presa dalla famiglia di destinare il proprio genitore alle nostre cure. La interpretano come un abbandono».
«E c’è una soluzione?».
«Ripensare alla scelta e parlarle».
Terminata la telefonata, Michele fece un tentativo con la sorella, spiegandole la situazione e i gravi problemi di salute che potevano insorgere nell’immediato futuro, ma Anna era irremovibile sulla decisione.
«Mamma, sono Michele. Mi senti?».
Una settimana dopo l’ingresso nella casa di cura, Clara era a letto, quasi totalmente priva di lucidità, scheletrica. Una serie di tubicini le fornivano quanto necessario per tenerla in vita e l’aiutavano ad espellere quanto in eccesso.
«Mamma, sono Michele. Mi senti?» ripeté il figlio.
La donna mosse di poco il capo e incrociò il suo sguardo mentre gli occhi dell’uomo s’inumidivano di pianto.
«Mamma, come stai?» provò Anna.
I due erano arrivati quella mattina, dopo aver condiviso buona parte del lungo viaggio insieme.
«Così». La parola sembrò giungere da un luogo che non apparteneva al corpo della donna, espressa con un tono che i due figli non avevano mai udito nella loro vita.
Anna e Michele si guardarono attoniti.
«Mamma, ti mandano un grosso bacio i ragazzi, Arturo e Francesca. Purtroppo, non son potuti venire ma contano di farlo quanto prima» disse con un leggero tremolio nella voce il figlio maschio.
«Perché non mangi? E perché non prendi le medicine?» Anna superò quasi immediatamente la fase di stupore per tornare a cose più “terrene”.
«Casa. Po-portatemi a casa» disse lentamente e quasi con un sibilo Clara, ora si intravedeva qualche barlume della sua voce.
«Lo vedi in che condizione sei? Non puoi lasciare questo posto ora. Devi curarti, riprendere a mangiare. Devi rialzarti da questo letto» rispose secca Anna.
«Mamma, Anna ha ragione. Non stai bene, devi riprenderti un po’ prima, e poi forse ti riportiamo a casa».
Su queste ultime parole Anna fulminò il fratello con uno sguardo.
«Sì, l’importante è che ora riprendi le forze» aggiunse lei.
La donna osservò i propri figli, intensamente, poi li gelò dicendo: «Ci vedremo al mio funerale».
«Signori, mi spiace ma ora Clara deve riposare».
Un’infermiera dalla candida veste interruppe improvvisamente quell’incontro, ma Clara ne aveva già decretato la fine.
«Hai letto il manifesto funebre?».
«No, quale?».
«Quello lì», indicò con un cenno del capo la donna sulla settantina che, con due sacchetti della spesa colmi stretti tra le mani, attraversava la piazza principale del paese affiancata dalla sua amica, di poco più giovane di lei.
L’altra allora si avvicinò incuriosita a quel riquadro bianco cartaceo dai bordi neri affisso su una delle pareti delle abitazioni che si sviluppavano sul lato orientale della piazza, spazio di sovente utilizzato per questo tipo di comunicazioni.
«All’età di ottant’anni è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Clara Patucci. Ne danno il triste annuncio i figli Anna e Michele, il genero Arturo, la nuora Francesca e i nipoti Giuseppe, Carmine, Lucilla e Giovanni».
Rifletté qualche secondo su quel nome, poi chiese all’amica: «Clara Patucci? Ma non è quella che è stata messa in ospizio poco tempo fa dai figli che non volevano più badare a lei?».
«Sì, esatto».
«Essere abbandonata così dai figli. Che brutta fine».
(pubblicato nell’antologia “Ah, la vecchiaia!” -Montegrappa Edizioni, 2019)








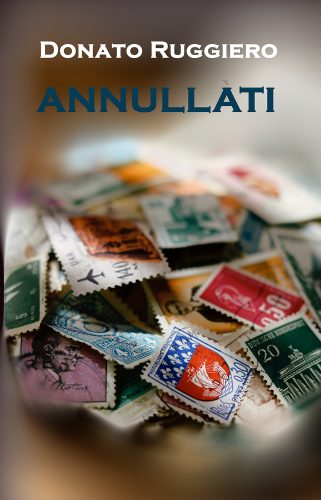
Lascia un commento