Donato e Giovanni Ruggiero
Lo scorso anno ha preso il via la collana “2 Fratelli. 2 Stili. 2 Storie (+2)” realizzata con mio fratello Giovanni, un’iniziativa aperiodica che, accanto alla pubblicazione di quattro racconti editi, vede, in ogni volume, la presenza di un capitolo di un romanzo inedito dal titolo “Niente va più”, un thriller scritto a quattro mani che, muovendo i primi passi con “Diastema”, e proseguendo con “Strabismo di Venere” e “Psicoacustica”, sta crescendo, e continuerà a crescere, con la collana stessa. Di seguito il primo capitolo di “Niente va più”.
NIENTE VA PIU’ – Capitolo 1
Le mele la circondavano come tante bocce intorno al pallino. Su tutte c’era un unico morso.
«Laura, cosa hai fatto?».
«Ho mangiato una mela».
«Sì, ma ne hai buttate dieci!».
«Beh, ho permesso a tutte di non sentirsi inutili».
«Non capisco…».
«Non mangio sempre la frutta, soprattutto le mele. Mi va oggi, forse tra una settimana o mai più. Le altre sarebbero marcite senza essere mai state assaggiate…».
«Potevi darle a me!».
«Ti saresti sentito obbligato a ricambiare il favore; e, io, non voglio persuaderti ad agire, regalandoti qualcosa che ho scartato».
«E allora perché non ne hai comprata solo una?”.
«Io non creo nuovi orfani…».
Il riflesso scomparve nelle pareti, assecondando il suo passo incerto. Sorrise, insensibile alla folata di vento freddo che lo sorprese con le difese abbassate. Rimase fermo e, sicuro che le ante scorrevoli non gli avrebbero ripresentato i resti dell’ultima operazione, sperò che il segnalatore laser posto sulla sommità della porta fosse quello di un cecchino, con il mirino fermo sulla fronte, pronto a sparare.
«Si presenteranno e con occhi colmi di empatia ti diranno che la vita è un lungo tornante a gomito in cui ci si accorge del pericolo solo quando è ormai troppo tardi per frenare», gli disse una suora tirandogli dolcemente la manica del cappotto.
«Scusi, cosa ha detto?!», rispose sorpreso Fritz.
«Le ho chiesto se si sente bene».
«Tutto bene, grazie. Ero solo sovrappensiero…», si giustificò, più con sé stesso che con l’inviata di Dio, per non ammettere l’evidente: le allucinazioni auditive erano solo il passo successivo alla perdita definitiva della propria libertà mentale.
«Il Signore la benedica».
«Come se avessi accettato. Scusi…», disse arrossendo, mentre la suora a testa china lo lasciava sul posto.
Lentamente, con le cicatrici ancora fresche che pulsavano sotto le ampie garze, l’uomo si portò verso la fermata del bus che, fortunatamente, non distava poi molto dall’uscita laterale del Thomas Jefferson University Hospital di Filadelfia.
Una donna con un piccolo essere misterioso avvolto in grembo e un’anziana figura dalla pelle scura occupavano l’unica panchina disponibile sul marciapiede. Incuriosito, Fritz Carraldo si avvicinò alla donna allungando il collo per scoprire il destinatario della sua protezione, notando con sorpresa che da quel lungo lembo di stoffa colorata avvolto con cura spuntava un muso peloso.
“Prossimo autobus per Andorra, attesa 8 minuti” lesse sul display che affiancava la palina, poco prima che un’improvvisa raffica di vento lo colpisse in pieno volto. Istintivamente Fritz chiuse gli occhi e ruotò la testa in direzione contraria al soffio freddo. Riacquistata la vista, il suo sguardo incrociò una piccola struttura in legno su cui campeggiava la scritta “A Little Free Library. Take a Book, share a Book”.
“E questa? Non l’avevo mai notata prima”, pensò sorpreso.
Si avvicinò e osservò attraverso la porticina a vetri che separava il contenuto della casetta dal mondo esterno.
“Libri? Ad una fermata del bus? Che stranezza”. E tornò verso la panchina.
«Non è possibile! Ogni giorno ne inventano una!» sbraitò d’un tratto la donna.
Fritz non distinse immediatamente il destinatario dell’invettiva. Poi, verificando nuovamente il tempo d’attesa, comprese.
“Prossimo bus per Andorra, ritardo previsto 45 minuti”.
«E pure oggi dovrò farla a piedi» e, col viso rosso di rabbia, la donna si alzò di scatto e s’incamminò.
L’uomo la osservò silenzioso diventare sempre più piccola lungo la strada, sino a scomparire.
“E attendiamo allora”.
Prima di occupare il posto sulla panchina, ora vuoto, i suoi occhi e la sua mente tornarono verso la piccola biblioteca di strada, seguiti, infine, dal corpo.
Aprì la piccola anta vetrata e scorse lentamente i titoli stipati senza molto ordine sui ripiani. Non si considerava un lettore assiduo, ma “almeno le basi”, come amava spronarli infastidito Dencing, il professore di letteratura della vecchia scuola, quelle poteva anche dire di averle. “L’Ulisse” di Joyce; “Guerra e pace” di Tolstoj; “I dolori del giovane Werther” di Goethe… Quest’ultima opera era stata una lettura adolescenziale, neanche troppo esaltante a quanto ricordava, eppure ripensò ancora a Dencing e alle parole che aveva utilizzato per introdurre il testo: “…all’epoca della pubblicazione, non solo assicurò al suo autore una fama immediata, ma suscitò un’ondata di suicidi emulativi in tutta Europa. L’effetto fu così potente che in diversi paesi le autorità vietarono la circolazione del libro”. Cercando di riportarne alla coscienza il contenuto, afferrò il libro e si sedette.
“Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds”.
Dopo aver posto per pochi istanti l’attenzione alla famosa iscrizione che campeggiava in facciata, scolpita sul lunghissimo architrave sostenuto dall’imponente colonnato corinzio innalzato agli inizi del ‘900, superò l’ampia scalinata e si ritrovò all’interno dell’immensa galleria.
Facendosi spazio senza troppa difficoltà tra la numerosa umanità che affollava relativamente quel luogo, individuò lo sportello giusto e si accodò alla fila.
L’attesa fu più breve del previsto. Dopo circa venti minuti venne già il suo turno.
«Buongiorno, come posso aiutarla?» chiese con tono di voce piatto l’uomo seduto dietro il sottile vetro antisfondamento.
«Ho un servizio Fermoposta attivo presso il vostro ufficio e vorrei sapere se c’è della posta in giacenza».
«Il suo documento, grazie».
Lo estrasse dalla tasca e lo porse all’operatore. Quest’ultimo, dopo aver letto il nome, osservò la foto e la confrontò con l’immagine che lo fissava a circa settanta centimetri dal suo volto.
«Un attimo e verifico» disse l’uomo, ruotando poi di 90° la sedia girevole, alzandosi con un piccolo saltello, facendo leva con le mani ben salde sui braccioli, e scomparendo dietro una porta metallica bianca, mimetizzata tra le numerose ante degli armadi a muro che formavano un’alta barriera alle sue spalle.
Meno di due minuti e lo vide ricomparire. Tra le mani una busta chiara con un piccolo francobollo multicolore annullato, collocato nell’angolo superiore destro.
«Solo questa busta. Prego, una firma qui» disse l’operatore facendo passare, nella stretta fessura tra piano e vetro, un documento che avrebbe attestato il ritiro della missiva da parte del destinatario.
«La penna è lì» aggiunse indicando con una mano aperta una biro legata con una sottile catena, realizzata con piccole sfere di plastica, al suo supporto.
Afferrò foglio e penna e firmò lentamente.
«Ecco, questa è sua. Grazie e buona giornata» disse, infine, l’addetto dopo aver recuperato il documento firmato e aver consegnato la lettera al cliente.
«Arrivederci» e si allontanò seguendo la striscia gialla sul pavimento che indicava il percorso migliore per allontanarsi dalla zona sportelli senza invadere la privacy altrui.
Quasi alla porta, si fermò. Osservò la lettera che ancora stringeva nella mano destra, quella calligrafia poco curata del mittente, il francobollo un po’ ruotato in senso orario e in parte non aderente al supporto. Poi la pose in tasca e uscì.
Caro sconosciuto
Non accartoccerò pagine per spedirti la copia in bella; sono certo che se dovessi sottostare a tutti i manierismi del cervello resterei imbrigliato soltanto nelle mie intenzioni senza portarle mai a termine. Dovrai tenerti questa lettera con tutte le correzioni e i cerchi eccentrici che per te saranno solo aloni di birra versata dallo sbrodolio della mia carne marcia allorché la leggerai. Se potessi ti invierei anche un’istantanea per farti vedere come mi sono ridotto, ma tu – come scrivi nel libro – non ammetti eccezioni: così come non vuoi conoscermi attraverso i caratteri filtrati da una tastiera, troveresti sicuramente da ridire anche dall’impressione di una foto che potresti trovare falsa. Eppure, non la scatterei per mostrarti la mia malattia; forse neanche mi esporrei, lasciando tutto il protagonismo alle lattine di birra accartocciate. Sì, cercherei di evidenziare le drammatiche pose plastiche che ho disseminato per la stanza come tanti soldatini caduti espletando il proprio dovere: evitare di farmi pensare ad un futuro da schifo schiavo. Sapessi la fatica: le mani non sono più le stesse; ci vuole tanta forza per stritolare un oggetto, anche quando ha finito di essere utile, ma chi decide quando non lo si è più? ma lo sforzo reiterato per piegare la latta non è nulla rispetto al peso di una penna nel cui stretto canale colmo d’inchiostro avrebbe difficoltà a diluirsi anche la pena raccolta in una sola cellula neuronale.
Questa è la tragedia di averne milioni.
L’uomo si differenzia dall’animale per quello che produce con le mani. Mio nonno mi diceva che questo paragone insensato a livello anatomico, nonché spirituale: “Gli animali ci sono superiori perché non hanno bisogno di credere in nulla!”, ci serve da lezione quando bisogna giudicare una persona perbene. “Non guardare il vestito, né le scarpe o il sorriso ammaliante mentre ti fissa benevolo, ascolta – sì ascolta – la presa della mano quando te la stringe. Il tatto è tutto!” quante risate col nonno, cazzo se mi manca. Nonno, mi nutrivo delle tue certezze e, oggi che sono seduto a questo tavolo, in una casa che non mi rispecchia, radicata in una città che non riconosco più perché ospita questo corpo cambiato irrimediabilmente, solo una cosa mi sento di poter garantire al mio caro sconosciuto: se tu fossi ancora qui non avrei bisogno di guardare le mani che tremano impotenti mentre cercano di aggrapparsi ad uno sconosciuto.
Tu non lo puoi sapere chi sono. O mi stavi aspettando? Posso però garantirti che riuscivo a tenermi ancorato a spuntoni di roccia sospesi nel vuoto con la stessa facilità con cui tu potresti spremere una lattina di birra. Divertente, vero. Campione nazionale lead di arrampicata sportiva dal 2004 al 2008 e bronzo ai giochi mondiali riservati agli sport non inseriti nei programmi olimpici. Pensa mi chiamavano Ace (S)Ventura, come Jim Carrey nel film omonimo ma con l’aggiunta della S, perché a differenza del comico avevo ‘salvato’ un procione su una scarpata con un grado di difficoltà al limite delle capacità umane. Quante risate con i colleghi, le stesse che un bel giorno mi avvisarono che qualcosa non andava come doveva. Andrew ci stava intrattenendo con uno dei suoi racconti davanti ai soliti cocktail analcolici: “Cosa hanno in comune Pinocchio e Topolino? Pinocchio è un buRATTINO e Topolino è un bugiardo! Perché? Ha 90 anni e ancora si presenta come Topo-lino e non come Topo-lone”. Ridemmo per la disperazione, come sempre. Solo che io, piegato in due, non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello, sfiancato da un dolore lancinante alla bocca dello stomaco. Boom! Tutto mi scoppiò in faccia come un petardo creduto spento e per questo molto più letale. Diagnosi: Tumore gastrico. La cura: chirurgia, chemioterapia e radioterapia con un tasso di sopravvivenza a 5 anni inferiore al 10%. Vaffanculo! Sono ancora qui dopo 3 anni e altre due operazioni. Perché non mi rispetta nemmeno la morte? Questo non dovrei scriverlo.
Cerco di immaginare la mano che regge il normografo che ha calcato a matita sul frontespizio del libro: Convincimi che hai bisogno di diventare protagonista. Di tuo pugno scrivimi di quello che non vorresti più essere. Cory Wright, General Delivery, James Farley Post Office 421 8th Ave, New York City, NY 10001.
L’indirizzo è quello dell’ufficio centrale della Grande Mela, quello vicino a Penn Station, per questo non mi faccio alcuna illusione sulle conseguenze di questa missiva del cazzo. Forse è uno scherzo di cattivo gusto o forse dietro c’è solo un disegno più grande che non riesco nemmeno ad immaginare, non è questa la base di tutti i complotti? Credo anche che non mi interessi saperlo; tutto quello che posso ricavare da te mio caro sconosciuto, l’ho già avuto con questo sfogo su carta.
R.I.P.
Fritz Carraldo
«Sei tu, vero?».
«Solo se tu vuoi che lo sia».
Non l’aspettava, era certo che non sarebbe mai arrivato quel giorno. Sì, aveva inviato quella lettera, ma era stato una sorta di gesto catartico e non una vera richiesta d’aiuto. Ma quel giorno arrivò avvolto in un pesante cappotto nero in twill e una sciarpa scura di lana che avvolgeva parte del viso.
«Entra».
L’accolse nella sala da pranzo. L’abitazione non era molto grande ma per un uomo solo era più che sufficiente.
«Il libro?» chiese l’ospite con la voce parzialmente filtrata dal caldo accessorio che copriva la bocca.
«È lì, sul tavolo» rispose Fritz indicando con un cenno del capo il piccolo volume.
«Quel quadro, è di troppo. Rimuovilo» disse dopo aver individuato il libro e aver osservato con cura la stanza.
Pochi erano i dettagli che la caratterizzavano: una cristalliera semivuota, una poltrona consunta, un tavolo tondo attorniato da sei sedie, non tutte figlie della stessa madre, e un mobile basso sovrastato da una vecchia TV con tubo catodico, oltre al dipinto.
Meccanicamente l’uomo esaudì il desiderio dell’ospite, staccando, con non poca difficoltà, una non riuscitissima copia del “Canestro di frutta” caravaggesco, poggiandolo in seguito a terra, accanto alla vetrina.
Gli occhi espressero una fugace soddisfazione, poi si posarono addosso all’uomo. Fritz Carraldo sopportò per pochi attimi quel peso, prima di abbassare lo sguardo e fissare la punta delle logore pantofole.
Era teso e l’ospite lo percepiva. Attese qualche minuto, voleva incrociare i suoi occhi, doveva incrociarli per avere una conferma sull’utilità della sua presenza.
Quattro giri di lancetta, poi i due sguardi si scontrarono.
«Sei pronto?».
«Credo di sì».
«Sei pronto?» chiese nuovamente.
«Sì».
“Tu ‘l sai, ché non ti fu per lei amara
in Utica la morte, ove lasciasti
la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara”
I versi vermigli campeggiavano sulla spoglia parete occidentale della sala da pranzo, interrotti in più punti dagli evidenti segni del tempo lasciati dal quadro che, fino a qualche minuto prima, era stato l’unico elemento estraneo ospitato da quel muro.
Nell’ambiente attiguo, la camera da letto, Fritz Carraldo disteso sul letto. Nudo. Il volto grondava sudore mentre dalla bocca affiorava un rantolio misto a convulsi colpi di tosse.
Le garze, che fino a poco tempo prima avevano abbracciato il suo torace e difeso dagli attacchi del mondo esterno le cicatrici ancora vive, erano appallottolate sul pavimento, non distanti dall’armadio in legno a due ante che, assieme al comodino a tre cassetti e al letto a una piazza e mezza, formava lo scarno corredo di quella stanza.
Sul suo corpo, ben visibili i segni che lo vedevano prossimo alla sconfitta in una battaglia impari. Aperti. Una mano ferma aveva divelto la barriera in Vicryl che divideva l’addome simmetricamente in verticale, dall’ombelico sin quasi allo sterno, e asimmetricamente in orizzontale, poco sopra la curva dell’evidente pancia. Il Fritz più intimo, osservato solamente, in poco più di quarant’anni, da un ristretto numero di chirurghi e dai rispettivi collaboratori di sala operatoria, era ora alla mercé di un pubblico invisibile.
Non distante dal monticello di garze giaceva un coltello da cucina a lama liscia e affilata. La sua punta sporca di sangue confessava il crimine compiuto.
Intanto la cassa toracica di Fritz si estendeva e si restringeva con un ritmo rapido e incostante, mentre il cuore pompava senza sosta il suo liquido vitale che trovava una via di fuga all’esterno del solito circuito.
«É…è… è g…, è gius…».
Tentò di abbozzare una frase, forse una domanda, ma lo sforzo fu sopraffatto dal dolore e le parole restarono per sempre incompiute.
Poi, d’un tratto, un ultimo, profondo e difficoltoso respiro, e il capo dell’uomo cadde sul lato destro.
Sulla soglia due occhi spettatori osservarono silenziosi la scena in paziente attesa del momento culmine. Soddisfatti, s’avvicinarono al corpo e constatarono l’interruzione dei ritmi vitali dell’uomo. Poi abbandonarono la stanza, si spostarono nella sala da pranzo e, recuperato il volume de “I dolori del giovane Werther”, si guardarono sfilare la tuta cerata imbrattata di sangue prima di guadagnare l’uscita.








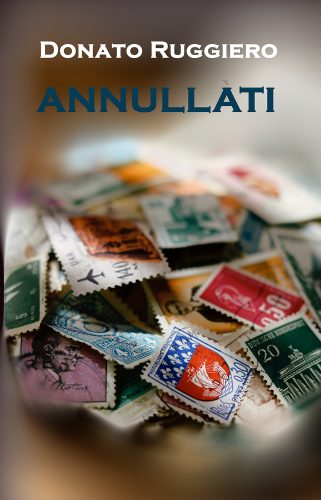
Lascia un commento