 «E tu, Noriyoshi, cosa vorresti fare da grande?».
«E tu, Noriyoshi, cosa vorresti fare da grande?».
«Pilotare uno di quelli» e il piccolo Noriyoshi Shibata, sette anni, indicò il cielo con la sua minuta mano aperta.
In alto, la sagoma di un Hiro H2H sorvolava uno degli sparuti villaggi di pescatori dell’isola di Rishiri nel nord del Giappone. Il velivolo era diretto verso le acque che dividevano il paese dall’Impero di Manciuria sulla costa opposta, per svolgere la sua attività di pattugliamento marittimo.
Lo stato fantoccio Manchukuo, o Impero di Manciuria, era nato meno di un mese prima, nel febbraio del 1932, come conseguenza dell’incidente di Mukden, l’attentato avvenuto il 18 settembre del ‘31 e che aveva danneggiato la ferrovia giapponese nei pressi di Mukden. L’esercito nipponico, esecutore materiale dell’atto terroristico, aveva accusato i terroristi cinesi e utilizzato l’evento come pretesto per mettere sotto l’influenza del Giappone la Manciuria, area già sotto il mirino da alcuni decenni.
Ma Noriyoshi, nel suo piccolo villaggio di pescatori, non era ancora a conoscenza della più recente storia del suo paese.
La vita di Noriyoshi e del suo piccolo villaggio proseguì senza affanni, pacifica, nonostante il cielo fosse solcato continuamente dall’aviazione giapponese che proseguiva incessante la sua espansione sulla sponda opposta.
E anche quando, nei primi mesi del 1933, ci fu l’operazione Nekka, con la conquista della provincia mongola di Rehe, e nel ‘36 la creazione dello stato fantoccio del Mengjiang nella Mongolia Interna, i pochi abitanti dell’isola di Rishiri, sempre consacrati alla loro attività di pesca, rimasero all’oscuro degli avvenimenti.
Ma poi arrivò il 1937 e l’isola di Rishiri e la famiglia di Noriyoshi furono investiti direttamente dagli avvenimenti che coinvolgevano il proprio Impero.
Era il 7 luglio e, presso il Ponte di Marco Polo, avvenne l’“incidente” che scatenò la Seconda guerra sino-giapponese. Forse inscenato alle truppe giapponesi dell’Armata del Kwantung, con propri militari travestiti da cinesi che avrebbero attaccato l’esercito del paese del Sol Levante, forse un attacco realmente realizzato dalla Cina, fatto sta che questo avvenimento diede il “lasciapassare” all’impero del Giappone per l’invasione dell’immenso stato asiatico.
E, meno di un mese dopo, aveva da poco compiuto i suoi primi diciotto anni, Yuzuku, fratello maggiore di Noriyoshi, ricevette la chiamata alle armi.
«Papà, tornerà Yuzuku?».
«Lo spero, figlio mio. Lo spero» rispose sincero l’uomo, poco più che quarantenne, impegnato nella riparazione di una delle piccole reti da pesca che, sapientemente tessuta a mano dai suoi bisnonni, svolgeva ancora il suo utile compito.
Azumamaro Shibata, tenendo stretto con le ginocchia parte del fondamentale strumento di sopravvivenza, sorrise al figlio lasciando cadere dalla bocca l’altro capo della rete tenuto teso per essere cucito con l’unica mano utile, la destra. La sinistra s’era sviluppata solo in minima parte, una malformazione genetica ne aveva lasciato crescere una sorta di moncone privo di dita che, nonostante la sorte avversa, era stata comunque una fortuna: gli aveva fatto evitare l’arruolamento nell’esercito.
E ora, sulla sua isola, seguendo la scia delle numerose generazioni che l’avevano preceduto, Azumamaro proseguiva felice la sua attività di pesca in compagnia della moglie Katsuko e dei quattro figli che la donna le aveva donato: Yuzuku, Noriyoshi e le gemelle Echiko e Maeko.
«Chiameranno anche me?» chiese ancora il bambino.
«Molto probabilmente sì, ma non devi pensarci adesso. Hai solo 12 anni».
«Ma perché dobbiamo obbedire alla chiamata dell’esercito?».
«Quando si nasce con nulla ci si accontenta di quel poco che, forse, la vita ci concederà. Quando, invece, si nasce con tanto, non si è mai sazi. E quando quel “tanto” si chiama potere, allora, il passo verso l’odiare chi ha tanto come te è breve. E quell’odio si chiama guerra e noi, figlio mio, siamo un’infinitesima parte di quel “tanto” che è nelle mani dell’Impero del Giappone».
Noriyoshi fissò il padre cercando di afferrare pienamente il concetto espresso con così semplici parole.
«Ma se siamo un’infinitesima parte del “tanto” che è nelle mani dell’Impero e lo stesso Impero ci manda a combattere e morire per conquistare altro “tanto”, significa che l’Impero non ama poi tanto il suo “tanto”» rispose poi saggiamente.
«Tra il potere e la guerra non c’è spazio per l’amore. E ora aiutami con questa rete».
Per oltre tre anni le notti seguirono i giorni e i giorni le notti. Noriyoshi e suo padre, costantemente, sfidavano il mare per trarne il cibo necessario per sfamare la propria famiglia e, quando fortunati, accumulare del pesce in più da vendere alla piccola imbarcazione che, una volta alla settimana, faceva da spola tra l’isola di Rishiri e quella di Hokkaido.
Ed ogni volta che Noriyoshi scrutava un aereo nel cielo tornare dalla costa cinese si chiedeva se in quel velivolo ci fosse anche suo fratello Yuzuku, ma ogni volta la risposta era negativa. Noriyoshi, però, ne era sicuro: suo fratello sarebbe tornato.
«Noriyoshi, presto! Vieni a casa!».
«Che succede?».
«Muoviti!» e, così come era apparsa sulla spiaggia, improvvisamente, correndo e urlando, Echiko aveva voltato repentinamente le spalle al fratello ed era fuggita verso casa lasciando la domanda di suo fratello nel vuoto.
Noriyoshi allora s’alzò di scatto, si assicurò che la rete tesa poco prima con suo padre, che al momento non era con lui, fosse ben salda ad uno degli sparuti scogli e s’incamminò a passo svelto verso casa.
«Fratello!».
La voce familiare lo colpì alla sprovvista una volta aperta la porta di casa. Il battello proveniente da Hokkaido, con il solito carico di riso e altri beni alimentari, aveva portato con sé anche Yuzuku.
I due s’abbracciarono e Noriyoshi pianse di gioia nel vedere di nuovo il viso dell’amato fratello maggiore.
E i cinque di casa Shibata trascorsero le ore seguenti e tempestarlo di domande.
Dopo la chiamata, Yuzuku raccontò di esser stato inviato alla base dell’aviazione militare di Chiran, nella penisola Satsuma, estremo sud del Giappone, e, dopo alcuni mesi di addestramento, aveva conseguito il brevetto di pilota realizzando quello che era il sogno di Noriyoshi. Poi aveva partecipato ad alcune delle battaglie sul suolo cinese dove, dopo la presa di Pechino, avvenuta l’8 agosto del 1937, e i successivi scontri che portarono l’Impero giapponese a mettere sotto la propria egida altri territori nemici, pagando un elevato prezzo di morte, nel 1940 il conflitto era entrato in una fase di stallo.
«E com’è pilotare un aereo?» chiese curioso Noriyoshi che pendeva dalle labbra del fratello.
«Provi una sensazione strana. Ti senti libero perché sei in alto, da solo, vedi tutto il mondo sotto di te, piccolissimo, ma provi anche tanta paura perché sai che non sei lassù solo per goderti l’emozione, ma sei in guerra e quel brivido piacevole scompare in un lampo» e gli occhi di Yuzuku s’abbassarono verso il pavimento mentre intorno a sé la famiglia abbracciò quel silenzio.
Intanto, qualcosa di grave stava accadendo dall’altra parte del mondo: nel 1939 la Germania aveva dato il via alla Seconda Guerra Mondiale. L’Impero del Giappone, che inizialmente si era dichiarato neutrale, impegnato com’era con il “problema cinese”, il 27 settembre 1940 sottoscrisse il patto tripartito con Germania e Italia, e, l’aprile successivo, con l’Unione Sovietica il Patto nippo-sovietico di non aggressione. In questo modo poté concentrarsi nuovamente sul dominio della Cina e dell’Asia orientale.
E, alla luce di tutto ciò, quel ritorno a casa di Yuzuku si trasformò in una gioia fugace poiché, in vista della missione in Indocina, fu richiamato alle armi. E nel luglio del 1941 il Giappone procedeva con l’invasione.
La nuova mossa giapponese accentuò, però, gli attriti internazionali e gli USA attuarono l’embargo dei prodotti petroliferi e ferrosi, fondamentali per l’impero del Sol Levante, giungendo ad un punto di rottura. Ora il Giappone aveva un nemico in più.
«Dove stiamo andando?».
«Non lo so».
Dopo esser tornato alla base di Chiran, Yuzuku e molti altri elementi dell’aviazione, provenienti da tutte le basi dell’Impero, furono radunati e spediti, in tutta segretezza, verso la baia di Tankan nelle isole Curili, nel nord del Giappone. Qui li attendevano le forze navali comandate da Isoruku Yamamoto, pronte per l’attuazione di un piano messo a punto dallo stesso: l’attacco alla base navale americana di Pearl Harbor.
Dopo esser stato assegnato alla portaerei Kaga ed essersi visto affidare un bombardiere Aichi D3A armato con bombe da 249 kg, Yuzuku fu messo al corrente solamente della sua parte nelle operazioni. Il pilota poté solo immaginare l’eccezionale portata del piano, ma solo una volta in volo ne afferrò la pericolosità.
Dopo la prima ondata di attacchi che colpì seriamente le navi e gli aerei statunitensi, Egusa, capitano di corvetta della portaerei Soryu, e Makino, tenente di vascello della portaerei Kaga, guidarono i propri uomini nella seconda ondata offensiva. Colpire gli incrociatori e le portaerei ancora attive, questo l’obiettivo assegnato ai piloti degli Aichi D3A.
Mancavano ancora oltre trenta miglia dall’isola di Oahu, nell’arcipelago delle Hawaii, posto strategico in cui gli USA avevano installato la base navale di Pearl Harbor, quando continui boati entrarono prepotentemente nelle orecchie di Yuzuku, seguite, pochi secondi dopo, dalla visione di lame di fuoco e fumo che si innalzavano dalle imbarcazioni che iniziavano a distinguersi in lontananza.
Non ebbe il tempo di realizzare quanto stesse accadendo poiché il suo velivolo fu ben presto sull’obiettivo. Un incrociatore, il Raleigh, fermo, con pochi danni visibili. Appena gli fu sopra sganciò la bomba e si allontanò fulmineo.
Ma una serie di rumori in rapida sequenza, accompagnata da un forte tremolio del velivolo fecero sobbalzare Yuzuku. Il mezzo navale aveva risposto all’attacco con una raffica di mitra e l’aereo era stato colpito.
Sperò fosse un danno di poca importanza ma quando iniziò a perdere quota capì che la fine sarebbe stata imminente.
“Addio fratello mio, addio miei cari”.
Riuscì, con una manovra disperata, a direzionare l’aereo nuovamente verso il Raleigh e, individuato il mitragliatore che ancora sparava verso di lui, lanciò l’aereo in picchiata.
Una nuova lama di fuoco s’aggiunse alle numerose altre.
«Che succede? Perché piangete?».
Il sole era scomparso ad Occidente da quasi un’ora quando Noriyoshi e suo padre rincasarono. Ad attenderli le tre figure femminili di casa Shibata in lacrime.
«È giunta questa» disse singhiozzando la mamma allungando la lettera verso Azumamaro.
«È con immenso dolore che l’imperatore Hirohito accoglie tra le sue braccia il valente figlio Yuzuku Azumamaro, caduto con onore durante lo svolgimento della sua onorevole opera militare» lesse ad alta voce l’uomo.
Poi la lettera volò sul pavimento.
Noriyoshi non disse nulla, corse immediatamente in camera, raccolse tutte le sue cose e, dopo aver scritto poche parole di commiato su di un pezzo di carta, si calò dalla finestra dirigendosi verso il porticciolo.
L’imbarcazione che collegava l’isola di Rishiri e quella di Hokkaido, e che, oltre al cibo, recapitava anche la posta, solitamente restava in porto la notte per ripartire la mattina seguente con il nuovo carico. Il ragazzo la trovò lì. Vi si avvicinò e, senza farsi vedere, salì a bordo nascondendosi nella stiva.
«Scusi, sa dov’è la più vicina base aerea militare?».
«No, figliolo».
Sceso di soppiatto dalla barca al porto di Wakkanai, Noriyoshi si mosse titubante in quello che era un posto totalmente diverso dai luoghi in cui aveva trascorso i primi sedici anni di vita.
Poi, trovato un po’ di coraggio, iniziò a fare domande ai passanti.
«Scusi, sa dov’è la più vicina base aerea militare?».
«Certo. Ma perché ti interessa?».
Un ometto dai capelli grigi fu il primo a raccogliere positivamente il suo quesito.
«Perché voglio arruolarmi».
L’uomo lo fissò per coglierne l’età. Poi con un sorriso fiero disse: «Base aerea di Chitose, nel sud di Hokkaido».
«Grazie. E come ci arrivo?».
«In treno».
«Ma non ho soldi per il biglietto».
«Seguimi».
E l’uomo, a passo lento, lo accompagnò verso la vicina caserma militare della città. Durante il tragitto provò a comprendere le sue motivazioni ma Noriyoshi non si aprì molto.
«Sono qui per fare il pilota».
Oltrepassata la soglia del grande edificio, dopo aver ringraziato e congedato l’accompagnatore, Noriyoshi individuò il primo uomo in divisa e s’approssimò.
«Su, ragazzo, lasciami lavorare».
«Non scherzo. Voglio arruolarmi e fare il pilota d’aerei militari».
L’uomo, poco più alto del ragazzo, nella sua uniforme color cachi, lo squadrò da capo a piedi.
«Quanti anni hai?».
«Sedici».
«Vieni».
E i due scomparvero dietro una porta che dava accesso al dedalo di uffici che componevano la caserma.
Fu un periodo di duro addestramento per Noriyoshi. Dopo i primi sei mesi trascorsi come soldato semplice presso la caserma di Wakkanai, ci fu la grande opportunità di trasferirsi presso la base aerea di Chitose. L’esercito imperiale necessitava sempre più di forze fresche per le sue mire espansionistiche nel Pacifico, soprattutto ora, con la presenza degli USA nell’area divenuta decisamente più palpabile dopo l’incursione aerea su Tokyo del 18 aprile 1942.
L’11 aprile 1943, per la prima volta, Noriyoshi si alzò in volo per eseguire un ordine militare: l’attacco alle baie della Nuova Guinea. E se la missione personale, colpire le navi statunitensi con il suo bombardiere Mitsubishi G4M, fu compiuta, quella generale fu un disastro. L’Impero giapponese iniziò a sgretolarsi.
Le offensive su vari fronti proseguirono e il pilota fu sempre più coinvolto nelle operazioni, partecipando, tra gli altri, anche agli attacchi in Birmania e in Cina.
Poi, fu la volta di traferirsi verso la base dell’aviazione militare di Chiran, nella penisola Satsuma.
«Tu lo conoscevi Yuzuku Shibata?».
«Mai sentito».
Giunto nella nuova base, Noriyoshi iniziò a chiedere informazioni su suo fratello. Voleva sapere come era morto e, soprattutto, per mano di chi.
Provò per alcuni giorni, ponendo la solita domanda ai suoi nuovi compagni ma, quasi tutti, facevano parte delle nuove leve e, ovviamente, non potevano aver familiarità con piloti scomparsi tre anni prima.
«Chiedi al tenente Terauchi. Lui è qui da oltre dieci anni».
Fu questo suggerimento ad aprirgli un nuovo spiraglio.
Dopo averlo individuato ed esser riuscito ad avvicinarlo, Noriyoshi andrò dritto al punto.
«Tenente, posso farle una domanda? Lei lo conosceva Yuzuku Shibata?».
«Forse».
«È stato un pilota e ha prestato servizio qui. È morto nel 1941».
«1941?».
«Sì».
L’uomo in divisa lo fissò dritto negli occhi. 1941, poteva riferirsi soltanto ad un attacco.
«Pearl Harbor. Tuo fratello è un eroe».
«Com’è morto?» lo incalzò Noriyoshi.
«Durante l’attacco aereo ai nemici statunitensi riuscì a colpire una delle loro navi ma, sfortunatamente, fu colpito a sua volta. Allora, da eroe, si lanciò con il proprio velivolo sul nemico danneggiandolo gravemente. Un grandioso gesto per il nostro Impero».
«Grazie» e andò via.
Le forze dell’Impero nipponico, intanto, stavano diminuendo gradualmente e i territori conquistati persi costantemente. Nel marasma generale, una delle ultime carte da giocare, facendo affidamento all’orgoglio “samurai”, fu creata ufficialmente il 20 ottobre 1944: l’Unità d’attacco Shinu, il reparto kamikaze.
Noriyoshi fu tra i primi ad accettare l’incarico, conscio delle conseguenze.
Assegnato al gruppo Scikiscima, prese parte alla prima missione kamikaze giapponese nel Pacifico. La partenza fu preceduta dalla cerimonia in cui, ogni pilota, ricevette dall’ufficiale la spada wakizashi, bevendo poi un bicchierino di saké voltandosi in direzione del palazzo imperiale.
Sto per sacrificare la mia vita per servire l’Imperatore, ma penso che questo atto fedele sia equivalente all’atto finale di rispettare voi, miei genitori. E per vendicare te, fratello mio.
Redatte con difficoltà le sue ultime parole, raggiunse gli altri militari in attesa della partenza verso la base di Mabalacat nelle Filippine.
Qui, il 25 ottobre 1944, preso possesso di un Caccia Zero, attese gli ordini. A lui, ed altri quattro piloti, toccava il secondo attacco.
Scrutò il cielo, poi salì a bordo e decollò. L’obiettivo non era molto distante e lo individuò presto: la portaerei di scorta statunitense USS St. Lo.
“Fratello mio, ci rivedremo presto”.
Poi puntò l’obiettivo, sganciò la bomba a colpo sicuro e, infine, si lanciò in picchiata verso la nave.
Di Noriyoshi rimase solo il gran boato dovuto all’impatto del suo aereo e le lingue di fuoco risultato dell’esplosione del deposito bombe della portaerei.
(pubblicato nell’antologia “Cinquantatré vedute del Giappone” – Idrovolante Edizioni, 2020)








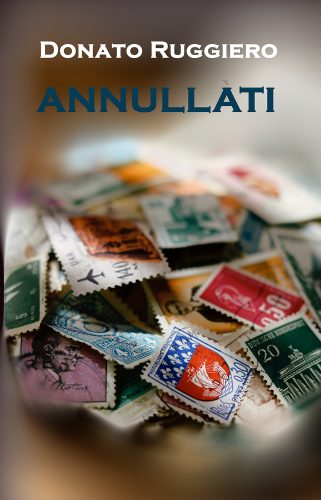
Lascia un commento