 Un caro benvenuto al bassista e compositore Daniele Sollo.
Un caro benvenuto al bassista e compositore Daniele Sollo.
D.S.: Grazie mille.
Iniziamo la nostra chiacchierata dalle origini. Quali sono i tuoi primissimi passi nel mondo della musica e i primi “amori”? E quando sboccia quello per il basso?
D.S.: Ho dato “i primi passi” approcciando ad una piccola tastiera che comprarono i miei genitori: su questa cominciai – a circa 7 anni – a strimpellare “Für Elise” con il solo dito indice della mano destra… dopodiché ho suonato le tastiere in piccole formazioni quando ero adolescente. Suonavo, prevalentemente, cover di vari artisti e band pop e rock.
All’inizio degli anni ’90 scoppia l’amore travolgente per il basso. Erano gli anni in cui impazzava l’acid jazz, un genere musicale che, tra l’altro, permette al basso di esprimersi in maniera totalmente differente dai generi musicali che avevo suonato in precedenza. Sicché comincio a studiare lo strumento (con il mio maestro e grande amico, Giuseppe Brandi), entrando in un mondo nuovo, fatto di suoni ed espressività diversi. Mi avvicino, per motivi didattici, a generi quali il jazz (in ogni sua forma) e la musica classica. In questo periodo, conosco compositori come Miles Davis, Frank Zappa, Pat Metheny e tanti, tanti altri musicisti che entreranno a far parte del mio “background”. Conosco quel meraviglioso strumento che è il basso fretless, che è uno degli strumenti che adopero sia nelle mie composizioni, sia in altri contesti musicali.
Le tue prime pubblicazioni ufficiali sono i due singoli “11-IX-1683” e “Turn left”, usciti nel 2014 (che troveremo anche nell’album “Order and DisOrder” del 2020). Mi parli un po’ di loro? Come nascono e quanto differiscono dalle versioni del disco?
D.S.: La pubblicazione di questi singoli è stata un esperimento. Ero nel periodo in cui si stava mettendo a posto il resto del materiale da cui sarebbero nati gli altri brani di “Order and DisOrder”, e avevo l’esigenza di uscire con delle mie pubblicazioni (a quel tempo, avevo già lavorato come bassista per Luca Scherani). Sicché, pubblicai i brani citati cercando di capire quale fosse l’accoglienza del pubblico. Infatti, i due brani furono pubblicati in solo formato digitale. Sostanzialmente, negli arrangiamenti sono pressoché identici; si è lavorato essenzialmente sulla pasta sonora, in modo da renderli omogenei al resto dei brani dell’album.
Nello stesso anno partecipi anche alla raccolta “Echoes of Secrets (A Pink Floyd tribute)” della Mellow Records, suonando il basso, come detto poc’anzi, nella versione di Luca Scherani del brano “See Emily play”. Che ricordo hai dell’esperienza? È in questo momento che entra nella tua vita la “banda di Zuffanti & Co.”?
D.S.: È stata un’esperienza molto interessante e divertente. Grazie a Luca, per la prima volta entro in “contatto diretto” con il Progressive, un genere musicale che – fino ad allora – mi ero limitato a goderne con il solo ascolto. Devi sapere che sono curioso per natura e sono sempre stato attratto per ciò che è nuovo. Quindi, ho approcciato ad un mondo nuovo – quello del Prog – con il candore del bambino che scopre cose a lui del tutto nuove. Mi sono lanciato in questa esperienza (il brano citato è stato, probabilmente, il primo brano Progressive che ho registrato). Inoltre, proprio grazie a Luca (una delle mie più belle “scoperte” fatte grazie ai social network) sono stato invitato a prendere parte alle registrazioni di un album degli Höstsonaten.
Il 2016 ti vede, appunto, partecipare agli album “Symphony n.1: Cupid & Psyche” degli Höstsonaten e “Il Cerchio Medianico” di Stefano Agnini. Ti va di raccontarmi come si sono svolte le cose, dal primo contatto con i “padroni di casa” all’uscita dei lavori?
D.S.: Come detto, ho conosciuto Fabio Zuffanti grazie a Luca Scherani. Sia Fabio che Luca furono entusiasti del risultato ottenuto con la registrazione di “See Emily play” e, quindi, decisero di mandarmi le parti di basso elettrico per “Symphony n.1: Cupid & Psyche”. È stata, anche questa, un’esperienza nuova: un confronto diretto con il rock sinfonico, un genere nel quale il basso elettrico “sta dietro” rispetto agli altri strumenti. Diciamo che, all’inizio, questa cosa si è posta a me come una sorta di “problema”, in quanto, il mio modo di suonare è un po’ anomalo… nel senso, che spesso viene definito “poco bassistico” (tante volte mi sono sentito dire: “Daniele, in queste parti suoni decisamente troppo…”). Però, come detto, mi piacciono “le sfide” e mi sono cimentato in questa nuova, eccitante, esperienza. Le registrazioni durarono poco: avevo preparato tutti i brani in un arco di tempo piuttosto breve e, nel giro di mezza giornata, portai a compimento le registrazioni. Il risultato è quello che potete ascoltare nei pezzi dell’album.
E nel 2020 giunge finalmente la tua occasione per un album solista: “Order and DisOrder”. Mi narri la sua genesi?
D.S.: Già dai primi anni 2000 avevo un bel po’ di materiale da utilizzare per quelle che sarebbero diventate le composizioni presenti in “Order and DisOrder”. Si trattava di arrangiamenti approntati usando diversi software di composizione musicale. Questo materiale veniva fuori a seguito di una serie di riflessioni su diversi argomenti, in primo luogo l’opera dello scienziato Wilhelm Reich (su questa importante persona, già Kate Bush aveva composto il brano “Cloudbusting”). Reich fu innanzitutto uno psichiatra, che raccolse gran parte dell’eredità teorica di Freud (fu il suo più brillante allievo) andando avanti nella ricerca e trovando “l’origine biologica” di quello che in genere chiamiamo “bene” e “male”. Inoltre, diede vita a numerosi studi – distrutti dal Governo degli USA negli anni ’50 (la storia è narrata nel pezzo della Bush citato) – che dimostravano palesemente come avvengono i processi di creazione e distruzione della materia. Tutto questo mi portò ad un’ampia riflessione su temi quali: l’amore, l’odio, la vita, la morte, il bene, il male; ed ebbi l’idea di sintetizzare tutto questo con il titolo “Order and DisOrder”. La grafia del titolo intende mettere in evidenza proprio il legame indissolubile fra i vari “opposti” di cui parlavo prima: senza l’uno, non può esistere l’altro, e dall’uno nasce l’altro secondo uno schema continuo (un po’ come avevano già teorizzato i Cinesi con il concetto di Yin e Yang, solo che Reich aveva dato una valenza scientifica a tutto questo).
Dopo aver messo tutto in tavola, mi metto alla ricerca dei musicisti che avrebbero potuto partecipare al mio progetto. Sicché, grazie a Facebook (i social, fortuna vuole, non sono solo un coacervo di frustrati e “leoni da tastiera”…) conosco Domenico Cataldo, che resta affascinato dal mio progetto e con il quale do inizio ad un rapporto di collaborazione che porterà alla stesura definitiva degli arrangiamenti dei vari pezzi dell’album. A lui si aggiungeranno tutti gli altri musicisti. È stato un lavoro lungo e faticoso, iniziato nel 2014, durato circa sei anni. Però, come si dice: “Per fare le cose per bene ci vuole tempo”.
Il tuo basso, ovviamente “si sente”, ma l’album è un riuscito mix di atmosfere cangianti come, ad esempio, quelle aggressive di “11-IX-1683” e “Turn left” o quelle evocative di “In my arms” e “Pavane in F# Minor”. Dove nasce, dunque, il “disordine” nella tua scrittura e come diventa “ordine”?
D.S.: Partendo da ciò che ho descritto sopra, avevo l’intenzione di rendere il tutto in musica, ovviamente. Quindi, l’idea base era quella di creare delle composizioni assai diverse fra loro stilisticamente (questo fa parte, tra l’altro, della lezione che ho appreso da Frank Zappa), ma che fossero legate “indissolubilmente” fra loro. Il problema è stato risolto rendendo omogenea la pasta sonora dell’intero album e “mettendo in scena” delle storie, dei “flashback” il cui filo rosso fosse proprio l’insieme dei concetti di cui ho parlato prima. Pertanto, nei vari brani si parla (attraverso delle immagini, delle storie) di amore, di morte, di vita, ecc. La risultante è una sorta di viaggio, quasi come se l’ascoltatore facesse un viaggio spazio-temporale (le scene rappresentate – si intuisce – che hanno diverse collocazioni spazio-temporali) che ha come costante il pensiero di Reich.
In “Order and DisOrder” ti avvali della collaborazione di un nutrito gruppo di artisti. Immagino sia stato naturale coinvolgere, in primis, Scherani, Zuffanti e Agnini nel tuo lavoro. Ma com’è stato “capovolgere” i ruoli? E qual è stato il loro effettivo apporto nella riuscita del lavoro?
D.S.: Quando mi fanno questa domanda, rispondo sempre con una metafora. Mi sono sentito come un regista che, nella realizzazione del suo film, ha chiamato a recitare un cast “all-star”. In genere, in queste situazioni, il regista fa poco: gli attori vanno avanti da soli senza che debbano essere diretti in senso stretto.
In effetti, ho agito proprio così: ho dato le parti ai vari musicisti coinvolti dando loro carta bianca. Ho chiesto loro di calarsi nelle atmosfere evocate nei brani e di andare avanti: il resto lo hanno fatto tutto loro. Se è vero che c’è stato un grosso lavoro a monte – per quanto riguarda la composizione e gli arrangiamenti –, un grande lavoro di interpretazione è stato fatto dai musicisti, cosa, questa, risultata decisiva in termini di risultato finale.
Oltre ai tre musicisti già menzionati, nel tuo album troviamo davvero una squadra di “aiutanti” invidiabile (Alessandro Corvaglia, Jason Rubenstein, Domenico Cataldo, Samuele Dotti, Maurizio Berti e Valerio Lucantoni). Come nascono le singole collaborazioni e come riesci, in pratica, a “convogliare” tutte le loro qualità e le loro energie nell’album?
D.S.: Rubenstein è stata un’altra interessante scoperta avvenuta tramite i social network. Avevo ascoltato diversi lavori realizzati da lui e l’ho reputato adatto a portare avanti uno dei brani: “Turn left”.
Samuele e Maurizio avevano già suonato con Domenico. Quindi, mi sono fidato dei consigli di quest’ultimo, e devo dire, la fiducia è stata davvero ben ripagata. Alessandro l’ho conosciuto di persona in occasione dei concerti con gli Höstsonaten. È una persona straordinaria, che si è calata appieno nel lavoro e che ha dato vita a delle performance stupende. Valerio è un talentuoso musicista, a breve sarà un punto di riferimento nel panorama dei batteristi italiani (e non). Per lui, come per tutti, vale il discorso fatto prima: ho fornito le linee guida del brano raccomandando loro di essere sensibili alle atmosfere dell’album. Il tutto è avvenuto in maniera naturale, e questo denota la grande sensibilità e talento dei musicisti che hanno partecipato.
Qualche ultima domanda su “Order and DisOrder”: dall’uscita dei primi singoli alla pubblicazione dell’album passano sei anni. Come mai questo divario temporale? Ti va di spendere qualche parola anche sulla copertina dell’album? E, infine, com’è stato accolto il tuo lavoro da pubblico e critica?
D.S.: In effetti, i tempi erano maturi per uscire con un album mio. Era il periodo in cui era uscito “Symphony n.1: Cupid & Psyche” ed era giusto proseguire sulla scia della pubblicazione degli Höstsonaten. Però non tutti i brani erano stati ultimati… diciamo che ho voluto fare un esperimento; ho cercato, come detto prima, di capire quali potessero essere le risposte da parte del pubblico. Inoltre, tutto l’album – per mia scelta – è stato interamente autoprodotto. Ciò ha comportato che la lavorazione subisse dei forti ritardi anche perché non essendo un musicista “professionista”, tante mie energie sono state impegnate in altri contesti. Ad ogni modo, ci sono state delle risposte positive: alcune webzine hanno dato spazio ai brani. Certamente, era un “parto a metà” e, quindi, l’eco della pubblicazione dei singoli (usciti peraltro in solo formato digitale) non è stata uguale a quella relativa a “Order and DisOrder”.
L’album, infatti, ha ottenuto davvero un buon successo finora, sia in termini di vendite sia in termini di accoglienza. Nonostante abbia suonato con artisti importanti della scena Prog internazionale, sono comunque un “debuttante”. Commisurando l’accoglienza ottenuta con questo “status”, devo dire che sono ampiamente soddisfatto. La stampa italiana ed estera ha scritto parole di elogio importanti su me e sul lavoro pubblicato. Inoltre, tieni conto che “Order and DisOrder” è uscito in un periodo molto strano, durante il quale sono stati pubblicati tantissimi lavori realizzati anche da tanti nomi importanti.
La copertina è stata realizzata da un mio vecchio compagno di liceo: Fabio D’Auria, uno dei più importanti fumettisti italiani (i Tex che leggete ora sono opera sua). La copertina è stata il frutto della libera elaborazione dell’autore sull’album. Una volta ascoltato i brani, Fabio ha realizzato di getto la copertina.
Cambiando discorso, il mondo del web e dei social è ormai parte integrante, forse preponderante, delle nostre vite, in generale, e della musica, in particolare. Quali sono i pro e i contro di questa “civiltà 2.0” secondo il tuo punto di vista per chi fa musica?
D.S.: È assodato ormai che Internet sia un mezzo, che può essere sfruttato al meglio o per dar luogo a delle storture abominevoli. Quest’ultime possiamo vederle e leggerle, appunto, sui vari social.
Riguardo il mondo della musica, ad internet va dato sicuramente il merito di aver dato voce ad artisti che sarebbero morti ancor prima di nascere. Io stesso, in un certo senso, sono una “creatura” di Facebook: le mie esperienze più importanti sono nate proprio da incontri nel social.
Anche YouTube – anzi, soprattutto YouTube – è stato il punto di partenza per tanti artisti. Al contempo, però, molte persone che figurano nel “tubo” – lo dico senza voler fare polemica – danno vita a delle esibizioni che spesso non hanno nulla a che vedere con la musica. Volendo fare un paragone, è la stessa differenza che corre fra gli Harlem Globetrotters e una grande squadra della NBA. I primi, sicuramente sono dei grandi atleti, ma non giocano a basket… Alla stessa maniera, su YouTube – specie negli ultimi dieci anni – è tutto un pullulare di “fenomeni”, “grandi musicisti”, “bambini/e prodigio”, ecc. Per carità, nulla di male; però essere musicisti e fare musica è un’altra cosa. Quello che si vede nella maggioranza dei casi è puro intrattenimento. Purtroppo, casi di questo tipo sono quelli che richiamano più attenzione: le visualizzazioni salgono vertiginosamente, magari si finisce per fare tutto questo “per mestiere” tagliando la visibilità a chi vorrebbe emergere e non ha la possibilità di farlo. Un interessante fenomeno che va sempre diffondendosi è quello dei costruttori di strumenti musicali che arruolano il “fenomeno” di turno: nelle varie esposizioni trovi sempre più spesso personaggi nati nei social network e sempre meno musicisti. Ti sembra “normale” che, su Instagram, una bella e graziosa ragazza che ama imbracciare il basso in pose ammiccanti abbia circa 5000 followers (con tanto di “repost” da parte delle riviste specializzate!), mentre un grande musicista come Pippo Matino “soltanto” più di 1000?
Purtroppo, tutto questo è la testimonianza del fatto che la musica è un prodotto commerciale, un bene di consumo, ed è un meccanismo che ci è sfuggito di mano, e tanti ne pagano le conseguenze.
E quali sono le difficoltà oggettive che rendono faticosa, al giorno d’oggi, la promozione della propria musica tali da ritrovarsi, ad esempio, quasi “obbligati” a ricorrere all’autoproduzione?
D.S.: La musica obbedisce a logiche di mercato ben precise, lo diciamo tutti da tanti anni. Anche la cosiddetta “musica di nicchia”. Non a caso si parla di “produzioni musicali”. Tutto quello che noi creiamo sono – a tutti gli effetti – un prodotto che va pubblicizzato, immesso nei canali giusti e venduto. Di per sé non vi è nulla di strano, del resto un produttore è un imprenditore che investe denaro ed è logico che abbia il suo ritorno. Negli ultimi anni, anche diversi produttori “di nicchia” hanno assunto un atteggiamento diverso. Molti preferiscono fare affidamento sul “nome sicuro”, tanto è facile venderlo. Spesso si assiste ai casi in cui i discografici sono consapevoli di non poter vendere un prodotto e, loro malgrado, vi rinunciano “girando” la proposta ad altri colleghi. Tutto questo, unito alla mercificazione della musica, ha fatto sì che tanto artisti abbiano fatto ricorso all’autoproduzione dei propri lavori.
Ad ogni modo, autoprodurre non è sinonimo di garanzia di visibilità. Dopo essere riusciti, con tanti sacrifici, ad autoprodurre il proprio lavoro bisogna lavorare tanto per potersi immettere nei canali giusti. Molti lavori – anche validi – “muoiono” proprio in questa fase.
Qual è la tua opinione sulla scena progressiva italiana attuale? C’è modo di confrontarsi, collaborare e crescere con altre giovani e interessanti realtà? E ci sono abbastanza spazi per proporre la propria musica dal vivo?
D.S.: La scena musicale è un ambiente ostico, a prescindere dai generi musicali. In particolare, in Italia si vive, purtroppo, in uno stato di “provincialismo cronico”. Provo a spiegarmi meglio raccontando un aneddoto.
Diversi anni fa – se non erro a metà anni ’90 – Herbie Hancock tenne un concerto al Pomigliano Jazz Festival. Dopo aver suonato, si intrattenne con i giornalisti, musicisti e alcuni del pubblico dietro il palco. Ebbene, come mi raccontò un amico che era proprio lì, il grande pianista parlava con tutti senza fare distinzione, con grande senso di umiltà… e stiamo parlando di Hancock… In Italia, nella stragrande maggioranza dei casi, molti musicisti si sentono “migliori degli altri”, si sentono in diritto di criticare (in malo modo e in maniera non costruttiva), “demolire”, “rottamare”, stroncare a priori o, al contrario, osannare. Nei social leggo, spesso e purtroppo, delle cose da far accapponare la pelle. Tantissimi colleghi e – presunti – addetti ai lavori hanno il brutto difetto di non prendersi troppo sul serio, e questo è il più grande difetto che si riscontra nel nostro Paese.
Premesso questo, posso dire – in base alle mie esperienze – che il Progressive, in Italia, ha delle caratteristiche diverse a seconda del territorio, sia per quanto riguarda il modo di concepirlo, sia per quanto riguarda l’accoglienza da parte del pubblico. Per esempio, a Napoli – fino a quando ci ho vissuto – si viveva una realtà che tendeva a snobbare il Progressive Rock, associandolo ad un solo linguaggio: il Prog Metal. Sicché era considerato “roba da metallari frustrati che hanno solo voglia di dar sfoggio delle loro abilità tecniche”. Il più delle volte, tali considerazioni venivano da alcuni musicisti, che, nell’immaginario collettivo diffuso grazie a certe esperienze culturali e musicali tipiche della città partenopea, sono da sempre considerati gli “Artisti”, quelli chiusi nella torre d’avorio e dalla quale dispensano perle ai porci. Negli ultimi anni sembrerebbe che le cose siano leggermente cambiate: vedo sempre più la comparsa in pubblico di Lino Vairetti, degli Osanna, di Jenny Sorrenti, e questo è un bene.
A Genova ho trovato un ambiente diverso, fatto di confronto costruttivo. Musicalmente “provengo” da un genere diverso dal Progressive, ma subito mi sono addentrato. A Genova, la tanto citata “contaminazione musicale” non è superficiale, ma una realtà concreta. Le mie esperienze in quella città mi hanno fatto vedere come il Progressive sia un linguaggio musicale in continua evoluzione, non vincolato a schemi rigidi associati ai linguaggi musicali di cinquant’anni fa. Non è un caso, secondo me, che giovani artisti – provenienti da diverse zone d’Italia – che suonano Progressive giungano a Genova per iniziare il proprio percorso artistico.
Purtroppo, gli spazi in cui proporre la propria musica sono sempre pochi. Questa situazione, come ormai è noto, è figlia anche della mancanza di “appeal” del genere. Fa molta più eco un festival jazz – se c’è il nome di punta, meglio ancora – che un omologo Prog, e questo è dimostrato dal numero maggiore di concerti e manifestazioni afferenti al primo genere. Bisogna, quindi, affidarsi ai pochi volenterosi che – con tenacia – combattono contro questo fenomeno e mettono a disposizione i propri spazi per permettere ai musicisti “prog” di potersi esprimere per la gioia del pubblico.
Rimanendo in ambito concerti, com’è Daniele Sollo sul palco?
D.S.: Beh, è una domanda a cui dovrebbe rispondere chi mi vede suonare… A parte gli scherzi, in realtà, non ho l’esatta percezione di me stesso, poiché tendo sempre a “fondermi” con lo strumento e la musica che vien fuori. Diciamo che sono sempre immerso nel “mood” del brano che eseguo e quello che si vede è il risultato di questo.
“Addentrandoci”, invece, nella tua vita privata, ci sono altre attività artistiche che svolgi nella vita quotidiana?
D.S.: In un certo senso, mi occupo sempre di arte. Sono, infatti, docente di “Disegno e Storia dell’arte” presso la Scuola Secondaria di II Grado. Tante questioni che sono alla base delle mie composizioni sono figlie di riflessioni che faccio da tempo nel campo delle arti. In particolare, l’emergere del mondo interiore nelle opere d’arte, come esso si manifesta e come ogni artista compie questa azione.
E parlando, invece, di gusti musicali, di background personale (in fatto di ascolti), ti va di confessare il tuo “podio” di preferenze personali?
D.S.: Più che podio, faccio una carrellata (la più sintetica possibile) di quello da cui ho attinto (e da cui attingo ancora): Pat Metheny, Frank Zappa, Miles Davis, David Bowie, Level 42, Casiopea, Prism, Incognito, Porcupine Tree, Dexter Wansel, Narada M. Walden, Perigeo, Area, Franco Battiato. Mi fermo qui, ma potrei continuare per un bel po’.
Restando ancora un po’ con i fari puntati su di te, c’è un libro, uno scrittore o un’artista (in qualsiasi campo) che ami e di cui consiglieresti di approfondirne la conoscenza a chi sta ora leggendo questa intervista?
D.S.: Sicuramente Wilhelm Reich, nonostante non sia stato un artista.
Ti va di descrivere a parole il tuo amore per il basso e il tuo rapporto quotidiano con esso?
D.S.: Beh, io considero lo strumento una sorta di estensione del mio corpo, una sorta di “medium” che mi consente di dialogare con gli altri attraverso la musica. Come tantissimi musicisti, ho l’esigenza fisica di dover avere un contatto con lo strumento, davvero non mi riesce di stare due giorni di fila senza metterci le mani sopra… Ancora oggi, dedico almeno un’ora allo studio, improvvisando la routine di studio al momento e alternando i miei due strumenti.
Chi sono i “mostri sacri” del basso cui ti ispiri o che ti hanno dato “qualcosa di tangibile” lungo il tuo percorso artistico?
D.S.: Beh, i nomi da citare sono davvero troppi. Però, posso dirti che le mie maggiori fonti d’ispirazione non sono stati bassisti. Spesso, consapevolmente o no, ho finito con il riproporre schemi presi direttamente da chitarristi, pianisti, violinisti, ecc.
Come tutti, ho conosciuto il mondo del basso (o di un certo modo di intendere il basso) grazie a Jaco Pastorius. Da lì ho davvero ascoltato di tutto, passando da Geddy Lee ad Alain Caron; da Billy Sheehan a John Patitucci; da Brian Bromberg ad Adam Nitti (senza considerare i tanti musicisti italiani). E davvero potrei continuare per tante righe… Quello che posso dire è che, se proprio devo fare qualche nome, cito: Randy Coven e Thundercat. Del primo ho davvero fatto – inconsapevolmente – man bassa del suo linguaggio artistico; il secondo è quello che più mi piace attualmente, per la tecnica, per il talento, per il suo approccio alla composizione e anche perché è un personaggio fuori dal comune…
Tornando al giorno d’oggi, alla luce dell’emergenza che stiamo vivendo, come immagini il futuro della musica nel nostro paese?
D.S.: Spero, con tutto il cuore, che questa tragedia finisca al più presto. Sono troppe sono le persone che stanno soffrendo per questa terribile situazione, e non mi riferisco soltanto ai musicisti. Infatti, molti ignorano che – oltre ai musicisti – vi sono categorie professionali altamente qualificate che vivono con la musica: i fonici, gli impiantisti, tutte le maestranze coinvolte nell’allestimento degli spettacoli. Si tratta di centinaia di persone ormai ridotte allo stremo e che sono state sistematicamente messe nel dimenticatoio.
La storia ci insegna, tra le tante cose, che – a seguito di un evento catastrofico – subentra sempre un periodo florido. In questo senso sono molto fiducioso; spero, soltanto, che questo punto di svolta avvenga al più presto per il bene di tutti.
Prima di salutarci, c’è qualche aneddoto che ti va di condividere sui tuoi anni di carriera artistica?
D.S.: Il primo episodio che mi viene in mente è una sorta di “battesimo”, che vide come “officiante” James Senese. Mi ero recato in un negozio di strumenti musicali a Napoli – per acquistare il mio primo basso – e lì si trovava il grande sassofonista. Al ché, dopo avergli chiesto (ed ottenuto) un autografo, mi disse (in napoletano, ovviamente): “Ragazzo, mi raccomando: va’ subito a casa e impara in fretta a suonare il basso!”.
E per chiudere: c’è qualche novità sul prossimo futuro che ti è possibile anticipare?
D.S.: È in lavorazione un secondo album, che, in qualche maniera, si allaccia a “Order and DisOrder”. Può esserne considerato una sorta di “sequel”, anche se ne differisce per diversi aspetti. Più di questo, non dico…
Grazie mille Daniele!
D.S.: Grazie di cuore a te e ai lettori.
(Febbraio, 2021 – Intervista tratta dal volume “Dialoghi Prog – Volume 2. Il Rock Progressivo Italiano del nuovo millennio raccontato dai protagonisti“)








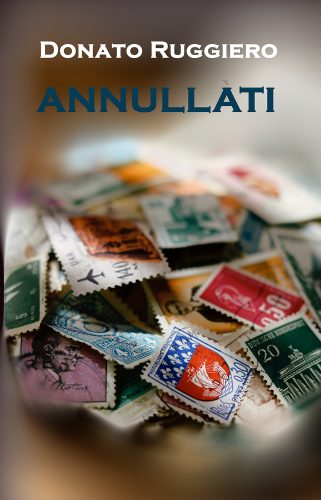
Lascia un commento