 Un caro benvenuto a Jerry Cutillo, cantante, compositore, polistrumentista, deus ex machina del progetto O.A.K. (Oscillazioni Alchemico Kreative).
Un caro benvenuto a Jerry Cutillo, cantante, compositore, polistrumentista, deus ex machina del progetto O.A.K. (Oscillazioni Alchemico Kreative).
J.C.: Grazie a te Donato. È un piacere ritrovarsi a fare quattro chiacchiere insieme. L’ultima volta, se non erro, eravamo al Caffè Nolano in Piazza Campo de’ Fiori a Roma, sotto l’occhio vigile di Giordano Bruno… che ha portato fortuna ad entrambi, direi.
Iniziamo la nostra chiacchierata dalle origini. Quali sono i tuoi primissimi passi nel mondo della musica e i primi “amori”?
J.C.: Sono di stirpe sannita ma negli anni ’50, da Solopaca, i miei genitori si trasferirono in un quartiere periferico di Roma che aveva come unico pregio quello di essere non molto distante dal Palasport dell’EUR.
Questo particolare, assolutamente da non sottovalutare, fece in modo che io bruciassi le tappe dei miei esordi musicali. Grazie ad un sufficiente rendimento scolastico, riuscivo ad estorcere ai miei genitori il permesso di recarmi, appena tredicenne, agli spettacoli di Frank Zappa, Gentle Giant, King Crimson, Genesis, Yes, VdGG e tanti altri. Avevo da poco iniziato un fitto scambio di musicassette con i miei amici di età maggiore e il pallone, con cui avevo condiviso accese sfide con i miei coetanei, mi guardava fisso con un’espressione di triste abbandono. Il mangianastri Philips, invece, vibrava in tutta la sua potenza e le note di “Tarkus”, “Per un amico” e “Who do we think we are”, miei primissimi acquisti, mi aprivano nuovi orizzonti. Ogni scelta mi costava, però, giorni e giorni di valutazioni perché con la paghetta mensile potevo a malapena effettuare un acquisto ogni due mesi. Quindi la disputa, a suon di articoli su Qui Giovani e Ciao 2001, era tra Deep Purple o Slade, Genesis o Gentle Giant, ecc.. Mi arrangiavo, però, con registrazioni pirata che effettuavo con il radio registratore Grundig di mio padre, con il quale mi sintonizzavo sulle frequenze di “Per voi Giovani”. Poi un mio amico fece il salto di qualità ed il suo riproduttore di nastri Stereo8 mi permise di ascoltare, per la prima volta e stereofonicamente, “Living in the past” dei Jethro Tull. Avvertii subito qualcosa di inconsueto, come un richiamo lontano, e non si trattava della solita inquilina del piano di sotto che si lamentava per il volume alto. Al contrario, si trattava di sonorità ancestrali che rievocavano qualcosa di immaginifico. E come la vibrazione del Big Bang, la magia di quel primo ascolto continua a risuonare nella mia fantasia ed io continuo ad inseguirne l’eco. Credo sia stato quello uno degli episodi più formativi che ha determinato le mie scelte professionali ed ha continuato a nutrire la mia creatività.
Tra le varie esperienze degli anni ‘70, c’è anche quella con l’Albergo Intergalattico Spaziale. Come ricordi i momenti passati con Mino Di Martino e Terra Di Benedetto e come entri nella loro “orbita”?
J.C.: A tredici anni comincio a studiare organo elettronico, vendo la mia Bocross (un orgoglio di bicicletta) e con il ricavato acquisto un flauto traverso. Nel mentre, la sei corde appesa nella camera di mia sorella cambia proprietario e, quindi, giù alla ricerca di qualche accordo da strimpellare. Comincia così l’avventura di un polistrumentista in erba (più tardi arriverà anche quella) che, a soli quindici anni, riceverà la visita dell’Albergo Intergalattico Spaziale cogliendone a pieno tutti i sussulti armonici. Dopo quella casuale improvvisazione avvenuta sul palco di un festival di quartiere, Mino Di Martino divenne una delle mie maggiori figure di riferimento. La sua calma serafica, il suo radicalismo artistico, il suo coraggio, la sua indole pacifista, la sua umiltà, i suoi silenzi e le sue sperimentazioni si riveleranno un faro che mi permetterà di attraversare indenne le spesse nebbie dei seguenti anni di piombo. Ho rivisto di recente Mino e Terra e sono rimasto per loro quel teenager curioso, a loro detta talentuoso, che li sbalordì con la sua precocità nel comprendere linguaggi musicali, filosofici e spirituali appartenenti ad una generazione precedente alla sua. Io, di loro, ricordo la luminosità e lo spirito d’avventura che posso ritrarre con questi pochi elementi: un pulmino Volkswagen, un Echo a nastro Binson (fonte di magie psichedeliche) e un organo Farfisa, lo stesso che accese le sue note quella prima volta che salii furtivamente sul palco durante la loro performance. Il legame con entrambi continua ad essere di assoluta empatia e si protrae nel tempo generando sempre nuovi progetti. Ho partecipato negli anni ai loro spettacoli, ai loro rispettivi progetti solistici, al concerto insieme a Juri Camisasca di ritorno da decenni di isolamento conventuale, e abbiamo ricreato sempre quello spirito pionieristico che contraddistingueva gli adepti della vecchia scuola psichedelica anni ’70.
I concerti al PalaEur, l’esperienza londinese, il fervore socio-artistico del periodo: come ricordi quella decade magica? C’è qualche altro aneddoto che ti va di condividere?
J.C.: Il ricordo rimasto degli anni ’70 è sicuramente distorto dalle pulsioni adolescenziali di quei momenti e da una smisurata fantasia che compensava la miseria dilagante. Aneddoti ne ho tantissimi (forse la vita non è altro che un lungo aneddoto). Tuttavia mi torna in mente il concerto dei King Crimson al Palasport nel novembre 1973. Fu la prima volta che, una volta entrato con regolare biglietto di gradinata, scavalcai dagli spalti in platea per gustarmi uno spettacolo migliore. Era un copione a cui avevo assistito passivamente nei precedenti concerti ma, in occasione del Re Cremisi, ruppi gli indugi e mi lanciai insieme agli altri verso le prime file. L’onda capelluta si diresse rapidamente verso la destra del palco occupando tutti i posti per cui io corsi dalla parte opposta dove nelle prime file c’erano ancora spazi. Raggiunsi una postazione di prim’ordine alla sinistra del palco e sogghignai alla corsa degli ultimi “scavalcatori” che continuavano a procedere verso il lato destro. Era evidente una certa discrepanza tra i due settori della platea ma non ci badai troppo. Ero contentissimo per aver fatto finalmente il mio ingresso all’interno del popolo dei contestatori, dei disubbidienti ad ogni forma di disparità sociale. Fuori dai cancelli potevo ancora sentire le voci dei militanti di Stampa Alternativa che gridavano “La musica si sente e non si paga”, per cui il mio era stato un gesto che nobilitava quella controcultura di sinistra. Quando si spensero le luci un boato accompagnò l’entrata della band e… Robert Fripp si posizionò sulla destra del palco! Ecco svelato il motivo di tanto affollamento da quella parte. La mia giovane età, il mio impeto e la mia inesperienza mi avevano precluso osservazioni più dettagliate sulla strumentazione posta sul palco, con i pedali chitarristici in bella mostra e i mellotron, entrambi bianchi, che giganteggiavano su entrambe le postazioni laterali. Quindi non rimaneva che rassegnarsi ma… un tredicenne non va in piena solitudine ad un concerto di una delle sue band preferite, poi scavalca in platea per essere più vicino al suo beniamino Bob Fripp e, alla fine, per una maledetta distrazione, si rassegna ad averlo lontano dalla sua vista! Per cui, al momento opportuno, sgattaiolai oltre le transenne che delimitavano la platea dall’estremità del palco. Mi trovai faccia a faccia con Fripp che dal suo sgabello nero fissava la tastiera della sua Gibson Les Paul custom nera, quasi incrociando il suo sguardo con il mio. Furono pochi secondi ma bastarono per essere travolto da un’energia indecodificabile, sovrastante, insostenibile e… non feci in tempo a trovare un quarto aggettivo che mi sentii sollevare dall’alto. Molto garbatamente, un agente della security mi invitava a tornare all’interno delle transenne.
Dell’esperienza londinese, invece, ricordo l’acquisto dell’album “Stormwatch” avvenuto in un Record Shop a King’s Road. Era l’estate del 1979 e il fenomeno punk era ancora in piena esplosione. Capelli corti color giallo canarino e t-shirt nera con gigantografia di Sid Vicious che con le dita invitava a… farsi da parte, entravo per effettuare il mio acquisto e trovavo alla cassa l’emulo di Johnny Rotten. La mano che teneva la copertina del disco dei Jethro Tull, con in copertina un vecchio hippy barbuto con un cannocchiale, tremava per l’imbarazzo. Cosa ci fa un punk con in mano un long playing di dinosauri? Temevo stessero tutti pensando! Stavo rischiando la gogna e la scomunica dal mondo del punk e all’interno della rivendita avvertivo gli sguardi su di me moltiplicarsi. Stavo quasi per tornare indietro e riporre il disco nello scaffale quando un gruppo di tifosi del Chelsea fece il suo ingresso nel locale. Approfittando della confusione, scattai in avanti, allungai la mano con il contante verso il cassiere e presi rapidamente l’uscita. Una volta in strada, stringevo il long playing sul petto per celare la copertina e il nome degli autori agli sguardi dei punk rockers che affollavano quel distretto a sud ovest di Londra. Sembravano minacciosi e i Jethro Tull erano fra i gruppi gettati dalla torre in quel finale degli anni ’70.
Anche a Roma il discorso non cambiava. Il cantante con cui avevo creato un fertile sodalizio artistico non sopportava che parlassi di Ian Anderson o di Tony Banks, mio altro riferimento musicale. Con lui suonavo una specie di art punk e mi occupavo delle tastiere (organo Farfisa, piano elettrico Fender Rhodes, tastiera violini Elka e sintetizzatore Yamaha CS30) e chitarra elettrica. Le prove si svolgevano nel magazzino di un Istituto Tecnico Professionale frequentato dal nostro batterista e spesso ricevevamo visite da parte dei nostri amici. Una sera si accalcarono più di una ventina di persone nella nostra sala ed io avevo scritto una nuova canzone. Ero il maggiore compositore del gruppo e, come di consueto, proponevo le mie creazioni presentandone sia le parti armoniche che vocali. Intonai le prime note della melodia sorretto da un tappeto di archi e l’effetto fu notevole. Al termine del brano ricevetti un lungo applauso e una serie di commenti lusinghieri che mi aprirono ad una domanda. Avrei forse dovuto cantare io le mie canzoni?
…e poi arrivano gli anni ’80. La musica quale lavoro, il successo commerciale col nome di Moses, le ospitate televisive e radiofoniche. Com’è cambiato, dunque, il mondo musicale di Jerry Cutillo in quel decennio?
J.C.: Nel secolo scorso ho sempre tenuto il passo con i tempi. Il mio traguardo era quello di esprimere la mia verve artistica che cambiava veste in base al trend del momento, ma rimaneva immutata nella sostanza. Tuttavia la mia ambizione era quella di diventare un artista d’avanguardia e quindi precorrere i tempi, ma nel mio paese c’era (e temo che oggi la situazione sia addirittura peggiorata) un gap insanabile e una dietrologia disarmante. Nonostante tutto, riuscii faticosamente a correre dietro alle stagioni del Prog, del jazz rock, del punk, della new wave fino allo scivolone nella realtà dell’italo disco. Nei primi anni ’80 avevo firmato un contratto con una casa di produzione, la Pollicino & Co. che realizzava i miei brani e li promuoveva nel settore discografico. Rappresentava una delle maggiori realtà di produzione musicale a Roma e numerosi managers e session men orbitavano intorno a quel circuito. Io rappresentavo il pezzo forte della scuderia. Giovane, prolifico e belloccio, secondo i canoni del tempo, scrivevo canzoni e sviluppavo arrangiamenti senza sosta, stimolato dalla presenza di musicisti esperti con cui condividevo gli spazi dello studio. Li osservavo all’opera e ne assorbivo i segreti professionali. Furono anni molto formativi e la mia fu una presenza costante negli studi di registrazione. Una delle canzoni prodotte in quel periodo balzò in cima alle classifiche di vendita italiane ed europee e io, apostrofato come Moses una sera dal mio manager napoletano, vidi apparire quello stesso nome sulla copertina del mio 45 giri sigla di Discoring. Poi il Festivalbar, Super Classifica Show, Radio Kiss Kiss ecc.… e con biglietto business class KLM il mio viaggio proseguì verso i cieli del nord Europa. All’aeroporto di Schipol il manager della Dureco olandese mi attendeva con un cartello con su scritto Moses ed io continuavo a guardarmi intorno. Capii infine di essere io il personaggio atteso.
Sono contento per quanti abbiano raggiunto la realizzazione personale nel “successo”, ma nel mio caso quello che mi girava intorno era fonte di stress e domande esistenziali. Il mio ritmo circadiano era cadenzato da alloggiamenti in Hotel di lusso, lunghi percorsi autostradali per raggiungere studi televisivi oppure stazioni radiofoniche e, infine, cene in ristoranti di prim’ordine. Una sera a cena, rimasto sprovvisto di sigarette, mi guardai intorno. Al tavolo poco distante c’erano i Pet Shop Boys che cenavano insieme a due energumeni. Non mi sembrò il caso di disturbarli. Ne chiesi, perciò, una al mio manager. Lui chiamò il cameriere, pronunciò alcune frasi incomprensibili e subito dopo il garçon tornò con un pacchetto della mia marca preferita ed un accendino. Scartò l’involucro, me ne porse una, l’accese e poi posò tutto di fianco al mio tovagliolo. Visto che si allontanava mi alzai per chiamarlo e rendergli le sigarette, ed anche l’accendino, ma Mr. Skall mi prese per un braccio e mi invitò a sedermi sorridendomi bonariamente. La sua espressione sembrò dirmi: Funziona così quando hai un disco in classifica!
Certamente, quell’esperienza fu una grande soddisfazione dal punto di vista personale. Poter dire di avercela fatta rappresentava un riscatto per quanti non avevano creduto in me. Un mio amico d’infanzia si trovava, purtroppo, a Regina Coeli per scontare una condanna per furto e, quando mi vide in televisione, provò una gioia immensa e mi scrisse una lettera che vale più di mille altre congratulazioni. D’altro canto, però, l’amarezza per aver conosciuto la superficialità e la falsità che regolano le relazioni che agitano il mondo del business musicale fu altrettanto intensa. Trovarsi sullo stesso set televisivo con i Starship (con la loro “We built this city”), Elton John (“Nikita”), Simply Red (“Holding back the years”) e moltissimi altri non aveva prezzo ma il condividere i dietro le quinte con A-Ha, Princess, Baltimora e tante altre meteore di un fenomeno musicale di rapido consumo (incluso il sottoscritto), aveva qualche controindicazione. Potevo leggere sui loro volti e sentire dalle loro parole che recitavano una parte che non aderiva alla loro personalità e sembravano ormai convinti di essere persone speciali. A me, invece, non successe niente di tutto questo. Percepivo i tentacoli di quella trappola mortale. Cambiare il proprio stile di vita e i propri atteggiamenti abituandosi ad avere sempre l’attenzione su di sé, avrebbe potuto avere gli stessi effetti di una droga come l’eroina probabilmente, con tanto di assuefazione. E ciò che mi tenne sempre lontano da quelle sostanze mi schermò anche nei confronti di quelle facili esaltazioni e da un fatale ingresso nei meccanismi morbosi della fama e del successo.
Ma la tua anima Prog non è mai morta e con gli anni ’90 torna a galla prepotentemente sotto la sigla O.A.K.. Come mai decidi di “buttare via” il Jerry eighties e ricominciare da capo? E come nasce il progetto?
J.C.: Sul finire degli anni ’80 avvennero due eventi che minarono la mia incolumità fisica e psichica. Mi aggrappai, quindi, alla parte più solida di me stesso che aveva come nome Prog Rock. Non fu facile risalire la china e remare controcorrente, ma con la forza della passione sono riuscito a tirar su una nuova storia, autentica e feconda.
Nel 1993 esce l’album “O.A.K.”, seguito da “Heresis Strigiatum”. Mi parli di questi due lavori? Quanto c’è già del Jerry Cutillo “esploratore di tradizioni esoteriche” che deflagrerà definitivamente nel nuovo millennio?
J.C.: Proprio in questo periodo sto aggiornando il sito www.oaksound.com. Mi sono quindi immerso nel passato della band rimanendo favorevolmente impressionato dalla coerenza artistica dimostrata in tutti questi anni. Gli O.A.K. hanno rappresentato il mio punto di approdo dal quale sono ripartito a vele spiegate alla ri-perlustrazione del mio mondo musicale. Il primo album omonimo, uscito nel ’94 in versione musicassetta, fu prodotto nel mio home studio con l’ausilio di Iacopo Ruggeri, chitarrista storico della band. L’alchimia sonora presente nelle sei tracce è un concentrato di Prog/folk/psichedelia e riff grunge. Nel seguente “Heresis Strigiatum” c’è anche un tocco di space rock derivante dal movimento psichedelico inglese degli anni ’90. Il circuito dei Festival estivi, relativo a gruppi come Mandragora, Ozric Tentacles, Moondragon ed altri, era l’unico ad emettere segnali degni di nota in quegli anni. Il sound e lo stile di scrittura dei testi nei primi album degli O.A.K. non sono distanti da quello che canterò venti anni dopo nella trilogia esoterica. Sembra proprio che mi stia avvicinando sempre più al buco nero dal quale continuo ad essere inesorabilmente attratto.
E poi esplode la moda della covermania che colpisce in pieno anche gli O.A.K., dandoti ampio spazio per abbracciare una delle tue più grandi passioni: i Jethro Tull. Nonostante sia una scelta davvero controcorrente, in un periodo in cui la band inglese non è proprio “sulla cresta dell’onda”, il progetto riscuote un gran successo e ti vede calato perfettamente nei panni dello “Ian Anderson italiano”. Ma dove nasce l’esigenza di seguire la moda delle cover band, nonostante tutti i rischi del caso specifico, e qual è stato il processo di trasformazione O.A.K./Jethro Tull?
J.C.: Credo che chiunque, almeno una volta nella vita, abbia provato il desiderio di emulare il personaggio che rappresenta il proprio ideale di perfezione. Si tratta per lo più di coincidenze, casualità che scatenano reazioni indelebili e perdurano lungo l’arco della nostra vita. E se in una serata d’autunno, un giovanissimo aspirante freak incontra un menestrello con capelli e barba lunga, vestito di un pastrano con una chitarra a tracolla… Aqualung sta per rivelarsi.
Sebbene gli O.A.K. fossero stati formati dal sottoscritto per dare corpo a composizioni originali, il fenomeno della cover mania non mi lasciò indifferente. I gestori dei locali, purtroppo, non prevedevano altro e dovendomi inchinare a un simile diktat, optai per la musica dell’artista che più sentivo vicino. Feci una rapida opera di convincimento nei confronti dei miei tre compagni di band e riuscimmo ad inserirci nel programma del Teatro Palladium di Roma. Mi ero esercitato a volteggiare il flauto e a suonarlo rimanendo in equilibrio su una gamba sola, avevo inoltre delegato alla mia vicina di cucirmi un soprabito di tartan scozzese e mi ero, infine, lasciato crescere i capelli. Il risultato fu sconvolgente! Dopo una decina d’anni di affermazioni nel settore delle tribute bands con numerosi encomi e riconoscimenti, si cominciò, però, a rivaleggiare tra bands per chi fosse il più Ian Anderson di tutti e quando Glenn Cornick mi presentò a Clive Bunker dicendo: “Jerry Cutillo, il clone di Ian” risposi stizzito: “Non sono un clone!”. Ci sono momenti della nostra vita dopo può accadere l’impensabile. Qualcosa che avevi anelato per anni, finisce improvvisamente per non avere più importanza.
Che ricordo hai delle iTullians Conventions? Mi racconti l’esperienza del “flute contest” del ’97 in cui “stracciasti” tutti i concorrenti di fronte a Glenn Cornick?
J.C.: Rispetto ai miei ideali artistici, ho sofferto spesso di solitudine e isolamento. Non sempre, infatti, sono riuscito a trovarmi al posto giusto nel momento giusto. Il tributo ai JT degli O.A.K. ne è la dimostrazione. Arrivò in uno dei momenti più critici per la band di Ian Anderson e per tutto il Prog in generale, gli anni ’90. Un temerario ebbe il coraggio di aprire un pub e chiamarlo Aqualung. Era sempre vuoto e dopo poco tempo chiuse i battenti. Poi, dal nulla spuntò il fan club de iTullians. Non ho mai aderito ad un fan club in vita mia e, quindi, non ne diventai socio, ma col tempo capii che un’associazione riconosciuta a livello istituzionale ha molto più peso di un gruppo musicale. Tuttavia, quando ebbi con loro il primo approccio, nell’estate del ’97 a Castel Ceriolo (AL), trovai una dimensione ancora molto “naïve”. Per puro caso partecipai al flute contest e arrivai primo. Fu tutto merito del mio amico Mario Prili il quale, partito con me da Roma, prese l’iniziativa mettendomi in lizza per il concorso. Non credo sarei riuscito ad esibirmi in un tale contesto senza la sfrontataggine di Mario… per cui iTullians devono prendersela con lui [ride].
Tra il pubblico c’era Glenn Cornick, con il quale mi intrattenni nel fine serata, ed esattamente dodici mesi dopo eravamo sul palco insieme per una stringa di concerti in Italia.
La demo “S.A.T.O.R.” e poi ancora “Parallel Dances”, “Re-living In The Past”, “Filosofisenzalibri”, “Shaman Feet”: anni davvero prolifici per gli O.A.K. quelli da 1998 al 2011, affiancati dagli spettacoli dedicati ai Jethro Tull. A quale (o quali) di questi lavori sei più affezionato? E quale (o quali), a distanza di diversi anni, pensi sia il più riuscito?
J.C.: Ho tendenza a cercare di superare sempre il mio precedente traguardo. Per cui, togliendo “Re-living in the past” che fu un lavoro di sole covers Tulliane, per gli altri vale la regola di cui scrivo.
“Spulciando” nella tua vita artistica, mi sono imbattuto nella grande “furbata” del Geronimo’s Pub. Ti va di raccontarla?
J.C.: Nel ’98 ebbi l’occasione di condividere il palcoscenico non soltanto con Glenn Cornick ma anche con il suo ex compagno di band Clive Bunker. In quel periodo la formazione degli O.A.K. era strepitosa e Clive ne rimase colpito. Quando giunse a Roma per un concerto con il chitarrista hendrixiano Carvin Johnes, andai a salutarlo. Il Geronimo’s Pub era un locale molto ambito dalle tribute bands ma gli O.A.K. non vi avevano ancora mai suonato. Quella sera feci, quindi, del mio meglio per bucare il velo di indifferenza mostrato sin d’allora dai proprietari rispetto alla mia proposta musicale. Mentendo dissi loro che Clive sperava di poter aprire la serata con qualche brano del suo vecchio, amato gruppo, i Jethro Tull. Loro acconsentirono ed io tornai da Clive riferendo di una presunta richiesta da parte del locale di farci aprire la serata con qualche classico dei JT. Non avremmo certo potuto scontentare Geronimo! E così Clive accettò. A quel punto chiamai il resto della mia band, che era già presente in sala, e partimmo con un set strabiliante. Il risultato fu una standing ovation con richiesta di bis e da quel giorno la nostra residenza al Geronimo’s Pub è stata regolare e ininterrotta per tredici anni.
Con “Filosofisenzalibri” e, ancor più, con “Shaman feet”, iniziano a fioccare le grandi collaborazioni: Rodolfo Maltese, David Jackson, Glenn Cornick, Maartin Allcock, Jonathan Noyce. Qual è stato, effettivamente, il loro apporto e quanto ha contato, nella tua crescita artistica, averli accanto in queste occasioni?
J.C.: Il mio primo approccio con i big, in veste di manager, lo feci con Glenn Cornick e non fu semplice perché insieme a lui, in formazione, avevamo l’inglese Robert Illesh e lo spagnolo Jonsalo Carrera. Devo confessare che dell’esperienza con loro preferisco ricordare soltanto i momenti delle performance. In quelle liberavamo tutta la nostra carica esplosiva realizzando dei top tributi che facevano rivivere gli esordi della band di Ian Anderson. Poi arrivò il turno di Maartin Allcock, che in principio era molto diffidente rispetto al nostro paese per aver avuto cattive esperienze in passato. Finì, invece, per innamorarsene, ma questa è un’altra storia. Rimanendo sul tema collaborazioni, una volta rotto il ghiaccio divenne per me un’operazione molto naturale contattare gli special guests ed organizzare la relativa logistica. Questo avveniva in modo spontaneo perché l’obiettivo comune era quello di condividere nuove esperienze e realizzare progetti di cui eravamo tutti interessati. Le operazioni, quindi, si svolgevano su binari paralleli, senza distinzioni di categoria. Sai, una volta che li hai avvicinati, questi mostri non fanno più paura. Ne scopri genialità e debolezze, proprio come tutti noi.
Sempre nel periodo di “Filosofisenzalibri”, la sigla O.A.K. assume un nuovo significato concettuale: Oscillazioni Alchemico Kreative. Come mai questo “passaggio” e quanto è dovuto ai contenuti dell’album?
J.C.: Nel lontano ’93, in una delle primissime prove in saletta, il bassista Giovanni Quarta arrivò esclamando: “Ho trovato il nome per il gruppo…Oak!”. Ci sembrò ottimo; breve e significativo. La quercia sarebbe stato il nostro albero magico. Più tardi ci accorgemmo, però, di quante insidie celava quel nome. Intanto la sua impronunciabilità da parte dei nostri connazionali, che non possono certo immaginare di dover pronunciare la vocale “A” come se fosse una “U” (misteri della lingua anglosassone), poi la similitudine con simboli relativi a pallide storie governative e, infine, la massiccia diffusione della parola nei paesi anglosassoni dove rappresenta una sorta di apostrofo per pubs, hotel, negozi and so on…
Pensavo, tuttavia, che fossimo stati sprovveduti soltanto noi ma recentemente ho scoperto centinaia di band, sparse in tutto il mondo, che hanno nome OAK. Quindi si è cercato di riparare creandone un acronimo. Oscillazioni Alchemico Kompresse (con la “K” che rinforza il concetto). Poi arrivò la collaborazione con Claudio Rocchi che soffriva, purtroppo, di una malattia degenerativa ed era in piena espansione spirituale. L’aggettivo “Kompresso” non si addiceva al suo estremo tentativo di liberarsi e volare. Sostituii quindi l’ultima parola dell’acronimo con “Kreative”. Ma, a tutt’oggi, questo nome non ha vita facile e, nonostante i puntini, c’è sempre bisogno di una puntualizzazione. Credo che la cosa migliore sia sottolinearlo con O.A.K. Jerry Cutillo, sperando che nel frattempo non spunti qualche mio omonimo.
La cosa che davvero dispiace è la totale irreperibilità fisica di quasi tutti i lavori che precedono “Viandanze” (2015). C’è mai stata (o ci potrebbe essere in futuro) la possibilità di un recupero e una ripubblicazione delle varie opere?
J.C.: Accade spesso che, in seguito ad una sopraggiunta “visibilità”, un gruppo debba riconsiderare i propri precedenti lavori. Questo è molto lusinghiero e, allo stato attuale, gli O.A.K. stanno suscitando un così grande interesse in tutti i continenti che ci sarà sicuramente motivo di ristampare tutti i primi album. E di questo ne sono profondamente orgoglioso perché ritengo che siano opere che meritano ascolto.
E nel 2015 arriva, appunto, “Viandanze” e, con esso, prende il via la “trilogia Prog esoterica” degli O.A.K. che si concluderà, nel 2020, con “Nine witches under a walnut tree”. Una miscela di storia, folklore, magia, scienza e la toccante dedica a tuo padre di “My old man” caratterizzano i testi dell’album, tutto avvolto da una musica immaginifica che fa del folk-rock Progressivo il suo punto fermo. Ti va di parlarmi del percorso che il “viandante” Jerry ha affrontato durante la sua stesura?
J.C.: Un mio progetto letterario dal titolo “Come una volpe tesa a rubare nel cortile delle voci” si era ormai trasformato nel “Rockbook”, spettacolo che ripercorreva le fasi più salienti della mia storia artistica e il feedback generato dai nostri show multimediali era estremamente positivo. Mi ritrovai ad interagire con la line up più numerosa della storia degli O.A.K., fino a dodici artisti che si alternavano in scena contribuendo a dar vita ad un percorso che da un iniziale background Prog si snodava in direzione art rock decadente, poi pop, per virare e giungere alle lontane lande siberiane prima di un definitivo ritorno. Un viaggio, o meglio, una Viandanza lungo le strade del mondo che al suo termine, come per incanto, mi riportava sui tratturi del Sannio. Sentieri secolari attraverso i quali i miei antenati avevano compiuto i cicli della transumanza e che risuonavano ancora dei richiami per le mandrie. Le mie origini agresti sussultarono ancora, in seguito alla morte di mio padre che avvenne nello stesso periodo della scomparsa della madre di David Jackson. Al sassofonista dei VdGG avevo fatto ascoltare il brano “My old man” e lui ne era rimasto profondamente colpito. Effettuammo parte delle registrazioni, alle quali partecipò anche Jonathan Noyce, nello studio dei Fairport Convention a Bodicote, in Inghilterra. Poi proseguii il lavoro nel mio home recording studio a Roma.
Dopo l’autoproduzione dell’album “Shaman feet” avevo ripreso anche i contatti con il produttore di “Filosofisenzalibri”, Marco Viale, che nel frattempo si era trasferito in Svizzera. Circondati dai rilievi alpini del Ticino realizzammo i missaggi del primo volume della trilogia Prog esoterica degli O.A.K..
“Viandanze” nasce quindi nella tua mente come allegato sonoro al libro “Come una volpe tesa a rubare nel cortile delle voci”, opera in cui narri, appunto, alcune vicende della tua storia musicale. Il progetto iniziale è stato poi “sovvertito” dalla parte sonora, completata in anticipo rispetto al libro e, quindi, pubblicata. L’idea del libro, al momento, è stata solo messa in “stand-by” e dobbiamo aspettarci una sua uscita in futuro?
J.C.: Il libro, o per meglio dire, il racconto multimediale di esperienze mie e di altri personaggi nei quali, nel bene e nel male, mi sono imbattuto lungo la mia folle corsa agli “anta”, è in continua ebollizione. Piuttosto che un resoconto autoindulgente delle mie vicende, però, spero che rappresenti una sorta di vademecum per giovani apprendisti “viaggiatori del tempo”. Detto in parole povere, un “bignami” sugli errori da non commettere per quanti volessero intraprendere la carriera musicale, considerando che tra qualche anno le cose potrebbero cambiare radicalmente.
Tornando col senno di poi su “Viandanze”, c’è una cosa che mi ha colpito più di ogni altra e, onestamente, è stata una sorta di “epifania”: la “trilogia Prog esoterica” è già tutta lì! In “Magica noce” anticipi “Nine witches under a walnut tree” narrando la storia delle janare, le streghe di Benevento, con i loro riti celebrati sotto un albero di noce nei pressi del fiume Sabato, mentre in “Giubileo” citi la fine “arrostita” di Giordano Bruno. La “bozza” dei tre album, dunque, era già nella tua mente prima di iniziare a scrivere “Viandanze”? Dubito sia solo un caso…
J.C.: In una sintesi estremamente cinica, i due album che seguono “Viandanze” potrebbero ritenersi quasi “superflui” ma temo che sia Giordano Bruno che le Nove protagoniste del sabba sotto il noce di Benevento si rivolterebbero dalla tomba e per me sarebbero ***** amari! Sarebbe come dire ad un secondo e terzo figlio di essere “riempitivo” rispetto al primo.
Tuttavia, credo che tu abbia ragione. Ma… il Prog è l’esatto contrario del concetto di sintesi.
Il 2018 è l’anno di “Giordano Bruno”. Quando e come nasce l’amore per il controverso filosofo nolano? È stato arduo il processo che ti ha condotto dalla prima nota scritta al doppio vinile?
J.C.: Il nove giugno del 1889 a Roma, in Piazza Campo de’ Fiori, fu inaugurato il monumento a Giordano Bruno. Da quel giorno i cattolici più intransigenti chiamarono quella piazza, Campo Maledetto! Ciò sta a dimostrare il lungo e drammatico conflitto tra forze laiche e clero che si contrapposero a lungo. A pochi passi dal Vaticano c’era in ballo la realizzazione di un monumento ad un eretico arso sul rogo il 17 febbraio 1600. Ma con quella prima vittoria delle forze progressiste, Piazza Campo de’ Fiori divenne la scacchiera sulla quale si giocarono molte altre battaglie sociali. Anch’io fui attratto dal luogo e, nonostante non conoscessi ancora bene la storia del filosofo nolano, rimasi impressionato dallo sguardo di sfida di quel monaco incappucciato con un libro stretto tra le mani. D’altronde Giordano Bruno è stato sempre trascurato dalla storiografia ufficiale e, a tutt’oggi, la Chiesa non ha ancora presentato le proprie scuse per aver barbaramente ucciso uno dei massimi esponenti dell’intellighenzia del nostro paese. Un altro elemento che ha determinato il mio orbitare intorno alla figura di Giordano Bruno è inerente ad una delle mie prime visite nel centro di Roma. La piazza adiacente a Campo de’ Fiori ospita la sede dell’Ambasciata Francese e, negli anni ’70, era sempre affollata di sessantottini che bivaccavano sulla seduta marmorea che cingeva Palazzo Farnese. Il caso volle che un menestrello, male in arnese, si sedesse a strimpellare “Aqualung” in mia presenza, colpendomi in pieno con il suo pulviscolo sonoro. Ascoltando “Angeli senza ali”, il breve brano acustico che chiude la prima delle quattro facciate del disco, possiamo immergerci in un viaggio del tempo che spiega tutto.
Ma tornando alla realizzazione tecnica dell’album “Giordano Bruno”, posso affermare che la fase concettuale, insieme a quella compositiva, sono state straordinariamente rapide e immaginifiche. Per tutto il resto, invece, c’è stata più di una complicazione. Le registrazioni si sono rivelate faticose (ho suonato io gran parte degli strumenti) e le relazioni con alcuni collaboratori/collaboratrici terribilmente stressanti e inconcludenti.
E come mai l’idea di riprendere il brano “Sandali rossi”, già pubblicato in “Heresis Strigiatum”?
J.C.: Qualcuno ha definito “Sandali rossi” la “Stairway to Heaven” degli O.A.K.. La suite fu composta da me nel ’94 e inserita nell’album “Heresis Strigiatum”, prodotto con una tecnologia molto limitata. Con questo non voglio dire che tutti i vecchi album dovrebbero essere registrati nuovamente. Ogni produzione artistica è figlia del suo tempo, ma se nell’arco di più di venti anni sopraggiungono mutamenti di rilievo nelle possibilità/capacità di concretizzare un progetto, riproporre un cavallo di battaglia nel contesto giusto non mi sembra scandaloso. Se poi ciò avviene con un nuovo contributo come quello di David Jackson, il remake è ancora più motivato. Nella ristampa di “Heresis Strigiatum” non comparirà “Sandali rossi”, la versione ufficiale è ormai quella presente su “Giordano Bruno”. Tuttavia, in qualità di bonus track, verrà inserita “Red sandal 37”, la versione cantata in inglese e risalente anch’essa al lontano ’94.
“Giordano Bruno” è stato un successo internazionale straordinario. Eri certo della buona riuscita del prodotto o questo clamore ti ha un po’ sorpreso?
J.C.: Sia al momento della genesi di ogni mio nuovo lavoro, che nel processo della sua realizzazione fino al termine, ho sempre avuto l’impressione d’aver compiuto il mio “the best of”.
“Giordano Bruno” ha sicuramente avuto degli elementi a suo favore ma questi, con la musica, hanno soltanto in parte a che fare. L’iter di un’uscita discografica non “mainstream” è totalmente imprevedibile. Vanno poi sottolineati i condizionamenti a cui siamo sottoposti. É triste dover constatare quanto sia manipolabile il giudizio altrui. E non mi riferisco a “Giordano Bruno” in particolare ma a quello che accade in ogni settore produttivo e consumistico. Ti porto alcuni esempi su scala internazionale che ripeto, non hanno troppo a che fare con il mio lavoro ma che possono suscitare qualche interrogativo. Nel febbraio del ’79 usciva “The Great Rock ‘n’ Roll Swindle” dove il manager Malcom McLaren spiegava tutti gli steps per creare un prodotto di successo a tavolino. Nel ’95, invece, all’esterno dei principali record stores londinesi, veniva esposta la pubblicità del disco di un gruppo sconosciuto (rimasto tale) che aveva come titolo “How to make friends and influence people”. Non ci crederai Donato, ma finii per acquistarlo. Ripeto, questi due esempi non aderiscono certo ad una realtà come la mia, ma ci lasciano riflettere su quanto non sia sufficiente suonare soltanto buona musica per ottenere riscontri. L’accensione della miccia può essere casuale ma il più delle volte è indotta dall’utilizzo di alcuni “hooks”. L’innesco finisce poi col produrre una reazione a catena che veicola il giudizio critico a senso unico. Non dimentichiamoci, infine, che allo stato attuale, una buona percentuale di addetti ai lavori in campo artistico è priva dei minimi rudimenti di conoscenza musicale, quindi il condizionamento diventa assoluto.
Una curiosità: come mai, nella narrazione di “Giordano Bruno”, hai realizzato un “percorso ciclico” che parte da quel 17 febbraio del 1600, da Campo de’ Fiori, per tornare indietro e narrare alcune delle vicende dell’intensa vita del filosofo e poi concludersi nuovamente lì, tra le fiamme dell’Inquisizione?
J.C.: È uno stile cinematografico che avevo già sperimentato in passato ma era rimasto circoscritto a dei singoli brani, per cui l’effetto risultava minore. In un album doppio, della durata di 74 minuti come “Giordano Bruno”, invece, il risultato è stato deflagrante.
I miei approfondimenti su tematiche relative ai viaggi nel tempo mi hanno poi permesso una adeguata mobilità di scrittura per tracciare gli eventi nella giusta successione.
Il legame con la tua terra sannitica e la sua aurea “magica” è davvero molto forte e, dopo l’accenno in “Viandanze”, finalmente riesci ad ambientare un intero album “a casa tua”: “Nine witches under a walnut tree”, uscito il 9 settembre 2020. Ti va di presentare il nuovo lavoro?
J.C.: L’idea originaria era quella di rappresentare in musica nove siti tra i più esoterici sulla Terra. Ma il risultato sarebbe stato troppo dispersivo, immaginai, e quindi restrinsi il campo d’azione (si fa per dire) ad un contesto più “familiare”. Dopo aver lavorato di memoria e letto la consueta pila di libri sui temi “Caccia alle streghe”, “Noce di Benevento”, “Stretto di Barba”, “Processi per Stregoneria”, ecc…. per avere una visione ancor più ampia dell’argomento, ruppi gli indugi e contattai gli esperti Paolo Scalise e Carlo Napolitano. Furono loro a guidarmi sulla Ripa delle Janare e nei luoghi dove presumibilmente si trovava il Noce. Più la ricerca proseguiva, più i segnali diventavano positivi e gli embrioni creativi si sviluppavano ed arricchivano di nuovi elementi.
Chlodswinda, Gioconna, Dame Harvillers, Janet Boyman, Franchetta Borelli, Polissena, Donna Prudentia, Nadira e Rebecca Lemp: come si è svolta, dunque, la tua “caccia alle streghe”?
J.C.: L’opening track “Chlodswinda” è dedicata ad un personaggio frutto di una ricerca storiografica sulle dominazioni che si sono susseguite nel territorio del Sannio. Provenienti dalla Scandinavia, i Longobardi si stabilirono per quattro secoli in quelle regioni dando vita al Ducato di Benevento. Le prime fonti storiche che riguardano l’albero di Noce risalgono ai loro rituali.
“Gioconna”, invece, è la discendente di una nota strega del folklore beneventano: La Zucculara. “Dame Harvillers” proviene da Ribemont ed è un’alchimista francese realmente esistita che fu condannata al rogo per aver causato avvelenamenti tra la gente del suo villaggio. “Janet Boyman” è nativa di Edimburgo e viene perseguitata per i suoi contatti con il “piccolo popolo degli specchi d’acqua”. Si imbarca clandestinamente su una nave diretta a Napoli, dal cui porto si incammina per raggiungere le sue compagne sotto l’albero di Noce di Benevento. “Franchetta Borelli”, la strega di Triora, viene incarcerata e torturata per aver “causato” una carestia nella zona ligure. “Polissena” è un’esile ragazza, affetta da epilessia, esperta in viaggi nel tempo. “Donna Prudentia” proviene dalla Tuscia ed è una guaritrice, ma quando le sue cure non sortiscono gli effetti desiderati, viene sottoposta a violenze inaudite. Al sabba Prudentia si reca con una copia del “Malleus Maleficarum”, il libro scritto da due monaci domenicani che spiegano come riconoscere le streghe, come torturarle per estorcere loro le confessioni e, infine, come giustiziarle. All’interno di un cerchio di candele nere Donna Prudentia dà fuoco a quel libro maledetto. Discendente di una delle sacerdotesse della dea Iside, il cui culto fu molto diffuso nel Sannio antico, “Nadira” rievoca con una danza alare l’estremo tentativo di ricomporre le membra dilaniate del suo amato Osiride. Infine, “Rebecca Lemp”, che sale sulla Rupe delle Janare per mostrare alle altre il bagliore causato dall’esplosione della supernova Tyco che nei giorni del novembre 1572 illuminava le notti d’Europa.
C’è qualche dettaglio particolare, nascosto, qualche aneddoto che ti va di condividere sul processo creativo e la realizzazione di “Nine witches under a walnut tree”?
J.C.: Caro Donato, ad ogni domanda da te posta sembra che tu conosca già la risposta!
Uno degli aneddoti legati al processo creativo dell’ultimo step della trilogia è sicuramente quello relativo all’episodio di quando, guidato dal professor Paolo Scalise, mi inerpicai sul costone di roccia che delimita lo Stretto di Barba in provincia di Benevento. Procedendo in salita oltrepassammo una fitta vegetazione incolta, costellata da filo spinato arrugginito. Arrivammo sulla spianata che dà forma al limite estremo della Rupe delle Janare da dove si domina la valle. Poco distante, l’altro costone di roccia si stagliava di fronte al nostro sguardo dando forma alla gola nella quale i Sanniti intrappolarono l’esercito romano nello storico episodio delle Forche Caudine. Il prof. Scalise era in preda ad una eccitazione maniacale e mi invitava ad avvicinarmi allo strapiombo da dove, la leggenda narra, le streghe gettavano i corpi dei neonati. Mi tenni a distanza di sicurezza ma, nonostante tutta la mia attenzione, nella seguente discesa dalle rocce scivolai su del filo spinato procurandomi una brutta ferita al braccio destro. Dopo il sanguinamento apparì un graffio che sembrava causato da lunghi artigli. Avevo di certo profanato un luogo denso di misteri e quello, forse, era un semplice avvertimento!
Con il prof. Napolitano, invece, visitai il castello di Ceppaloni, risalente al periodo normanno, che domina la sottostante valle del fiume Sabato. Con noi c’era un gruppo di giovani ricercatrici americane guidate dalla medium, growl singer Karyn Krol Tiso, nota studiosa statunitense di esoterismo sannita. Lei e il prof. Napolitano ci istruirono sui luoghi degni di nota sparsi tra le provincie di Benevento e di Avellino. Ascoltavo avidamente quelle lunghe disquisizioni ed avevo come l’impressione di stare vivendo momenti irripetibili, una sorta di gita culturale condivisa insieme ad un’accademia di stregoneria. Avvertivo già la risonanza interiore che stava producendo quell’esperienza ed ero fiducioso che il progetto delle Nove streghe sotto l’albero di Noce, già a buon punto della lavorazione, ne avrebbe ulteriormente giovato. Non amo immortalare momenti di vita su fotografia, preferisco viverli pienamente, ma quel giorno sentii qualcosa che mi spingeva a scattare una foto a quell’allegra, esotica combriccola. Le ragazze si misero a schiera, premetti e mi affrettai a vedere il risultato. Contai i profili nell’immagine e… le apprendiste streghe erano NOVE!
Eccezion fatta per il legame tra le tematiche, quali sono i punti di contatto e le differenze sostanziali, secondo il tuo punto di vista, tra i tuoi ultimi tre album?
J.C.: Uno dei miei desideri non corrisposti, legati alla mia avventura con gli O.A.K., è stato il vano tentativo di costituire una formazione stabile e produttiva, in puro stile anni ’70. Ma… niente da fare, sarebbe forse stato più facile trovare, nel 2020, pepite d’oro nei fiumi americani. Ma dove sono finiti quei musicisti che si chiudevano in un cottage come quello di Headley Grange e vi rimanevano mesi a provare, nonostante topi e spettri vi girovagassero notte e giorno???
Fatta questa premessa, posso affermare che per “Viandanze” ci fu una partenza sufficientemente coesa da poter rassomigliare ad un lavoro di gruppo, ma, in seguito, la disponibilità dei componenti si rivelò irregolare, fino a sbriciolarsi definitivamente. Non è una critica diretta ai miei collaboratori, anzi, non posso dare loro torto visto che l’attività del musicista non è più inserita nel libro di paga delle professioni. Si tratta quindi di pretendere impegno e costanza senza relativo compenso. Mi sono trovato più volte a cavalcare due ruoli differenti, quello dell’artista e quello del manager/produttore e posso assicurarti che è un incubo.
Tuttavia, tornando alla tua domanda, posso confermare che in “Viandanze” si avverte una sorta di alchimia, anche se approssimativa, che sembra il risultato di una formazione pseudo-Prog. Mi viene da sorridere, però, al pensiero che tutti i partecipanti all’album (meno uno) si ritrovarono per la prima volta insieme soltanto in occasione del concerto del 4 novembre 2015 al Teatro del Lido, insieme alla cantante siberiana Choduraa Tumat.
Per “Giordano Bruno”, quindi, pensai fosse utile ridurre i ranghi per incorrere in meno imprevisti possibili (il bassista si era, nel frattempo, trasferito a Mosca e il batterista con cui avevo cominciato le registrazioni di “Giordano Bruno” aveva trovato lavoro allo Sheraton Hotel di Milano). Ma ci fu anche una scelta tecnica; per ottenere un sound più originale feci a meno della chitarra elettrica. Orientai quindi la natura sonora degli O.A.K. su di un versante folk/sinfonico e la mossa si rivelò azzeccata, considerando che facemmo a meno del discepolo di Fripp, membro della The League of Crafty Guitarists, Al Bruno. Alla fine, disponibili rimanevamo io e il pianista Francesco De Renzi ma, fortunatamente, in seguito, si verificò un’escalation di collaborazioni che incrementarono lo spessore dell’album. Mi riferisco all’onnipresente David Jackson e a Richard Sinclair, Maartin Allcock, Sonja Kristina, Jenny Sorrenti, Derek Wilson e altri.
Nel terzo ed ultimo capitolo della trilogia accettai, invece, la sfida di realizzare un buon album nonostante l’assenza di questo o quello e facendo addirittura a meno del drumming di un batterista in carne ed ossa. In realtà parecchio del materiale registrato con special guests, di cui non rivelo i nomi per fair play, fu cestinato. Oggi più che mai, a me interessa il risultato sonoro e non il nome da sbattere sulla copertina come richiamo per le vendite. Finii quindi per suonare, anche questa volta, quasi tutto l’album da solo, se si eccettua il solido e risolutivo lavoro al basso di Jonathan Noyce su otto dei nove brani dell’album, il sax di David Jackson sul finale di “Donna Prudentia”, un intervento pianistico di Daniele Fuligni sulla prima parte di “Dame Harvillers”, un breve intervento canoro da parte del soprano Tetyana Shyshnak su “Gioconna”, qualche vocalizzo su “Nadira” di Cristiana De Bonis, il contributo al testo di “Rebecca Lemp” da parte di Gerlinde Roth e poco altro. Ma quest’ultimo lavoro è il più definito dei tre e ciò a causa del lockdown seguito allo scoppio della pandemia di Covid. Avremmo dovuto presentare il nuovo album il 2 marzo 2020 all’Auditorium insieme ai Caravan ma l’evento fu cancellato. Una gran delusione, indubbiamente, ma ciò permise un lavoro di rifinitura extra delle tracce dell’album. Finalmente, dopo un’estate da batticuore, i vinili arrivarono e gli apprezzamenti delle riviste e siti Prog sparsi in tutto il mondo mi hanno riempito il cuore di soddisfazione. I maggiori encomi, infatti, continuano a pervenire da esperti di Prog sinora a me sconosciuti, giornalisti per i quali gli O.A.K. rappresentavano, fino a poco tempo fa, soltanto un grattacapo per l’omonimia con altri gruppi di livello internazionale ma ora quotano “Nine witches under a walnut tree” con valutazioni molto alte.
Tutta la tua carriera con il progetto O.A.K., comunque, è “impregnata” di elementi magici/esoterici/folkloristici. Ma cos’è che ti affascina davvero di queste tematiche e come riesci a convogliarle nelle tue creazioni (anche attraverso quell’alchimia di suoni e generi tipica del tuo sound)?
J.C.: Non possiedo alcuna formula segreta ed ho soltanto dedicato alla musica gran parte della mia vita. Quando si dice che il lavoro fatto con passione e volontà paga non è uno slogan ma la condizione imprescindibile per andare avanti e migliorare.
La vita è magia, basta viverla liberamente assecondando le proprie intuizioni. Non sono un esperto di esoterismo e non mi interessano le spettacolarizzazioni delle scienze occulte. La magia vive all’interno della natura, vibra delle sue trasformazioni e, nonostante la scienza provi a far luce su tutte le leggi che regolano l’universo, ci saranno sempre domande inevase. Anzi, a volte abbiamo la sensazione che più proseguiamo sulla strada della conoscenza, più ci perdiamo in interrogativi sempre più complessi. Poco tempo fa, Andrew Keeling, musicista, medium e curatore della biografia dei King Crimson, mi pose alcune domande sulle relazioni tra musica ed esoterismo. Non trovai di meglio che descrivere le immagini, elaborate dalla mia fantasia, che mi hanno accompagnato nella crescita e permesso di volare alto sulle miserie del mondo.
Già gli ultimi lavori prima di “Viandanze” ti avevano visto lavorare in solitaria, attorniato da straordinari collaboratori. Ora, con gli ultimi tre album, la tua figura di deus ex machina del progetto O.A.K. è emersa definitivamente. Quali vantaggi dà il poter contare solo su se stessi in fase compositiva?
J.C.: Il destino ti orienta verso questa o quella direzione. Ho sempre avuto due strade davanti: quella della rassegnazione, che significava rimanere in attesa del momento magico da condividere in gruppo… rischiando di aspettare in eterno; o quella dell’intraprendenza, anche se in solitaria, che corrispondeva al tentativo di concretizzare le mie idee contando soltanto sui miei mezzi. Non posso certo obbligare qualcuno a rispettare un impegno, e alla base di ogni attività amatoriale o pseudo professionale c’è sempre la libertà di ognuno di cambiare idea e poter disporre del proprio tempo come meglio si crede. É evidente che, con tali presupposti, album come “Giordano Bruno” o “Nine witches under a walnut tree” non avrebbero mai potuto vedere la luce. Un discorso a parte, invece, va fatto per i contributi occasionali dei special guests.
Una caratteristica che, tra le tante, mi ha colpito molto positivamente nei tuoi lavori è quell’essenza tutta battiatiana di affrontare a testa alta liriche e canto in altre lingue (inglese, francese, latino, ecc.). Come avviene, di volta in volta, la scelta e dove nasce la necessità di esprimersi, in questi particolari frangenti, con parole che non siano nella tua lingua madre?
J.C.: Senza voler arrivare a scelte estreme come quella dei Sigur Ròs, posso affermare di provare un intenso piacere ad esprimere il mio canto con fonemi sconosciuti. Questo accade spesso nel momento dell’ispirazione. Dopodiché cominciano i dolori! Ho avuto molte indecisioni e difficoltà prima di riuscire a padroneggiare una lingua che esprimesse le liriche nei miei brani. Ho cantato in inglese, in italiano, in tedesco, in russo, in francese, in latino e persino in siberiano e sono ancora in fase sperimentale, proiettato verso la creazione di un’alchimia linguistica che rispecchi il mio “sentire” la musica.
Glenn Cornick, Clive Bunker, Barriemore Barlow, Jonathan Noyce, Maartin Allcock, Dave Pegg, Ian Anderson: tanti sforzi e, infine, lentamente, sei riuscito a collaborare nei tuoi album e a condividere il palco con i tuoi eroi. Emozioni?
J.C.: Sì, delle forti emozioni iniziali… poi, il sopraggiungere della consapevolezza che tutti respiriamo, mangiamo, defechiamo ecc…. e che soltanto l’impegno e l’esercizio continuo possono portare risultati… ovviamente dando per scontata la presenza di talento.
Un catalizzatore per artisti orientati verso nuove forme d’espressione. Un punto focale di scambio e condivisione di progetti artistici professionali: CraftyArtVenture. Ti va di spendere qualche parola su progetto?
J.C.: Un’avventura di cui sono particolarmente orgoglioso. Con già un sufficiente bagaglio di esperienze in campo manageriale e soprattutto artistico, nel 2014 provai a creare un sodalizio di artisti indipendenti con i quali esprimere forme d’arte libere e originali. Intorno avevamo il deserto, nulla che potesse far risplendere la parola Arte. In una Capitale avara di iniziative, il “fai da te” era, come sempre, il solo modo per bypassare i latifondisti della musica che avevano come scopo guadagni sicuri con il minimo sforzo ed attuavano politiche di controllo sugli approvvigionamenti statali, che poi si traducevano in zero investimenti. Soffrivo nel vedere tanti talenti privi di un’opportunità per emergere e decisi di dare il mio piccolo contributo per un cambiamento. Mi orientai verso un genere di proposte artistiche “trasversali” rispetto ai canoni, suddividendole in sei incontri tematici. Dalla Germania, da Milano, Napoli, Roma e dintorni arrivarono le adesioni di artisti che riempirono il cartellone degli eventi. Gli O.A.K. ebbero il ruolo di house band e, oltre a proporre la mia musica, accompagnarono le altre performance. Tutto questo fu possibile grazie al proprietario dell’Idea Factory coworking space Angelo Magni che mi aprì le porte del suo centro multimediale ad un costo minimo. Inoltre, il mio ringraziamento va al fonico Alfredo Fabbri e al gruppo dei miei collaboratori, senza i quali questa stupenda avventura non sarebbe stata possibile.
Cambiando discorso, il mondo del web e dei social è ormai parte integrante, forse preponderante, delle nostre vite, in generale, e della musica, in particolare. Quali sono i pro e i contro di questa “civiltà 2.0” secondo il tuo punto di vista per chi fa musica?
J.C.: Non posso che esserne strafelice. Il web “è ‘na livella” che in parte ridimensiona il divario tra ricchi e poveri, tra caste e gente comune. Mai scoperta fu tanto rivoluzionaria e siamo solo agli inizi. Ci sono, ovviamente, delle controindicazioni perché i “navigatori” andrebbero educati nel fare un uso corretto delle piattaforme digitali. Temo che, piuttosto che continuare a leggere i “Promessi sposi”, ci si debba attivare anche a livello scolastico con degli opportuni training sulle potenzialità della rete.
E quali sono le difficoltà oggettive che rendono faticosa, al giorno d’oggi, la promozione della propria musica tali da ritrovarsi, ad esempio, quasi “obbligati” a ricorrere all’autoproduzione o ad una campagna di raccolta fondi online?
J.C.: La leggenda narra che alle origini dell’industria musicale, le case discografiche mettessero sotto contratto ogni gruppo emergente nella speranza di bissare il successo che stavano ottenendo quattro ragazzi di Liverpool che, con le loro canzoni, stavano risollevando i destini della corona inglese. Questo accadeva nell’Inghilterra degli anni ’60, ma il vero faro per i nuovi prodotti musicali di quegli anni erano gli U.S.A., vincitori del secondo conflitto mondiale. Un super business, legato al fenomeno musica, modellava sogni, aspettative e tendenze del popolo giovane. Ai gruppi che affioravano dall’underground veniva dato un lauto anticipo ed accadeva, molto più spesso che non il contrario, che i soldi finissero senza aver acquistato alcuna strumentazione o registrato neanche un demo. A quel punto il gruppo inadempiente cambiava casa discografica e giù con un altro anticipo! Those were the times!
Fare un paragone a distanza di più di cinquanta anni non avrebbe senso. È tuttavia fuori di dubbio che tutti i profili professionali che in passato orbitavano intorno ad un progetto musicale sono spariti ed è la figura del self artist che oggi predomina la nuova scena.
Qual è la tua opinione sulla scena Progressiva Italiana attuale? C’è modo di confrontarsi, collaborare e crescere con le nuove (e le vecchie) leve?
J.C.: Rispondevo recentemente alla domanda di Cousin Hub della rivista Prog francese Koid9 sul tema relativo ad una presunta scena Prog Italiana, prolifica, collaborativa e amichevole. E spiegavo che, nonostante io abbia rapporti d’amicizia con molti esponenti del Prog in Italia, nelle poche occasioni che abbiamo di incontrarci condivido con loro dei momenti iniziali molto piacevoli ma i restanti si rivelano sempre piuttosto monotoni. Inevitabilmente si devia sulle solite lagnanze: l’impoverimento dell’arte, la mancanza di investimenti, c’era una volta, le sale sono vuote, ai tempi miei ecc…. Sarà un caso, ma raramente sono riuscito a concretizzare qualche collaborazione con qualcuno di loro. Denoto molta discontinuità e carenza di concentrazione. La mia storia musicale è cominciata quando, molto precocemente, ho scoperto il rock romantico inglese negli anni ’70 e da allora sono rimasto sempre orientato verso quelle latitudini. Inoltre, io appartengo alla generazione X, il che significa che sono troppo giovane per la vecchia scuola ma troppo vecchio per il re-make del nuovo millennio. Dalle mie parti quelli della mia età sono come gli unicorni. Ne siamo rimasti pochi, decimati dagli anni di piombo, dall’eroina di stato, dalla follia causata da viaggi lisergici andati male e, infine, dall’AIDS. Tuttavia, conosco bene le vecchie e nuove realtà del nostro paese ma sembra che quest’ultime finiscano sempre per rimanere schiacciate dal cliché che determina le band anni ’70 migliori delle altre. Qualcuno accenna addirittura ad una sorta di caporalato! Quindi, un presunto clima collaborativo e amichevole in seno al movimento Prog Italiano è alquanto improbabile. Dissento, invece, categoricamente quando ho conferma di come nel nostro paese valga più un arruffianamento che dieci capolavori di fila. La differenza dovrebbe farla allora il pubblico con ascolti attenti e un rinnovato interesse per le novità. Ma temo che ormai alla musica le si riconoscano soltanto gli aspetti ludici ed evocativi. Bisognerebbe quindi sperimentare nuove contaminazioni perché le sette note, da sole, hanno perso di incisività e il pubblico è anestetizzato. Per il Prog il discorso non cambia, anzi… e forse, allora, ha ragione Steven Wilson quando afferma che la musica Progressive è morta. Ma allora entra in gioco la magia del web con le sue straordinarie potenzialità. Diventa quindi non più un gioco di quantità ma di qualità, sia musicale che di ascoltatori perché la differenza, sostanzialmente, la fa chi ascolta. Soltanto allargando gli orizzonti si può sperare di ottenere un raggio d’azione più vasto entro il quale i miracoli tornano ad essere possibili.
Esulando per un attimo dal mondo O.A.K. e “addentrandoci” nella tua vita, ci sono altre attività artistiche che svolgi nella vita quotidiana?
J.C.: Scrivo e provo a produrre brevi filmati con mezzi economici e con tecniche approssimative.
E parlando, invece, di gusti musicali, di background individuale (in fatto di ascolti), ti va di confessare il tuo “podio” di preferenze personali (escludendo i Jethro Tull)?
J.C.: I miei ascolti musicali sono tra i più disparati. Come background, però, partirei ovviamente dai mostri sacri: Genesis con Gabriel, King Crimson, VdGG, ecc.… ma anche Portishead, il povero Jeff Buckley ed altri artisti praticamente sconosciuti.
Restando ancora un po’ con i fari puntati su di te, c’è un libro, uno scrittore o un artista (in qualsiasi campo) che ami e di cui consiglieresti di approfondirne la conoscenza a chi sta ora leggendo questa intervista?
J.C.: Io proverei a leggere e ad ascoltare di tutto. La curiosità e la ricerca sono imprescindibili per vivere una vita ad occhi aperti. Dopo di che, ciò che maggiormente risuona dentro… lo custodirei come un tesoro.
Chitarre, tastiere, flauto e tanto altro: ma qual è lo strumento che ami di più e che più ti rappresenta?
J.C.: Amo tutti gli strumenti perché in ognuno di essi c’è l’essenza della magia dei suoni. E come per l’interrogativo su quale lingua usare per cantare le mie canzoni, anche per la scelta di uno strumento musicale mi sono imbattuto in un gran rebus. Alla fine la soluzione è stata: usarli tutti!
Ma se per qualche motivo ne dovessi scegliere soltanto uno, provo ad immaginare il suono di una cornamusa che mi accompagnerà, il giorno quando chiuderò gli occhi, nel luogo dove appartiene il mio spirito.
Tornando al giorno d’oggi, alla luce dell’emergenza che abbiamo vissuto (e che stiamo ancora vivendo), come immagini il futuro della musica nel nostro paese?
J.C.: Starei cercando di abbattere ogni frontiera e di sentirmi ora più che mai un cittadino Europeo. Nel vecchio continente sono avvenuti i più cruenti scontri territoriali, le più grandi invasioni e le più lunghe dominazioni della storia. Come stormi d’uccelli impazziti, i popoli sono dilagati lungo le terre d’Europa ed è ormai inesatto analizzare un fenomeno circoscrivendolo ad un singolo paese UE. Apparteniamo ad una stessa storia che ha plasmato nei secoli culture e tradizioni. Forse la mia è solo una speranza ma spero che presto potremo unirci in un’unica identità. Libero scambio e libere possibilità di condivisioni musicali. Soltanto uniti possiamo sopravvivere artisticamente.
A quasi tre decenni dall’avvio del percorso O.A.K., dalle prime formazioni (con i vari avvicendamenti interni) al Jerry Cutillo= O.A.K., ti va di trarne un primo bilancio? E, prima di salutarci, c’è qualcos’altro che ti va di condividere sulla tua lunga ed incredibile carriera?
J.C.: Quello degli O.A.K. è un percorso inarrestabile. Qualcosa che fin quando avrà luce, continuerà ad esistere. Questo gruppo vive d’ispirazione, di confronto, di forza nel volersi affermare come realtà artistica libera e indipendente. Rappresenta una finestra sul mondo che ci arricchisce e ci fortifica e il contribuito dato da tutti i suoi membri ha permesso l’aggregazione delle nostre energie con altre monadi artistiche per sviluppare progetti, focalizzare e realizzare traguardi.
E per chiudere: cosa prevede il futuro di Jerry Cutillo/O.A.K. e “Nine witches under a walnut tree”?
J.C.: Il viaggio nel tempo è già cominciato.
Grazie di cuore Jerry!
J.C.: Tante grazie a te Donato, mi sento spremuto ma felice. Alla prossima uscita.
(Dicembre, 2020 – Intervista tratta dal volume “Dialoghi Prog. Il Rock Progressivo Italiano del nuovo millennio raccontato dai protagonisti“)








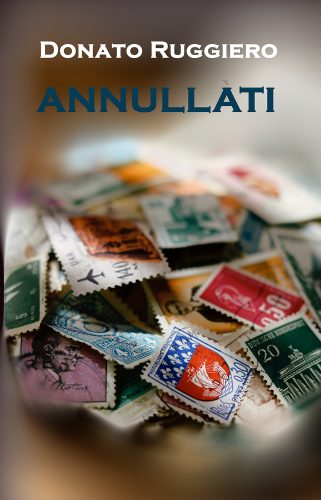
Lascia un commento