 Un caro benvenuto ad Abele Gallo (A.G.), Pietro Li Causi (P.L.C.), Benedetto “Benny” Marano (B.M.), Ambra Rinaldo (A.R.) e Salvatore Sinatra (S.S.): il castello delle uova.
Un caro benvenuto ad Abele Gallo (A.G.), Pietro Li Causi (P.L.C.), Benedetto “Benny” Marano (B.M.), Ambra Rinaldo (A.R.) e Salvatore Sinatra (S.S.): il castello delle uova.
A.G.: Ciao, e grazie per l’attenzione.
P.L.C.: Ciao Donato! Grazie per questa opportunità!
B.M.: Buongiorno, anche a tutti i lettori!
A.R.: Grazie Donato, è un piacere!
S.S.: Ciao Donato, è un piacere anche per me.
Iniziamo la nostra chiacchierata dalle origini: come nasce il progetto il castello delle uova (articolo “il” volutamente minuscolo)? E cosa c’è prima de il castello delle uova nelle vite di Abele, Pietro, Salvatore e Benedetto (quest’ultimo entrato molto presto nella band)? Ad esempio i BraindeaD…
A.G.: il castello è una famiglia che nasce all’interno della grande famiglia dei BraindeaD. Siamo cresciuti insieme… era il lontano 1991 quando abbiamo iniziato. I BraindeaD erano e rimarranno sempre un gruppo che va al di là della semplice condivisione di musica, palchi, studi di registrazione e idee; non a caso non abbiamo mai messo una pietra tombale su quel progetto, e non è detto che nell’immediato futuro post-Covid non si torni a fare qualcosa di nuovo (o di vecchio!) insieme. Chissà. Le scelte di vita di ognuno di noi, i problemi di carattere logistico, le distanze e una sorta di andamento lento nella realizzazione delle nostre cose ci hanno portato a prenderci sempre tempi molto lunghi.
il castello delle uova nasce da una visione diversa dei concetti e della musica, qualcosa che va di pari passo con la carta d’identità e con pulsioni differenti figlie di esperienze varie; in tal senso, aver incontrato musicisti con un background diverso dal progetto precedente ci ha permesso di sviluppare le idee che compongono i nostri due album. Chiaramente il periodo con i BraindeaD è qualcosa che rimane ancora flusso vitale nelle nostre vene.
P.L.C.: La scelta del minuscolo è legata alla nostra idea di non prenderci mai troppo sul serio. Quanto al passato, c’è tanta roba, direi. Soprattutto i BraindeaD, lo ha già detto Abele. Per circa dieci anni io, Abele e Salvatore abbiamo suonato insieme in quel gruppo come se non ci fosse un domani. Eravamo una live band niente male e proponevamo solo brani di nostra composizione. Peccato che di tutto quello che abbiamo composto insieme sono uscite – nel 1998 – solo le sei tracce di “Ombre ancora luci”, che è stato ristampato recentemente in digitale su Bandcamp. In realtà, più volte abbiamo discusso di tornare insieme in studio per incidere i brani più vecchi, che erano in lingua inglese. Chissà!
Poi, fra i BraindeaD e il castello delle uova, c’è stata, per me, la brevissima esperienza dei No! Ici Naif!, un gruppo noise che avevo formato con Ambra, suo fratello Ivano e la nostra splendida amica Maria Teresa Cucchiara, oggi mamma a tempo pieno negli USA.
S.S.: Ho suonato sin da ragazzino in diversi gruppi musicali anche con un discreto successo a livello locale. Ancora oggi ho una band blues alla quale non rinuncerei per nulla al mondo. Nel 1991 ho incontrato Pietro e Abele, e con loro, assieme a Maurizio Mannone e Nicola Ratto, costituimmo i BraindeaD. Fu l’inizio di una storia lunga trent’anni e che, a seguito di peripezie diverse, è sfociata nel castello delle uova. Ci accomunava, oltre ad una vera amicizia, la consapevolezza di potere fare qualcosa di nostro, comporre (finalmente!) e non scimmiottare la musica degli altri. Ho sempre visto il castello delle uova come una sorta di evoluzione di quel gruppo. È nato, in fondo, dall’esigenza di assecondare il nostro personale percorso di crescita artistica. Diciamo che forse è un progetto meno… tosto di quello dei BraindeaD ma certamente più maturo e imperniato su una ricerca artistica più originale.
B.M.: Io sono arrivato poco dopo i primissimi inizi del progetto, anche se, in prima battuta, come collaboratore esterno, per così dire. Avevo solo prestato la mia voce per recitare il testo del primo disco. Ma è durato poco. È venuto subito naturale considerarmi ed essere considerato come parte attiva di tutta l’impresa.
Prima del castello, nella mia vita c’era molto teatro; sono stato anche direttore del “Gebel Hamed”, un teatro di Erice. Ma c’erano stati anche altri progetti musicali, uno di questi era molto simile al castello delle uova: si chiamava Moelstrom ed era un insieme di musiche originali, composte dal mio compare Salvo Buffa, e di poesie (mie e non solo) recitate da me. L’insieme era molto suggestivo, anche per via del fatto che le musiche di Salvo, oltre ad essere originali, spaziavano molto e in molti campi, ottenendo, appunto, un effetto Moelstrom davvero unico. Immaginatevi una poesia recitata su una base reggae o elektropop, o ispirata al grande maestro giapponese Nobuo Uematsu, o alle atmosfere di Kenji Kawai, e avrete una mezza idea di cosa si trattava. Poi è arrivato il castello con tutte le sue uova…
il castello delle uova: come nasce il nome e qual è il suo significato?
A.G.: Come spesso capita con le idee che hanno a che fare con i testi e con tutto ciò che riguarda la dimensione concettuale, è il nostro caro Pietro l’artefice. Averlo in famiglia è un valore aggiunto, anche se ognuno di noi, per diversi motivi, è importante e ha un ruolo ben preciso.
P.L.C.: Sì, è così. Nel gruppo ognuno di noi gioca un ruolo importante. Contribuiamo tutti alla costruzione delle trame sonore e alla composizione. Poi, finito il lavoro musicale ognuno di noi si divide il resto: ufficio stampa, grafica, ufficio legale, live agency.
L’idea del nome è stata mia ed è il frutto di una sorta di folgorazione, o di un volo pindarico, se vogliamo. Era un giorno d’estate. Avevo appena finito di ascoltare un album dei King Crimson – credo fosse “The ConstruKCtion of Light” –, e dopo avevo rivisto “Io e Annie”. Nel monologo finale di quel film, dopo avere incontrato Annie per l’ultima volta, Woody Allen racconta la barzelletta dell’uomo che va dallo psichiatra cui comincia a parlare del fratello pazzo che si crede una gallina. Lo psichiatra gli propone di internarlo e l’uomo allora gli risponde: “e poi a me chi me le fa le uova!”. Ecco, in quell’istante si è creato un corto circuito che mi sembrava perfetto: la corte del re Cremisi mi aveva fatto pensare a un castello con tanto di ponti levatoi, mura, contrafforti; la battuta di Woody Allen, invece, mi suggeriva di associare, a quella immagine di solidità e pesantezza, un’immagine ironica di leggerezza e, insieme, di fragilità: dalle uova nasce la vita, ma il guscio che dovrebbe proteggerla si può rompere con una facilità estrema.
Il caso poi ha voluto che il giorno dopo, sul tavolo della biblioteca dove ero solito studiare, qualcuno avesse lasciato un’edizione italiana dei frammenti orfici curata da Graziano Arrighetti. Mi ci sono tuffato dentro e ho scoperto che nella tradizione orfica l’uovo è l’origine della vita e dell’universo. Da lì l’idea del poema cosmicomico che ha dato il titolo al nostro primo album: “Appunti sonori per una cosmogonia caotica”.
B.M.: Beh, io non c’ero ancora quando il nome è stato creato. Comunque mi viene facile associarlo al termine e al concetto richiamati dalla parola araba Kalaat… “castello”, appunto, che dà anche il nome a molti paesi siciliani: Calatafimi, per esempio – che un altro dei nostri luoghi dell’anima, dove si trova una casa di famiglia di Pietro –, o Caltanissetta. il castello delle uova, come ci piace ricordare, non è solo uno spazio fatto di pietra, forte, protettivo e inespugnabile, ma anche un luogo aperto e accogliente all’interno del quale si può prosperare e pensare al futuro.
S.S.: Il nome comunque suonava piuttosto bene. Direi meglio di BraindeaD, che può significare sia “morte cerebrale” che, in slang, “scimunito”. Diciamo che il nuovo nome è frutto di una visione più articolata e matura di quello che vogliamo dire al mondo. Il ciclo della vita e della fragilità che ci circonda, poi, in fondo è il motore anche del nostro secondo lavoro.
La prima di una delle varie “scelte radicali e controcorrente” che caratterizzano il gruppo riguarda l’aspetto live: sin dalle origini decidete di non calcare i grandi palchi, di non partecipare a raduni e festival e di non suonare nei club e nei pub. In polemica con certe forme di estetica rock, definite allora “pornografiche” da parte di alcuni suoi membri, il gruppo si sarebbe esibito soltanto nei teatri o en plen air rigorosamente al tramonto o all’alba. Quali sono, dunque, queste forme di estetica rock “pornografiche” che vi hanno spinto a tale decisione?
A.G.: Facendo il musicista di mestiere non posso negare di aver provato emozioni forti nei vari live che hanno caratterizzato la mia vita artistica; un pizzico di vanità deve scorrere necessariamente nelle vene di un artista. Con i castellani non abbiamo avuto la necessità di ragionare troppo a lungo su questo modo, diciamo così… “alternativo” di apparire; è stata una scelta naturale, che è nata da quella alchimia che si taglia con il coltello ogni volta che ci si vede in presenza o, ultimamente, anche durante le varie call conference. Non è un modo per apparire sofisticati a tutti i costi. Se volessimo realmente esserlo, in fondo… ci sarebbero tanti modi per farlo.
P.L.C.: Quando ero ragazzino ascoltavo prevalentemente musica heavy metal. Ad un certo punto della mia vita, però – diciamo dopo la scoperta del grunge e del Rock Progressivo –, mi sono reso conto di quanto quella musica fosse intrisa di una forma di machismo fascistoide. Se il rock delle origini – quello dei Led Zeppelin e dei Rolling Stones, per esempio – era stato portatore di un messaggio di liberazione, negli anni ’90 la scelta di certi suoni e di certe pose che vedevamo attorno a noi ai festival e ai raduni, ai quali ci capitava di partecipare, avevano cominciato a darmi sempre più fastidio. Non mi piacevano gli atteggiamenti divistici delle rockstar mainstream, e ancora meno mi piacevano i loro scimmiottamenti da parte di certe band di provincia che ci capitava di incrociare sui palchi. Già con i BraindeaD noi eravamo altro rispetto a tutto questo, ma con il castello delle uova avevamo deciso di marcare in maniera ancora più esplicita questa alterità.
Dagli anni ’80 in poi la dimensione visuale – che io allora chiamavo “pornografica” – della musica era diventata sempre più iperbolica e vampirizzante, e orientava l’attenzione e i comportamenti di chi la ascoltava verso formalismi sempre più svuotati della sostanza liberatrice delle origini.
Devo poi dire che della musica io ho sempre amato proprio l’immaterialità, la dimensione concettuale, pre-linguistica e pre-visiva. È anche per queste ragioni che, in prima battuta, abbiamo deciso di sparire dalle scene usuali e di cercare dimensioni più intime e raccolte. I primi live che abbiamo fatto sono stati all’aperto, su invito e solo per i nostri amici più cari e per i loro amici.
Confesso poi che non ho mai retto fino in fondo una certa dimensione notturna del rock. Odiavo rincasare alle cinque del mattino dopo i concerti dei BraindeaD e poi rimanere completamente stonato e sfatto per i giorni immediatamente successivi. È per questo che ho proposto di organizzare i nostri eventi dal vivo sempre al tramonto, nell’ora in cui la luce lascia spazio al buio, nell’ora in cui tutto ciò che è vecchio sta per scomparire dalla faccia della terra, ma il nuovo non è ancora iniziato. Ai nostri occhi, era più suggestivo, più vero, e permetteva a chi ci ascoltava di fare spaziare lo sguardo non solo sui nostri strumenti e sui nostri corpi – che non sono un gran che, diciamocelo! –, ma sulla luce che cambia, sulle piante, sul paesaggio.
Lo spettacolo del rock’n’roll, negli anni, aveva creato corpi da idolatrare, noi volevamo essere solo parte di un cosmo in perenne mutamento.
S.S.: Credo che la dimensione teatrale del castello sia fortemente legata, come ha detto Pietro, alla distanza che sentiamo di avere nei confronti dell’estetica del rock. In fondo anche i BraindeaD erano così, ma forse eravamo ancora troppo timidi e troppo giovani per ammettere di non essere attratti dai grandi raduni e dalle masse rumorose. Come dice Abele, il nostro lato narciso aveva il sopravvento. Quando abbiamo creato il castello abbiamo capito che una dimensione più raccolta per l’ascolto delle nostre esibizioni fosse quella ideale. Del resto, avevamo smesso di suonare canzoni ed avevamo iniziato… a registrare sensazioni. La nostra musica era diventata fluida e farcita di improvvisazione continua. Non come nelle jam session del jazz, tuttavia. Era una improvvisazione senza temi, del tutto legata a sensazioni del momento. Tutto questo ha bisogno di esprimersi in contesti estremamente empatici dove il rapporto con il pubblico è esso stesso strumento creativo. Per questo la scelta dei piccoli contesti e delle sale di registrazione.
Altra scelta inconsueta: niente testi cantati ma solo recitati. Come mai?
A.G.: Rispetto al precedente progetto sentivamo l’esigenza di un cambio di marcia. Non rammento bene come sia nata l’idea; ricordo però che, quando la parte musicale era in nuce, non abbiamo avuto alcun dubbio sul fatto che i testi potessero risaltare al meglio con la recitazione in luogo del canto. Quella fase che Pietro chiama “post-prog”, espressione che – devo dirlo – non amo fino in fondo, essendo un amante del Prog classico… quella fase che Pietro chiama “post-prog”, dicevo, si associa, secondo il mio parere, a un tipo di comunicazione che non debba necessariamente prevedere l’utilizzo di note cantate, soprattutto in un progetto come il nostro.
P.L.C.: Con i BraindeaD avevamo raggiunto un affiatamento incredibile. Ci bastavano due note messe in fila a caso per creare su due piedi strutture complesse di brani. Verso la fine di quella storia avevamo però l’impressione che ogni linea di canto che partorivamo fosse già sentita. Insomma, non eravamo mai soddisfatti dei risultati e avevamo cominciato a sentire il bisogno di un cambiamento drastico.
L’idea della recitazione mi era venuta dopo un’esperienza negli USA. Ho passato lunghi periodi, dal ‘96 al ‘98, a Providence, nel Rhode Island. Con un mio caro amico americano, Raymond Marks, bassista, abbiamo messo su un duo free jazz. Una nostra comune amica francese, regista, ci ha proposto di fare da colonna sonora dal vivo per l’adattamento teatrale degli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau che aveva organizzato per i suoi studenti. Mi sono divertito moltissimo e mi sono accorto di quanto sganciare la voce dalle costrizioni della melodia potesse sprigionare la libertà degli strumenti di sottofondo e aumentare l’intensità drammatica della musica e la pregnanza stessa delle parole. Tornato in Italia dopo quel periodo, proposi la cosa al resto della band. È stata una proposta divisiva. Capisco che in un certo senso ha decretato lo scioglimento – forse momentaneo, diciamocelo! – dei BraindeaD, ma è stata anche l’origine del castello delle uova. A quel punto io, Salvatore e Abele abbiamo contattato Benny, che, fra le altre cose, aveva avuto un passato anche in un gruppo posse trapanese, i TP Posse, e che soprattutto aveva importanti esperienze teatrali. Ci piaceva molto per la sua presenza scenica, il suo senso del ritmo e… per i suoi gusti musicali.
B.M.: Perché il testo recitato? Perché non so cantare… (ride). No, a parte gli scherzi… io vengo dal teatro e poi, come ho detto, avevo già fatto cose del genere. Inoltre, il testo del primo lavoro, essendo una cosmogonia, non era, per sua natura, un testo ortodosso per canzoni ortodosse, ma un testo eterodosso eseguibile solo in modo eterodosso.
S.S.: In realtà, nell’ultimo album una breve linea cantata l’abbiamo inserita. E poi la scelta non è affatto inconsueta, almeno se si considerano le esibizioni del castello come delle pièces teatrali, più che come concerti rock. Diciamo che il cambio di prospettiva a cui abbiamo dato luogo nel primo album rendeva naturale sperimentare nuove forme espressive, anche attraverso la rinuncia al canto. Non escludo che in futuro potremo tornare ad utilizzare linee di canto, appena avremo superato quel senso di banalità cui accennava Pietro. Del resto, in fase di mixaggio de “L’enigma del capitale”, abbiamo scelto di utilizzare le voci parlate come se fossero veri e propri strumenti della band, lavorando sull’effettistica a volte in maniera esasperata. L’idea è quella di ottenere un impasto sonoro di cui la voce recitata è parte integrante ed integrata. Insomma, uno strumento come gli altri, anche se non si esprime attraverso la produzione di note, ma attraverso i toni del recitato.
È il 2001 quando, in occasione di un secret live nella campagna siciliana, registrate il vostro primo lavoro “Appunti sonori per una cosmogonia caotica”, da voi stessi definito un’opera tentacolare e magmatica al confine fra musica, teatro e poesia, che fonde forme estreme di free-jazz con il rock. Vi va di raccontare la genesi dell’album? Quali sono state, dunque, le fonti d’ispirazione sonore che vi hanno “aiutato” nella sua creazione?
A.G.: Le ispirazioni, ascolti a parte, sono nate dalla scelta di sofisticati marchingegni che Pietro e Salvatore utilizzavano alle prove. Fino a qualche anno prima erano gli amplificatori e le valvole a farla da padrone; le varie loop station e i suoni di tastiera che avevamo cominciato ad apprezzare grazie all’ascolto dei Dream Theater nel periodo di Kevin Moore hanno ampliato il modo di pensare la musica. L’idea del testo recitato si è incastrata alla perfezione e ci ha permesso di considerare l’utilizzo della tromba di Aldo Bertolino, un bravissimo jazzista marsalese, che faceva da controcanto a una chitarra che diventava… delfino. Sì… questo era proprio l’effetto che mi faceva allora la chitarra di Pietro: era proprio un delfino! Mi ricordo che, mentre Salvatore faceva le tessiture sonore, lui giocava a creare tutti questi suoni ultra-acuti mettendo dei pitch shifter a catena. È stato davvero un bel periodo di sperimentazione, quello!
P.L.C.: Un po’ di cose te le abbiamo già raccontate. A distanza di anni non so dirti quali siano state le fonti di ispirazione sonore che ci hanno guidato. Ognuno di noi ascolta veramente di tutto, dai Sonic Youth a Rita Payes, da John Coltrane ai Black Sabbath, da Gilberto Gil ai Fontaines D.C. La nostra idea, allora, era quella di non assomigliare a nessuno, di spiazzare completamente l’ascoltatore e di mescolare ogni cosa… sicuramente c’era, alla base, una concezione totale della musica che può forse ricordare, nella fusione fra jazz, rock e registri colti, quella degli Area. A influenzare il modo in cui suono, però, oltre che gli ascolti che faccio, ci sono gli strumenti e gli effetti che uso. In genere, l’ambiente tecnologico all’interno del quale ti muovi in qualche modo orienta le scelte che fai.
Nel caso degli “appunti sonori”, io e Salvatore – come ha detto Abele – stavamo facendo i nostri primi esperimenti con le loop station. Allora io usavo un Akai Headrush E1, che mi permetteva di registrare dal vivo fino a trenta secondi di base su cui poi improvvisavamo. Un ruolo importante sicuramente è stato giocato dall’idea della commedia dell’arte: con Salvatore avevamo fissato cinque loop di tastiera pre-registrati che, assieme al testo fisso dell’attore, facevano da canovaccio e segnavano il passaggio da un atto all’altro della recitazione. Su questi loop, che erano fissi, si andavano a innestare i loop di chitarra che venivano creati sul momento e su cui il resto del gruppo improvvisava. Ogni live che facevamo aveva solo questi elementi ricorrenti e sempre uguali; per il resto, tutto era in continua mutazione. Non abbiamo mai fatto un concerto simile all’altro.
S.S.: Per la verità l’album fu inciso prima dei live, anche se è stato poi pubblicato e distribuito anni dopo. Fu appunto quel segnale netto di rottura che avevamo deciso di dare: costruire qualcosa che nascesse direttamente dentro lo studio di registrazione, sulla base dei frammenti preregistrati delle mie tastiere che fungevano, appunto, da sipario sonoro tra un atto l’altro. Non era la prima volta che ci cimentavamo in uno studio di registrazione, ma era la prima volta (anche per il fonico dello studio) che decidevamo di destrutturare totalmente il classico modo di registrare un album: volevamo creare una traccia sporca, ininterrotta e non priva di errori ed imprecisioni, purché fosse vera. Naturalmente iniziammo e finimmo in meno di un’ora, ma la fase di produzione dell’album la ricordo ancora con nostalgia e terrore allo stesso tempo. Fu faticosa e complessa, anche per i mezzi tecnici dell’epoca che non consentivano di intervenire così pesantemente come oggi, grazie al digitale, sulle tracce registrate.
Il live a Calatafimi e, prima ancora, quello in villa Gallo, a Marsala, furono, per quanto mi riguarda, una liberazione. Almeno io li ho vissuti come un ritorno alla normalità dopo mesi rinchiuso dentro uno studio. Un’esperienza indimenticabile e bellissima.
I testi dell’album prendono spunto da diversi “mondi”, quali le storie naturali, la letteratura didascalica greco-romana, la tradizione orfica e la “Piccola Cosmogonia Portatile” di Raymond Queneau. Secondo quale processo questi temi sono diventati testi dei vostri brani? E cosa vi affascina di tali tematiche/opere?
A.G.: Il fatto di aver avuto come punti di riferimento gruppi italiani e stranieri le cui tematiche erano molto profonde e avevano radici negli studi, nelle letture e negli approfondimenti fatti in tanti anni di esperienza, ha influito sulla modalità di concepire un testo per un’opera musicale. Avere poi nel gruppo uno studioso come Pietro, che fa anche il chitarrista (e che non ti fa pesare in alcun modo il suo infinito bagaglio culturale), è di certo qualcosa che arricchisce anche ognuno dei suoi singoli elementi.
P.L.C.: Abele, tu mi confondi… per qualcun altro (ride)! Diciamo che il mio bagaglio culturale non è affatto infinito. Anzi, forse è anche piuttosto settoriale. Sono un antichista. Nel momento in cui ho composto gli “Appunti sonori per una cosmogonia caotica” stavo scrivendo la mia tesi di dottorato. Lavoravo, allora, sulle dinamiche di trasmissione del sapere in relazione agli animali paradossali delle periferie del mondo conosciuto nelle storie naturali degli antichi (ad esempio, il martichoras). Gli “Appunti sonori” sono, per certi versi, il frutto degli scarti del materiale che andavo selezionando per il mio studio. Ci sono, qua e là, spunti presi dalle “Metamorfosi” di Ovidio, dalla cosmologia degli Stoici e degli Orfici, notizie di paradossografi come Antigono di Caristo o di naturalisti greco-romani come Eliano o Alessandro di Mindo. Alla base, poi, c’è l’idea che l’ordine del cosmo, sia solo apparente, e che derivi dalla semplice descrizione del caos e degli eventi casuali. Di Queneau riprendevo non tanto il gusto per la sperimentazione linguistica, quanto l’attrazione per l’ironia, la leggerezza e l’understatement… e poi c’è un piccolo cameo di uno dei personaggi degli esercizi di stile: un tipo di circa ventisei anni (era l’età che avevo quando abbiamo inciso!), con un cappello floscio con una cordicella al posto del nastro e con il collo troppo lungo. Questo è il processo… per il resto, ho sempre avuto una grande passione per i temi “cosmici” e “aurorali” e, in generale, per le storie mitiche di “origini della specie”. Amo alla follia le “Cosmicomiche” e “Ti con Zero” di Italo Calvino o le “Storie naturali” di Primo Levi, e mi fanno tuttora sognare ad occhi aperti le coloratissime copertine “cosmiche” degli Yes… “Fragile”, “Drama”, “Tales from Topographic Oceans”, robe così.
B.M.: Molte delle cose di cui si parla negli “Appunti Sonori” le ho scoperte grazie… agli “Appunti Sonori” e a Pietro, che ne è l’autore; e devo dire che le tematiche trattate sono molto affascinanti. L’elaborazione di cosmogonie, più o meno complicate, fa parte della natura e delle origini di tutte le civiltà e di tutte le società, anche la nostra, per cui sono per così dire congenitamente necessarie. Noi abbiamo scritto la nostra che probabilmente… è quella giusta (ride).
S.S.: Beh! I testi sono appannaggio di Pietro; noi ci limitiamo a metterli in scena, ad arrangiarli tutti insieme. C’è comunque un comune sentire nel pensare la complessità del mondo attraverso i luoghi della fantasia e della letteratura. Diciamo che lo lasciamo fare (risata grassa!).
P.L.C.: Esatto (ride)! Ma devo portare una piccola correzione… In realtà i testi nascono quasi sempre dopo. Prima lavoriamo tutti insieme alla musica, poi in genere mi faccio carico di buttare giù qualcosa di scritto. Era così anche al tempo dei BraindeaD. Nell’ultimo album, però, anche Benny ha scritto due testi, quelli di “Distruzione creatrice sulla terra” e di “Uno sguardo dalle macerie”. In questo caso, per quello che ricordo, è avvenuto il processo contrario, perché abbiamo adattato la musica ai testi che lui ci aveva proposto.
Altra “stranezza”: l’album è registrato nel 2001, pubblicato nel 2005 e distribuito nel 2007. Come mai questo frazionamento temporale?
A.G.: Come dicevo prima, sin dal periodo dei BraindeaD abbiamo sempre avuto tempi molto lunghi; uno dei nostri brani di punta di allora, “Il Deserto”, lo abbiamo terminato dopo nove mesi, una vera e propria gestazione. Le distanze e la difficoltà di vederci frequentemente con gli strumenti in mano hanno dilatato ulteriormente i tempi materiali del nostro lavoro, fermo restando che si è cercato di portare avanti il progetto contestualmente a situazioni di vita quotidiana, difficoltà, amarezze, qualche gioia, lavoro e famiglia. Personalmente (e onestamente) ho sempre procrastinato molte cose pensando di poter avere tutto il tempo possibile; adesso che l’anagrafe comincia a essere impietosa sto accelerando il passo e mi auguro che eventuali progetti futuri del gruppo non vengano messi in stand by a causa della mia cronica… malavita disorganizzata.
P.L.C.: In linea di massima, ci piace prenderci il nostro tempo. La fretta è tipica dei processi industriali e della produzione capitalistica, mentre il lavoro del castello delle uova è come il bozzolo del baco da seta. Si crea lentamente. Nella fattispecie, però, le ragioni di quella tempistica sono legate al fatto che pochissimo tempo dopo l’incisione degli “Appunti sonori” siamo stati travolti da una serie di eventi. Benny si era dovuto trasferire a Brescia per ragioni personali, io… stavo per diventare padre, e avevo vinto il concorso per l’insegnamento. La mia vita era cambiata drasticamente. Poi, nel 2005, abbiamo pensato che era davvero un gran peccato non pubblicare quello che avevamo inciso. Abbiamo stampato in quello stesso anno e per un po’ ci siamo limitati a regalare le copie agli amici che ci avevano ascoltati dal vivo. Poi, due anni dopo, abbiamo deciso che potevamo estendere la circolazione al di fuori della nostra cerchia. L’ascesa delle prime piattaforme social, come Myspace o Reverbnation, ci è stata di grande aiuto per vendere e distribuire in giro e per amplificare il messaggio che volevamo portare avanti.
Nel 2007, poi, avevamo cominciato di nuovo a provare con un nuovo attore e con un nuovo bassista, ma la chimica non era la stessa, e non siamo riusciti a cavare gran che di buono fuori. Dal 2008 al 2015 siamo stati di nuovo fermi. Ero diventato padre per la seconda volta, e dopo una fellowship di cinque anni all’Università di Palermo, ero tornato ad insegnare di nuovo a scuola. Le energie e le idee cominciavano a venire meno. Solo che noi, quando le energie e le idee vengono meno, non ci sciogliamo. Con Abele e Salvatore ci conosciamo da quando siamo ragazzini, e anche con Ambra, che è molto più giovane di noi, siamo praticamente cresciuti insieme. Questo ci aiuta a rimane sempre in contatto e ad attendere che ritorni l’urgenza che ci permette di creare roba nuova.
B.M.: Ecco sì… il frazionamento temporale. Che poi in realtà non è propriamente tale. A guardare da lontano si vede uno stacco di parecchi anni tra una fase e l’altra del progetto, ma a guardare da vicino salta all’occhio che gli anni non sono separati da una linea netta, bensì tenuti insieme, invece, dalle nostre stesse vite che hanno dovuto fare i conti con il mestiere di vivere senza per questo abbandonare il lavoro del sogno. All’apparenza questo ci ha portato via molto tempo ma, in realtà, è un salto illusorio.
S.S.: Direi la complessità della vita di ognuno di noi è la ragione vera. La distanza fisica rende tutto più difficile. Ho già detto che il lavoro in studio è stato lungo e complicato, nella gestazione degli “Appunti sonori”, e me lo sono sobbarcato quasi da solo, per ragioni di vicinanza fisica allo studio, per più di tre mesi. Comunque, condivido con i ragazzi questa specie di vocazione alla lentezza nel lavoro. Del resto, nemmeno “L’enigma del capitale” ha avuto un parto breve… è un po’ il nostro marchio di fabbrica. Il primo album l’abbiamo fatto mentre Pietro cambiava i pannolini a sua figlia, vorrà dire che il prossimo album lo faremo tra un cambio di pannolone e l’altro nostro! (altra grassa risata).
Una sola parola: “asparizione”. A voi carta bianca…
P.L.C.: La parola viene dal titolo di una poesia di Giorgio Caproni… è l’idea chiave attorno a cui ruotano due sue raccolte poetiche, “Il franco cacciatore” e “Il conte di Kevenhüller”. Nella fattispecie, indica la comparsa di qualcosa che scompare, o che – come la bestia del Gevaudan, o come il Dio della sua poetica teologia negativa – è presente laddove non c’è, nei vuoti, nei silenzi. Questa parola chiave mi sembrava perfetta per definire il nostro stato. La missione del castello delle uova è quella di creare storie in musica che alimentino l’immaginario di chi ci ascolta. Dopo la creazione seguono spesso, nella storia delle nostre vite, lunghi periodi di silenzio. Le band che devono obbedire alla logica capitalistica del produci-consuma-crepa non riescono a reggere i lunghi silenzi, e scompaiono. Noi, invece, aspariamo, ci siamo pur non essendoci, siamo presenti nell’assenza. Soprattutto siamo sempre presenti l’uno per l’altro, perché non è un rapporto economico o contrattuale quello che ci lega, ma una storia ormai più che trentennale di amicizia.
B.M.: Io, all’inizio, pensavo che Pietro avesse sbagliato a scrivere la parola “sparizione”. Sul serio. Poi quando sono stato liberato dalla mia ignoranza, ho capito e sposato l’importanza di questo concetto. In fondo qualsiasi attimo della nostra vita, preso singolarmente, “asparisce”, cioè compare per subito sparire, perpetuando la sua presenza solo con l’assenza. È solo nell’insieme, nel peso della loro massa, che gli attimi diventano tempo, e quindi flusso, e quindi presenza. Una cosa strabiliante: solo l’assenza crea presenza.
A.G.: Io ti devo fare una confessione: per parte mia amo associare giocosamente il termine “asparizione” al nome del papà di Pietro, il compagno Gaspare Li Causi, che tutti affettuosamente chiamano, in dialetto siciliano, “Asparinu”. Noi siamo anche molto giocosi… e per me l’asparizione ha anche a che fare con lui… che ha dato anche un importante contributo personale a “L’enigma del capitale”. Alcuni dei brani sono, infatti, tratti da interviste che Pietro gli aveva fatto per un archivio memoriale di famiglia. Quanto al resto, sì, asparire è quanto il castello ha fatto in più di vent’anni di vita artistica: esserci senza farsi vedere, materializzarsi per dissolversi in meno di un attimo lasciando comunque qualcosa di tangibile. Non so se sarà il leit motiv dei prossimi anni. È molto probabile che tutto rimanga com’è.
S.S.: Beh! Che aggiungere senza essere ripetitivo? In fondo, come dicevo prima, il concetto è strettamente legato alle scelte di vita che ognuno di noi ha fatto. L’esserci come gruppo per noi è sempre stato una normalità. Non ci siamo mai sciolti, non abbiamo mai pensato alla parola fine, eppure siamo rimasti invisibili a lungo. Questo ci ha tenuti uniti anche se inattivi, e nei nostri silenzi abbiamo continuato ad esistere.
Gli anni successivi all’uscita dell’album sono piuttosto duri e vedono un forte rallentamento del progetto causato da movimenti interni. Tocca attendere il 2015 per la ripartenza de il castello delle uova, la cosiddetta “Fase 2”. Ma la “fiamma” è sempre rimasta accesa…
A.G.: Il fuoco non si è mai spento nonostante lunghi periodi senza vedersi né sentirsi. Quando alla base c’è un rapporto che ha fondamenta solide, il tempo della frequentazione è relativo; in un modo o in un altro, si è sempre connessi e, in questo caso, la connessione non ha alcun elemento di carattere tecnologico. L’amicizia che ci lega è qualcosa di meraviglioso. Siamo come una famiglia dove tornare anche dopo lunghe camminate in solitario o con compagni di viaggio occasionali.
P.L.C.: Lo ripeto… a tenere accesa la fiamma c’è stato il nostro rapporto di amicizia. Dal 2008 al 2015 io, Abele e Salvatore ci siamo sempre visti fra noi e siamo sempre stati in contatto, sia pure solo telefonico. Ambra viveva fra Milano e Berlino, ma anche con lei ci sentivamo spesso. Anche se non abbiamo suonato, abbiamo sempre parlato di musica e abbiamo sempre cercato di immaginare cosa avremmo potuto fare se avessimo deciso di rimettere in moto la macchina. Per un po’, almeno io, avevo perso i contatti con Benny. Ci eravamo incontrati a Palermo poco dopo la nascita della mia prima figlia. Credo fosse nel 2003. Poi ci eravamo sentiti alcune volte per telefono, fino a perdere le tracce l’uno dell’altro per un periodo lungo di tempo… per via di una SIM mutata! Credevamo ormai di non avere più un frontman, e avevamo deciso che “L’enigma del capitale” avrebbe dovuto essere un album di musica strumentale, quando poi il destino ci ha messo lo zampino. Il giorno della prima prova ufficiale della nuova line-up mi sono visto Benny spuntare mentre scaricavamo gli strumenti per strada. È stata, diciamocelo, una cosa da film… mi sentivo dentro una trama di Frank Capra! La vita era veramente una cosa meravigliosa: Benny era venuto giù con la sua compagna per le vacanze di Natale e – dopo anni in cui non eravamo riusciti a sentirci al telefono – aveva incontrato la mattina prima, a Trapani, Abele, con cui aveva deciso di organizzare una sorpresa. A quel punto gli abbiamo spiegato l’obiettivo del disco e, io e lui, abbiamo cominciato, nel tempo, a buttare giù i testi.
B.M.: Beh, direi che a tenere viva la fiamma sia stata… la fiamma stessa. Anzi le fiamme: l’amicizia, la passione, la forza di un’idea giusta e la voglia di non “asparire” l’uno per gli altri.
S.S.: È il vantaggio della lentezza, del riuscire a fare le cose con i giusti tempi. Quando ci si rincontra è come se ci fossimo lasciati il giorno prima. A parte le dita arrugginite, tutto ricomincia senza alcuna interruzione.
Questa “rinascita” ha portato in dote un nuovo membro: Ambra Rinaldo. Ambra, cosa c’è nella tua vita artistica prima de il castello delle uova e come entri nella sua “orbita”?
A.R.: Entrare nel cosmo dell’enigma del capitale è un viaggio molto lungo, e comincia nel 1993, quando ero… la più giovane fan dei BraindeaD! Avevo dodici anni e li vidi suonare al primo concerto della mia vita… e che emozione quando il chitarrista notò la mia maglietta dei Pearl Jam! Devo moltissimo al mio fratellone Ivano in questo senso, sono cresciuta sgranocchiando tutta la musica che custodiva nella sua stanza… poi Milano, dove ho gironzolato dall’anno zero del millennio, fra l’Accademia di Belle Arti e il Teatro Arsenale…
Sono sempre stata onnivora (tranne che nell’alimentazione) e la mia ricerca è sempre stata trasversale, e ho trovato dei fondamentali punti chiave fra l’improvvisazione corporea in teatro, la pittura (per cui ringrazio Ivan Quaroni sempre) e la musica… In quegli anni, in cui bazzicavo l’opera lirica, la classica contemporanea e il teatro musicale contemporaneo (ho fatto una tesi su Mauricio Kagel, di cui ho un ricordo affettuosissimo!), ho avuto la fortuna di imbattermi in Nicola Arata, direttore dell’Ararat Ensemble Orchestra. Polistrumentista, mi ha insegnato a giocare con i generi formularici – funk, musica africana, tango, mazurka, reggae… – e con diversi strumenti e artisti che mi hanno insegnato moltissimo (i workshops con William Parker, Dave Burrell, Hamid Drake e tanti altri ancora dell’Amirani group sono stati momenti ma-gi-ci!).
La mia orbita è entrata in rotta di collisione con quella de il castello delle uova quando progettavo il mio rientro in Sicilia, ancora in movimento fra Milano, Marsala e Berlino, altra tappa fondamentale del mio percorso, in cui ho sviluppato la mia esperienza con musicisti di tutto il mondo e con degli incredibili e talentuosi producers… così abbiamo cominciato a registrare, fra un viaggio e l’altro, trovando dei momenti di coesione nelle vite frenetiche di tutti noi castellani.
E con la ripartenza riprende anche il vostro cammino live in cui, però, cedete in parte alla tentazione dell’estetica rock. Come mai questo cambio di rotta?
A.G.: Le origini non si dimenticano. Il fatto di aver esplorato nuove dimensioni ci ha arricchiti notevolmente; esibirsi dal vivo in contesti come un happening cui hanno partecipato altre band – parlo di Rockarossa, uno dei più importanti appuntamenti musicali del nostro territorio – è stato emozionante e gratificante per diversi motivi. Eseguire un brano nostro, dei BraindeaD, vecchio di un quarto di secolo, con l’esperienza di venticinque anni in più sulle spalle, è stato come sentire la carezza ideale del nonno che non hai mai conosciuto o del papà severo che vedeva il diavolo nel rock prima di accorgersi che la batteria era per il proprio figlio una specie di gemello siamese. Suonare a distanza di pochi minuti un brano di recente composizione ha rappresentato un ponte temporale, lungo cinque lustri, dove la fortuna e la gioia di esserci ancora hanno preso per mano la grinta e la consapevolezza di una vita vissuta intensamente.
P.L.C.: Sì, come dice Abele, è stato una sorta di ritorno alle origini. Quando abbiamo inciso gli “Appunti sonori per una cosmogonia caotica” vivevamo nello stato di grazia e felicità tipico di chi non era ancora del tutto diventato adulto. I tempi adesso, rispetto a quegli anni, sono cambiati, e non solo per questioni anagrafiche. Sentivo che l’ironia delle origini sarebbe stata fuori luogo in una fase politica e sociale come quella che stiamo attraversando e che volevamo raccontare.
“L’enigma del capitale” è un disco che nasce da una rabbia profonda e da un fortissimo sentimento di perdita. È il lutto per il venire meno di una serie di riferimenti ideologici, ma anche per la scomparsa di alcune persone care. Nel mio caso, ad esempio, ha inciso anche la lunga malattia di mia madre, che ho visto consumarsi lentamente, prima di morire nel 2019, proprio nei cinque anni di lavorazione dell’album. Mi portavo dentro come un grumo e, mentre per gli “Appunti sonori” avevo usato solo suoni puliti e overdrive leggeri, adesso volevo di nuovo fare urlare le mie chitarre e farle esplodere in faccia al mondo. E, nello stesso tempo, in questo magma ribollente di distorsioni e di droni cupi, volevo anche cercare una catarsi: volevo trasformare la mia rabbia in gentilezza; la gentilezza di mio padre, per esempio, che è stato un rivoluzionario sui generis, uno di quelli che ha sempre saputo che il vero cambiamento non nasce dall’estetica della violenza, ma dalla radicalità della sostanza più che della forma. In fondo, questo nuovo corso si sposava, per molti versi, con quello che è stato – ed ecco qui il discorso sulle origini! – il nostro passato con i BraindeaD.
Abbiamo deciso di dare il battesimo del fuoco al nostro progetto in occasione di Rockarossa, nel 2018, anche per onorare quel passato. Ma devo spiegare meglio: Rockarossa è stato un festival di musica indipendente che ha avuto luogo periodicamente, negli anni ’90, a Petrosino, una piccola cittadina di mare fra Marsala e Mazara del Vallo. Da quel festival sono passati un sacco di grandi nomi del rock siciliano: gli Uzeda, gli Use + Abuse di Giovanni Gulino (poi Marta sui Tubi), Roy Paci. Fra quei nomi c’erano anche i BraindeaD, che hanno suonato per tre anni di seguito a quella manifestazione. Quando il nostro amico Gianfranco Marino, ex chitarrista degli Use + Abuse, di Manu Chao e dei 99 Posse, e direttore artistico della rediviva rassegna, ci ha invitato, sulle prime abbiamo un po’ tentennato. Poi abbiamo deciso di fare a modo nostro: abbiamo partecipato suonando – al tramonto! – un pezzo allora inedito del castello delle uova (“Eserciti industriali di riserva”) e la suite Prog dei BraindeaD cui allude Abele, “Il deserto”. È stato anche un omaggio alla memoria, diciamo.
A.R.: …se non cedessimo a qualche tentazione, che vita sarebbe! Scherzi a parte, era arrivato un momento, anche nella storia dello storico festival Rockarossa, in cui era più che necessario rimettere i nostri corpi – ed i nostri strumenti – sulla prima linea di una lotta molto significativa per noi, per la nostra terra ed ancora per tutti: (citando non a caso “Gioia e Rivoluzione”) “il mio mitra è un contrabbasso / che ti spara sulla faccia / che ti spara sulla faccia / ciò che penso della vita / con il suono delle dita / si combatte una battaglia / che ci porta sulle strade / della gente che sa amare”.
S.S.: Non è stato per nulla semplice, tra l’altro. Avevamo in lavorazione “L’enigma del capitale”, di cui avevamo registrato, credo, quattro o cinque tracce. Un lavoro anche questo pensato principalmente per l’incisione e non certo per una esibizione dal vivo. Ad un certo punto ci arriva l’invito e ci siamo dovuti rimettere in gioco. Riarrangiare “Eserciti industriali di riserva” è stata la cosa più complessa. Tenere a bada per un mese intero la voglia di sperimentare e, in qualche modo… sprecare un mese intero che avremmo potuto dedicare allo studio di nuovi brani per venticinque minuti di celebrità è stata una scommessa. Magicamente, da quel momento, “L’enigma del capitale” ha preso una nuova forma, e di lì a poco il lavoro ha trovato un’accelerazione mai vista fino a quel momento. Insomma, la preparazione e l’esibizione live, stranamente e imprevedibilmente, ci sono servite per ritrovare l’energia giusta e portare a termine l’album. Avevamo bisogno di una valvola di sfogo evidentemente.
Frutto di questa “Fase 2” è un nuovo album: “L’enigma del capitale”, lavoro che muove la sua narrazione da tre eventi traumatici: il bombardamento alleato di Marsala dell’11 maggio del 1943, in cui morirono, in una sola notte, circa mille persone; lo scoppio della crisi del 2008 e i suoi effetti sulle nostre vite; l’uccisione del sindacalista siciliano Vito Pipitone, raccontata dalla viva voce di Gaspare Li Causi, suo compagno di lotte. Mi parlate delle tematiche, del vostro “legame” con le stesse e del modo in cui sono state trattate nei singoli brani?
A.G.: Il conflitto è il filo conduttore del lavoro. Che poi sia economico, militare o interiore è persino marginale rispetto all’importanza e al bisogno di riportare l’equilibrio. Di guerre ne abbiamo sentito parlare da bambini, a scuola; mai avremmo immaginato di viverle, sotto forme differenti, nel corso della nostra vita. In molti sono stati colpiti da ordigni ben più deflagranti delle semplici bombe; in molti sono morti ben prima di esalare l’ultimo respiro quando un gruppetto di birbanti giocherelloni ha scombussolato le regole dei mercati finanziari. Menti contorte di un pericolosissimo Monopoly dove tanti comuni mortali non hanno più avuto nemmeno la possibilità di passare dal Via.
Da marsalese, il bombardamento del ‘43 è una ferita dolorosa per la mia città e lo è stata fino all’ultimo per quei parenti che me l’hanno raccontato.
P.L.C.: L’idea del nuovo album comincia a nascere a partire dal mio ultimo viaggio negli USA. Era il 2009 e io mi trovavo a Philadelphia per un convegno di antichistica. Durante una pausa dei lavori sono uscito per le strade del centro storico: la città sembrava immersa in una cappa di silenzio. Era tutta una sequela di saracinesche abbassate e di negozi chiusi per fallimento. Per le strade di quello che si intuiva essere stato un quartiere vibrante e pieno di vita, c’erano solo pochissime persone e camminavano a capo chino, vestite di abiti sgualciti e con gli occhi pieni di una tristezza e di una rassegnazione che a me – che avevo conosciuto l’America scintillante degli anni ’90 – erano sembrate sconvolgenti.
L’illuminazione finale è arrivata qualche anno dopo, nel 2014. Stavo vedendo su YouTube un filmato d’epoca che riprendeva le strade del centro di Marsala nei giorni successivi al bombardamento alleato dell’11 maggio del 1943, in occasione del quale più di mille persone erano morte in una sola notte. In mezzo alle macerie delle palazzine sventrate di via Calogero Isgrò erano inquadrati due uomini vestiti di nero. Si muovevano con la stessa andatura lenta e mesta che avevo visto nei passanti di Philadelphia nel 2009. Ho rivisto, in loro, la stessa disperazione e la stessa rassegnazione. Ma quella rassegnazione era anche la mia, era la rassegnazione di tutto un mondo globalizzato che era stato investito da una crisi economica che aveva ulteriormente esacerbato le differenze sociali, e che aveva travolto l’umanità intera, rendendola ancora più fragile e indifesa proprio perché privata degli strumenti ideologici che avrebbero potuto portarla alla liberazione e alla ricostruzione. In quel momento, per me, la Marsala del dopoguerra era diventata l’epicentro di una sorta di rivelazione, la lente a partire dalla quale comprendere la verità atroce delle differenze sociali e delle ingiustizie economiche del mondo neoliberale.
In quello stesso anno avevo letto “L’enigma del capitale” di David Harvey, cui aveva fatto seguito la lettura di “Marx e la follia del capitale” e di “Finanzcapitalismo” di Luciano Gallino e de “L’uomo flessibile” di Richard Senett. L’idea iniziale era quella di creare una sorta di colonna sonora del saggio di Harvey. Poi, però, abbiamo deciso di aggiungere ai pezzi ispirati dalle letture saggistiche anche la sonorizzazione delle interviste private che avevo fatto – ad uso dei miei figli – a mio padre, che ha ricordato e raccontato quella Marsala degli anni ’40. La ribellione di mio nonno alla militarizzazione del lavoro fascista in periodo di guerra, l’occupazione dei feudi per protestare contro la mancata applicazione della Legge Gullo, la lotta contro la mafia davano una prospettiva diversa al racconto della crisi. Ricordavano che una reazione al disastro che ci circonda è pur sempre possibile, e che la rivoluzione può anche essere fatta in toni pacati e gentili.
Per il resto, ognuno di noi ha avuto, a suo modo, una storia di militanza, personale e familiare, nelle file della sinistra della nostra città. La storia di Abele addirittura risale ai suoi avi. Un suo antenato, Abele Damiani, è stato un garibaldino, socialista e sottosegretario agli interni del primo governo unitario postrisorgimentale.
“L’enigma del capitale” è stato anche un modo di rielaborare il lutto per la fine di quel mondo di idee e valori nel quale ci siamo formati. Ma il lutto si elabora proprio per andare avanti, per dare un segnale, per rinascere. Guardare l’abisso può farti diventare abisso, ma può anche aiutarti a capire come non finirci dentro o tirarti fuori.
B.M.: Naturalmente, dal mio punto di vista, non si tratta di eventi diversi, ma sempre dello stesso tragico evento: la guerra. Quella armata, quella economica, quella sociale. E se le prime due sono state guerre mondiali, la terza è una guerra che combattiamo noi siciliani (purtroppo non solo noi) ancora oggi. Quella guerra contro la mafia che è forse la più difficile da vincere perché i nemici non hanno divisa e a volte abitano di fianco a te (anche a meno di cento passi), e a volte sono quelli da cui dipende il tuo presente e il tuo futuro. È anche questo grande dramma che è raccontato nell’opera: sempre lo stesso e sempre diverso.
A.R.: Il legame con questi tre eventi per me è il legame con la storia della mia città, con la carne ed il sangue dei nostri predecessori… in un momento storico in cui la memoria si accorcia, la consapevolezza si annacqua, il quotidiano si fossilizza sul già noto (e quanto poco sappiamo…). Tirare questi tre fili con le dita significa ricordare da dove veniamo, agire nel presente in modo nuovo e costruire un futuro in cui, auspicabilmente, non commetteremo gli stessi errori. La Vita non è mai fuori da noi stessi, non è “colpa di qualcun altro”, non è fuori dalla portata dai nostri… cannoni (riempiti di fiori).
S.S.: Unire tre eventi apparentemente così lontani tra di loro è un modo per legare la macrostoria, quella degli eventi raccontati sui libri di scuola, a quella microstoria, altrettanto importante, dei singoli. Tutto si cala in un flusso il cui significato è sempre lo stesso: la dimensione del potere. Sia esso quello dei governanti che fanno le guerre, o quello dei banchieri che fanno soldi sulla pelle delle persone, o ancora quello dei boss mafiosi legati a doppio filo con i ricchi proprietari terrieri. Tutto fa parte dello stesso flusso in cui il controllo sulle masse si esercita sempre attraverso la violenza. Le vittime di questa violenza, come diceva Pietro, hanno tutte la stessa faccia: sono quei disoccupati generati dalla crisi del 2008, o i sopravvissuti ai bombardamenti del ’43 su Marsala che vagavano per la città alla ricerca di cibo o dei corpi dei loro cari. Ma ci sono anche i cortei dei compagni di Vito Pipitone, o di Peppino Impastato, o delle tante altre vittime della mafia. Sono la voce di chi non si arrende e vuole lottare per un destino migliore.
…ma c’è anche un messaggio di speranza…
A.G.: La speranza è il motore di ogni nostra azione. Nel disco, per quanto possa apparire cupo, sono tanti i contenuti ispirati dalla fiducia, dalle aspettative e dai desideri. Per quanto certi di appartenere a una minoranza, in questo caso musicale (ma non solo), l’auspicio è quello tirare dritti per la propria strada fondandosi su valori e fiducia.
P.L.C.: Proprio così… e in fondo lo dicevamo anche prima. Il disco vuole essere, a suo modo, un messaggio di speranza. Viviamo in un mondo in cui il presente è imposto come unica dimensione, che tende a cancellare il passato e quindi anche il futuro. Noi abbiamo voluto riagganciarci all’immediato dopoguerra, cioè ad un passato in cui esisteva ancora una prospettiva di ricostruzione futura. È lì che si possono aprire gli orizzonti del possibile!
B.M.: Esatto. Aggiungo che già la sola esistenza del disco è un messaggio di speranza. Il messaggio che voci “contro” esistono e possono farsi sentire, e che le cose non devono per forza andare in una direzione. Quando prenderemo coscienza che siamo noi (e con “noi” intendo noi come soldati, noi come consumatori, noi come legittimatori di certi atteggiamenti che sono mafiosi senza sembrarlo)… ecco, quando prenderemo coscienza, allora potremo pensare non solo a combattere il nemico ma anche di poterlo vincere.
A.R.: Assolutamente sì! Certo, il grumo narrativo e musicale dell’album è frutto della collaborazione fra tutti noi e del nostro sentire. E come accade quando si crea un dialogo, si succedono momenti di racconto, di denuncia, di emozione viva, di sintesi e catarsi finale (per un progetto che vada a buon fine, ci vuole tutto questo!). Ogni nota, ogni pausa, è specchio vivo di tutto quello che abbiamo condiviso insieme.
S.S.: La speranza è in quel corteo funebre. Nelle parole scritte sui muri della città di Marsala il giorno del funerale: viva Vito.
Vi va di spendere due parole sulla copertina dell’album, visionabile in realtà aumentata per mezzo di un’applicazione?
A.G.: Ho litigato con la tecnologia quasi cinquant’anni fa, sicuramente c’è chi ne potrà parlare meglio del sottoscritto (anche se sto cercando di adattarmi).
P.L.C.: Lascerei parlare Ambra a questo proposito. È stata lei a concepire la copertina e le piste narrative che ci stanno dietro. Poi Vito Foderà – che, sia detto per inciso, è uno dei miei amatissimi cugini materni – ci ha aiutato a realizzarla. Per certi versi, l’astronauta è un omaggio a Bowie; per un altro verso, ci piaceva l’idea che quello che un tempo era stato il simbolo della conquista delle nuove frontiere dello spazio e del futuro, diventasse adesso un essere spersonalizzato e privo di legami che fluttua in uno spazio immenso e solitario con un enorme buco nero alle spalle. Lo spazio creato dal tardo-capitalismo.
A.R.: Quando si è trattato di scegliere un’immagine per la copertina, ci siamo trovati davanti alla difficoltà di narrare visivamente un processo così lungo e complesso, evitando il rischio di cadere in immagini stereotipate e troppo descrittive. Abbiamo realizzato un set fotografico bellissimo, grazie alle competenze di Salvatore e degli amici che ci hanno… prestato il loro obiettivo (Luigi Spagnolo e Salvatore Castelli). La narrazione di quelle foto, però, in qualche modo non mi bastava, occorreva estraniarmi: mi sono messa immediatamente ai pennelli. Così è nata l’immagine dell’astronauta, unicamente dal “sentire” di tutto quello che ci aveva portati fino a quel punto. Un vagare nel vuoto che è un abbandonare la presa, il crollo di un sistema di riferimento che ci ha lasciato inermi e soffocati ma che è al contempo una liberazione interiore e non.
A completare il discorso, è arrivato l’incredibile contributo di Vito Foderà, che ha realizzato l’animazione della cover e il video del brano “Il flusso si interrompe” (e qui lo cito): “Dopo tre secoli di costante modellazione del mondo operata dal capitalismo, che forma ha assunto la realtà? Ai nostri occhi, ormai, quella che vediamo è l’unica forma, data e immutabile. La forma che permette al flusso del capitale di scorrere, fluire, circolare. Finché non si interrompe. A quel punto la realtà si deforma, si sforma, il sistema si riforma. Per assumere una nuova forma, quella più funzionale al capitale e alle nostre vite su di esso e da esso plasmate”. Per questo il vuoto dello spazio diventa chiave di liberazione e, in qualche modo, di rivolta.
S.S.: L’astronauta si perde nel vuoto. È un’immagine insieme terribile e magnifica: assenza di punti di riferimento e placido fluttuare verso un nuovo futuro, mentre qui, sulla terra, siamo ancorati alle rovine del capitalismo. L’idea di Ambra è stata magnifica e riesce a riassumere, in una sola immagine il significato dell’album.
Eccezion fatta per i temi trattati nei testi, quali sono i punti di contatto e le differenze sostanziali, secondo il vostro punto di vista, tra i due album? Musicalmente parlando, qualcosa di diverso si nota, direi…
A.G.: Gli “Appunti sonori” sono stati indubbiamente influenzati dal background figlio del Prog di matrice italica, con un’attenzione – sia pure, diciamo così, “divergente” – agli omologhi stranieri che si sfidavano a colpi di favole, leggende, letteratura e sperimentazione. L’ultimo lavoro, invece, risente degli echi sabbathiani e di quindici anni di digressioni varie. Nel complesso, è un lavoro più meditato, ponderato e non privo di una certa tristezza che ha pervaso le vite di alcuni di noi anche a causa della perdita di affetti fondamentali. C’è molto della nostra vita in entrambi i dischi… persino il pudore, a volte, viene meno.
P.L.C.: Come ti dicevo, gli “Appunti sonori” è figlio della fine degli anni ’90, di quella che nel loro saggio sulla New Italian Epic, i Wu Ming avevano individuato come l’età dell’ironia. “L’enigma del capitale”, invece, è un album a suo modo epico e dolente, anche se certe forme ironiche di citazionismo nascosto sono pur sempre presenti. Il primo album era figlio della gioia di vivere, questo è figlio della rabbia e del dolore, ma anche del desiderio della catarsi e della palingenesi.
Questa differenza concettuale, ovviamente, si ritrova anche nei suoni. Quest’ultimo è un album di rock rabbioso che si fonde con ondate cupe di post-rock e di Prog. Il primo album, poi, era stato inciso in presa diretta con lo spirito un po’ sbarazzino del “buona la prima”, questo è, invece, il frutto di cinque lunghi anni di lavoro, di discussioni, di sovra-incisioni e… di post-produzione… che abbiamo curato personalmente, in particolare io e Salvatore. Ma anche Ambra ha dato una mano.
A.R.: “Appunti sonori per una cosmogonia caotica”, è, come hanno ben definito i miei compagni di viaggio, un’opera tentacolare e magmatica al confine fra musica, teatro e poesia, che fonde forme estreme di free-jazz con il rock. Un disco che ho sempre trovato incommensurabilmente elegante, e sottile come freccia tesa al cielo. Ne “L’enigma del capitale” la storia si fa diversa… da un lato, i contenuti hanno impresso una forma molto più piena, molto più viscerale al suono. D’altra parte, si aveva l’esigenza di sperimentare un suono che fosse da un lato un ritorno a sonorità più… rock; dall’altro, un nuovo tentativo di rimescolare i generi e i nostri gusti, con un occhio puntato verso il post-rock.
S.S.: Avevamo bisogno di sperimentare un linguaggio nuovo. “L’enigma del capitale” per quello che riguarda il mio contributo suonato, è molto meno basato sui suoni sintetici e sull’uso di archi. Paradossalmente, ho lasciato a Pietro il compito di creare i soundscape con tastiere e droni di chitarra e mi sono dedicato alla ricerca di un linguaggio suonato più ipnotico e angosciante. In tutto l’album uso, sì e no, tre synth diversi e soprattutto molto pianoforte. Per me è stato un passaggio importante in cui scarnificare il sound generale dei brani serviva, in qualche maniera, a svuotare l’album dai manierismi che hanno costellato il percorso sonoro dei BrandeaD prima e degli “Appunti sonori” dopo. Questo, assieme all’apporto più rabbioso delle chitarre di Pietro, ha prodotto un suono profondamente diverso da quello del nostro primo lavoro, più in linea con i temi che trattavamo questa volta. Insomma, siamo rimasti consapevolmente legati al testo, più ancora che negli “Appunti sonori”.
E poi arriva la “Fase 3” in cui, a mio modo di vedere, la vostra idea di “traiettoria controcorrente” viene piuttosto stravolta. Dall’“asparizione”, la sola promozione digitale e il rigoroso riserbo sulle immagini dei membri del gruppo, si passa alla promozione con ogni mezzo possibile del secondo album (con ripubblicazione de “L’enigma del capitale” realizzata dall’etichetta Seahorse Recordings) e del messaggio politico ad esso sotteso e alla possibilità di poter finalmente vedere i vostri volti (il tutto sommato all’apertura ad un certo tipo di concerti della “Fase 2”). A cosa è dovuto questo “capovolgimento”?
A.G.: La fortuna del castello, come di molte realtà artistiche, è la rete, quel mezzo spesso criticato ma che, nella fattispecie, consente di arrivare dall’altro capo del mondo grazie a un click. Le varie possibilità che si hanno in tal senso hanno consentito a chi è certamente più capace del sottoscritto di organizzare campagne pubblicitarie e una rete di contatti che ci hanno permesso, comodamente seduti su un divano, di pensare a una distribuzione e all’uscita fisica del CD. Uno degli obiettivi potrebbe essere, Covid permettendo, qualche sortita live anche per pochi intimi e, magari, un reiterato eclissarsi nel pieno rispetto delle regole della… asparizione.
P.L.C.: Nel dire “con ogni mezzo possibile” forse abbiamo esagerato. Non è che abbiamo tutti questi mezzi di marketing a dire il vero! Diciamo che il messaggio che vogliamo veicolare, questa volta, non è soltanto musicale, ma anche politico. E poiché crediamo a questo messaggio, siamo disposti anche ad esporci un po’ di più. Ad esempio, abbiamo rinunciato all’autoproduzione e alla distribuzione indipendente affidandoci a Seahorse e ad Audioglobe. Ma non è che andremo a X Factor o a Sanremo, eh!!! Quelli, del resto, per noi non sono contemplati fra i mezzi “possibili”. Insomma… non è un capovolgimento di fronte. Diciamo che è un’evoluzione.
B.M.: Le differenze fra le diverse fasi, comunque, sono legate anche al messaggio contenuto nei due lavori. Il primo era un messaggio, per così dire, più “filosofico”, seppure radicato nella realtà, per cui il concetto e l’applicazione dell’asparire aveva un senso molto forte e in sintonia con il nostro modo di vedere di allora.
Il secondo è portatore di un messaggio sociale che, in quanto tale, ha bisogno di essere diffuso il più possibile. Quindi, come dicevo, il capovolgimento è dovuto al seguire la natura dei nostri messaggi e delle nostre idee… situate nel contesto in cui sono nate.
A.R.: Come dicevo prima, le nostre ultime scelte sono in parte attribuibili ad una presa di posizione, ad una sorta di combattimento sul fronte. La diffusione della musica – e delle informazioni – online, ci ha fatto scegliere di optare per la visibilità, per mettere l’accento sul fatto che dietro al progetto ci sono, innanzitutto, delle persone.
S.S.: Beh, il riserbo sulle immagini del gruppo era puro pudore: se volevamo vendere qualche copia era meglio se non ci vedevano in faccia (ride). A parte gli scherzi, non vedo sinceramente una grossa differenza tra la promozione del primo album e questa. Sono cambiati i tempi e di molto. All’epoca degli “Appunti sonori” la rete era ancora concepita come un mondo da esplorare. Per i musicisti, quindi, promuovere un album solo in rete equivaleva a farlo conoscere ad una nicchia ristretta di pubblico. Oggi il mondo musicale, e non solo, si è completamente ribaltato, per cui la rete, prima prateria sterminata su cui potere galoppare liberi, oggi è diventata la circonvallazione di una grande città nell’ora di punta e di per sé non ti offre più nemmeno quella visibilità verso il pubblico di nicchia che offriva anni fa. Voglio dire che, paradossalmente, rivolgersi ad un’etichetta e produrre un CD fisico è del tutto controcorrente (e pure antieconomico) almeno per un gruppo con un pubblico ristretto come il nostro.
Al netto di quanto già detto, quali sono, dunque, le differenze effettive tra le tre fasi del progetto?
A.G.: Più che di differenze di fasi, parlerei forse di differenze nelle intenzioni. Le intenzioni, in genere, sono influenzate da stati d’animo, possibilità, aspettative e da un certo realismo che a una certa età deve prevalere su altri elementi. La tecnologia ci aiuta a lavorare da casa anche con gli strumenti musicali; la cosa potrebbe dar luogo a fasi ulteriori di cui ancora potremmo non essere a conoscenza.
P.L.C.: Le differenze sono, oltre che ideologiche, anche logistiche. Nella “fase 1”, quella degli “Appunti sonori”, eravamo un gruppo… residenziale. Tranne Benny, che viveva a Trapani, vivevamo tutti a Marsala, e avevamo tempo a iosa per provare. Nascevamo dalla costola di una ex live band e avevamo deciso che non volevamo più fare certe cose.
Nella “fase 2” abbiamo capito come organizzare al meglio la logistica delle prove e delle incisioni (e di qualche sporadica apparizione dal vivo) pur vivendo a chilometri di distanza.
Nella “fase 3”… siamo in pandemia e dobbiamo ancora cercare di capire come e cosa fare per andare avanti. Abbiamo inciso due brani lavorando a distanza. Uno è stato una cover di “Bella ciao”, che abbiamo diffuso su YouTube in occasione del 25 aprile 2020; un altro è un inedito su cui stiamo ancora lavorando. Devo però dire che non ci divertiamo molto in questa modalità di lavoro, e stiamo semplicemente aspettando di poterci finalmente rivedere in presenza per capire un po’ i possibili sviluppi.
B.M.: Mi piace rispondere così: “fase 1”, l’assenza; “fase 2”, l’esistenza; “fase 3”, la presenza.
S.S: Credo che la “fase 1” sia stata quella della scoperta di un nuovo modo di concepire la nostra vena artistica, una sorta di manifesto ideale di ciò che volevamo fare da grandi.
La “fase 2” è stata quella della consapevolezza della maturazione di un percorso, quello che ci ha portato a concepire un album forse per la prima volta realmente legato al nostro modo di sentire, privo di fronzoli e manierismi che ci avevano caratterizzato sino ad allora.
La “fase 3” deve ancora cominciare e sinceramente non so quale sarà la strada che intraprenderemo. Non credo nell’idea di suonare a distanza; noi abbiamo bisogno del contatto visivo quando suoniamo, nell’aria aleggiano le nostre anime che si incontrano e si scontrano. Solo attraverso questo processo riusciamo ad essere davvero il castello delle uova. Musicalmente credo che vivremo l’ennesima svolta, ma è troppo presto per capirne la direzione.
Tornando per un attimo al tema concerti: com’è il castello delle uova sul palco? Cosa c’è da aspettarsi da un vostro live?
A.G.: Durante un nostro live potreste vedere occhi che suonano più e meglio di corde, tasti o tamburi…
P.L.C.: Stiamo programmando qualcosa. Ma preferiamo non sbottonarci. Sicuramente sarà qualcosa che prima non avevamo mai fatto, comunque.
B.M.: Ti rispondo con una sola parola su quello che ci si deve aspettare: lo spettacolo! Cioè tutto quello che attrae lo sguardo la vista e l’attenzione… e le orecchie.
A.R.: Cosa c’è da aspettarsi? A parte qualche mia papera (…eheheh! A volte il ritmo è così frenetico che comincio a suddividere fino allo sfinimento delle dita!), la mia immagine di un live del castello è un giro in mare durante una tempesta: la navigazione procede decisa sulla carena della batteria, fra le imponenti ondate dei riff di chitarra e di tastiera, il basso lancia le cime e in alcuni tratti di mare si viene rassicurati dalla voce del comandante. Non da ultimo, posso affermare che sicuramente l’aspetto performativo nel live ha, e avrà, sempre una certa importanza, sempre nell’ottica del “mettere nella carne” la narrazione poetica e musicale.
S.S.: Un lavoro di destrutturazione simile a quello degli “Appunti sonori” sarà quello che ci aspetta per riuscire a portare dal vivo “L’enigma del capitale”. Il tessuto sonoro pensato per uno studio di registrazione non si concilia perfettamente con l’esibizione dal vivo e, dunque, occorrerà ripensare alcuni passaggi e reinterpretare i brani. Avevamo già iniziato il lavoro, almeno concettualmente, prima ancora di pubblicare l’album. Poi la pandemia ha impedito persino quei pochi incontri che ci potevamo permettere durante l’anno, ed ora non vedo l’ora di iniziare questo lavoro preparatorio.
Cambiando discorso, il mondo del web e dei social è ormai parte integrante, forse preponderante, delle nostre vite, in generale, e della musica, in particolare. Quali sono i pro e i contro di questa “civiltà 2.0” secondo il vostro punto di vista per chi fa musica (e vista anche la vostra esperienza)?
A.G.: Suonare, comporre e confrontarsi a distanza consente di far fronte a duemila difficoltà di carattere logistico. Farlo in presenza, la domenica mattina mentre fuori piove, guardare dalla finestra le gocce d’acqua che fanno da spettatrici eleganti e discrete a un riff di chitarra, a un groove di batteria, a una linea di basso, a un pad di tastiera e a un verso parlato o cantato è qualcosa di insostituibile. Il grigiore nell’immaginarsi una scena del genere rimanda ai momenti più prolifici delle nostre prove quando, quasi sempre, piove dolcemente.
P.L.C.: Sì… accade anche in Sicilia che piova! (ride). Noi di solito proviamo in inverno e facciamo, con discrezione asparitiva, qualche sortita live in estate. Ma per tornare alla domanda… per chi ascolta, i pro sono, a prima vista, moltissimi. Per chi, come noi, suona senza inseguire le mode e le tendenze dominanti, invece, sono forse i contro a prevalere.
È opinione comune che piattaforme come Spotify e similia abbiano salvato l’industria discografica. Di certo, però, non hanno salvato i musicisti; anzi, hanno compiuto un’operazione che a me sembra analoga a quella delle enclosures of common lands delle origini del capitalismo: hanno recintato dentro nicchie di algoritmi il frutto dell’ingegno, riservando soltanto le briciole dei ricavi ai musicisti. È, in altri termini, una grande forma di alienazione della forza lavoro.
Al di là dei fattori economici, è comunque l’impatto antropologico che a me sembra degno di riflessione. Spotify e similia creano l’abitudine di ascolti bulimici e poco attenti, legati alla quantità più che alla qualità. Prova a chiedere a un ragazzino di 18 anni quale sia la differenza fra un file wave e un mp3. Scoprirai che non la conosce, e che non sa che i brani che ascolta sul suo smartphone sono di fatto l’equivalente sonoro di una bottiglia di plastica che viene schiacciata e compressa prima di essere buttata via.
Un possibile danno consiste poi nel fatto che le piattaforme di streaming eliminano il filtro e la mediazione degli “esperti”. Ricordo benissimo che il primo contatto che avevo con le nuove uscite quando ero ragazzino era quello delle recensioni. La musica era prima di tutto musica immaginata, che abitava – prima di arrivare all’orecchio – nello spazio indeterminato delle parole di chi la descriveva e la giudicava. Questo meccanismo creava attesa e desiderio, e quando finalmente avevi il tuo bel CD in mano, magari potevi anche restare deluso, ma la maggior parte delle volte te lo assaporavi in assoluta tranquillità, calandoti in una dimensione altra e unica, che ti isolava veramente dal resto del mondo.
Spotify da un lato democratizza gli approcci alle produzioni musicali: non c’è più bisogno delle parole o del giudizio dei critici, proprio perché ognuno si può fare da solo una propria idea del lavoro che vuole ascoltare direttamente in streaming, senza passare dalle riviste specializzate; dall’altro lato, però, questi primi ascolti sono sempre più distratti e veloci. L’effetto è che chi passa direttamente all’ascolto by-passa il giudizio della comunità degli esperti, ma di fatto, proprio per questo, non diventa mai un vero e proprio “esperto”. Entra a far parte di una comunità di utenti, e non certo di una comunità di “ascoltatori”.
B.M.: Quella del digitale è una rivoluzione, e come tutte le rivoluzioni ha i suoi pregi e le sue teste tagliate. Dipende tutto dall’uso che faremo dei nuovi straordinari mezzi messi a disposizione dalla tecnologia. Ad abusarne anche l’acqua è mortale. Io, in verità, non sono molto tecnologico e sono molto sospettoso riguardo a tutto questo. Ma non perché io sia contro il web e le sue possibilità per partito preso e a prescindere, ma perché conosco l’uomo e so che se c’è un modo per trarre il peggio da una cosa potenzialmente positiva, allora… lo faremo. Aspireremo al peggio del web e specialmente dei social e quando lo raggiungeremo (forse lo abbiamo già raggiunto), daremo la colpa a quelli che non ci hanno avvisato che era pericoloso. È per questo che non ho profili social personali.
A.R.: Chiaramente la rete ci ha aperto un mondo di connessioni impensabile fino a poco tempo fa; ma se per le nuove generazioni sarà parte integrante delle loro esistenze, per noi… vecchietti, che abbiamo vissuto la nostra adolescenza senza nemmeno il cellulare, sarà forse sempre un portale da cui entrare e uscire. Per chi fa musica in modo professionale, forse, può sembrare un generale peggioramento, ma magari sarà il modo di sdoganare la dimensione del gioco anche in questo serissimo settore.
S.S.: Mi riporto a quanto detto prima: quello che era una sterminata prateria in meno di dieci anni si è trasformato in una autostrada intasatissima. Ora, al di là dei risvolti economici che, come dice Pietro, hanno reso i musicisti manovalanza sottopagata, ad eccezione di quelli che hanno la possibilità di qualche passaggio televisivo, il vero problema è che questa autostrada non permette alcuna vera circolazione. Si sta tutti incolonnati più o meno ordinatamente in attesa che qualcosa sblocchi il traffico e ci permetta di uscire dall’ingorgo. Il bello è che non escono dall’ingorgo necessariamente quelli che hanno la macchina più potente, ma solo i più fortunati. Fuori di metafora, emergere dal traffico della rete è molto difficile e non consente una valutazione della qualità artistica di chi vi si propone. Indubbiamente consente una diffusione veloce in ogni capo del mondo, ma è pura illusione. Potresti avere un ascoltatore interessato in Papua Nuova Guinea, ma sostanzialmente il tuo progetto musicale è destinato a rimanere sconosciuto.
Io piuttosto vedo nel ritorno al concetto di tribù, degli spazi ristretti e del contatto fisico tra artista e fruitore il vero futuro.
E quali sono le difficoltà oggettive che rendono faticosa, al giorno d’oggi, la promozione della propria musica tali da ritrovarsi, ad esempio, quasi “obbligati” a ricorrere all’autoproduzione o ad una campagna di raccolta fondi online? E, nel vostro caso specifico, quali ostacoli avete incontrato lungo il cammino?
A.R.: Penso che Pietro possa rispondere meglio di chiunque altro, ma il nocciolo della questione sta nella rete che si riesce a creare…
P.L.C.: Per quella che è la nostra esperienza, con gli “Appunti sonori per una cosmogonia caotica” siamo riusciti con grande facilità a promuovere e distribuire il nostro lavoro senza alcun bisogno di intermediari: non avevamo ufficio marketing, non avevamo agenti, non avevamo ufficio stampa. E non li abbiamo ancora, a dire il vero! La logica era, ed è ancora, in tutto e per tutto, quella del Do It Yourself. In questo, Myspace è stato un potente alleato. A quel tempo esisteva ancora una comunità di ascoltatori esterna allo spazio della rete. Questa comunità acquistava ancora i CD e la rete funzionava soltanto come vetrina per qualcosa da trovare altrove. I brani che avevamo messo su Myspace, in particolare, funzionavano da gancio: chi ci scopriva poteva usufruire, lì, di un pre-ascolto, e poi, se si interessava (e molti si sono interessati: siamo arrivati anche ad avere 10.000 ascolti al giorno per qualche settimana!!!), ci contattava in prima persona per richiedere la spedizione del CD dopo aver pagato un contributo con PayPal.
Oggi, invece, l’esperienza dell’ascolto è circoscritta all’interno del web, da cui quasi nessuno esce più. L’offerta di musica è spropositata, anche perché è gonfiata dalla messe di brani prodotti da ragazzini che, senza saper suonare alcuno strumento, sfornano musichette facili dal chiuso delle loro camerette con Fruity Loops o Ableton. Nel nostro caso, capita spesso che l’ascoltatore distratto, in genere, si fermi a un brano e passi ad altro, magari perché non riesce a reggere l’impegno di un discorso e di una narrazione complessi che occupano l’intera durata dell’album. Per il resto, chi si interessa veramente a ciò che facciamo sa ormai che può ritornare ad ascoltarci quando vuole sulle varie piattaforme… che ci riservano pochi spiccioli. Pochissimi continuano ad acquistare i CD o i vinili. L’unico modo che i musicisti hanno per guadagnare veramente qualcosa è sacrificare la propria esistenza ai live e diventare fenomeni da baraccone. In questo senso la pandemia è stata un vero e proprio disastro per il settore. Per noi lo è stato relativamente. Anche perché noi fenomeni da baraccone proprio non vogliamo esserlo. La sola idea di passare la mia vita da un palco all’altro sacrificando i miei affetti e stando lontano dai miei figli mi ha sempre terrorizzato. Preferisco sempre la logica del baco da seta e dei tempi lenti. Questo, ovviamente, significa rischiare di andare in perdita… ma mi piace anche essere consapevole del fatto che non è per il denaro che noi stiamo facendo tutto questo. Per certi versi, tutto rientra nella logica del dono. La musica del castello delle uova è un dono, che facciamo, in maniera artigianale, a noi stessi e agli altri.
B.M.: Quali ostacoli? Tutti! Come tutti quelli che fanno arte, sappiamo che, come diceva il Cavaliere, con la cultura, quindi con l’arte, non si mangia. Soprattutto se non sei in carreggiata, ma ti muovi, come diciamo in Sicilia, “trazzere trazzere”, cioè per strade di campagna. E noi del castello siamo molto fuori carreggiata. Ma è una cosa che è sempre successa. Pure agli U2 avevano detto di cambiare mestiere. Quindi se fai arte non omologata, sai già che avrai problemi ma, grazie a questo, parti già avvantaggiato; lo sai, ci convivi e ne fai quasi un punto d’onore. In realtà… anche a noi, sotto sotto, piacerebbe fare la stessa fine degli U2.
S.S.: Mi allaccio alla mia risposta alla domanda precedente. La visibilità offerta dalla rete è solo apparente. Diciamocelo chiaramente: la musica “facile” c’è sempre stata: sono cambiati gli strumenti, ma tutto sommato anche trenta o quaranta anni fa esistevano le piccolissime etichette discografiche dove bastava pagare una somma di denaro per portarsi a casa un vinile destinato a prendere polvere negli scaffali degli amici o dei parenti. Solo che, una volta, le etichette minori, ma più legate agli ambienti underground, riuscivano a campare e proporre della buona musica.
Oggi queste etichette sono state tutte travolte dalla crisi del mercato discografico ed hanno finito per chiudere quasi tutte. Mancano a mio avviso quei luoghi dove un buon musicista, senza per forza passare da X Factor o da Sanremo, possa affermarsi tra una cerchia di appassionati. Manca insomma la tribù, mancano gli appassionati di genere, o, per dirlo meglio, questi fenomeni oggi coinvolgono un pubblico meno specializzato e riguardano generi musicali come la trap, di consumo veloce e poco critico. La musica più intellettualizzata è stata completamente travolta, dunque, da un lato dal fatto che il mercato ufficiale rimasto è diventato sempre più marginale e, dall’altro, dal fenomeno nuovo di una musica, diciamo così, “popolare” che certo ha dato nuovi riferimenti ai più giovani, ma che tuttavia è poco incline ad un ascolto consapevole, ed è più rivolta al consumo acritico.
Come diceva Pietro, in questo percorso noi siamo fortemente atipici, perché non inseguiamo il successo né i soldi (i sacri valori della trap!), e questo ci ha agevolato nella produzione dell’album che abbiamo deciso di autofinanziarci. L’apporto della Seahorse Recordings ci ha, invece, dato una mano nella realizzazione del CD fisico e nella sua distribuzione.
Facendo un parallelo tra letteratura e musica, tra il mondo editoriale e quello discografico, è, non di rado, pensiero comune etichettare un libro rilasciato tramite self-publishing quale prodotto di “serie B” (o quasi), non essendoci dietro un investimento di una casa editrice (con tutto il lavoro “qualitativo” che, si presume, vi sia alle spalle) e, in poche parole, un giudizio “altro”. In ambito musicale percepite la stessa sensazione o ritenete questo tipo di valutazione sia ad uso esclusivo del mondo dei libri? Al netto della vostra esperienza, consigliereste alle nuove realtà che si affacciano al mondo della musica la via dell’autoproduzione?
A.G.: L’autoproduzione racchiude un elemento fondamentale della nostra esistenza: la libertà. Curare in toto (o quasi) la propria produzione vuol dire farsi spazio nella giungla del mercato musicale dove, purtroppo, emergono troppe realtà “mordi e fuggi” destinate a spegnersi nel tempo di un respiro a fronte di tantissimi progetti degni che non hanno la giusta spinta o quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Fortunatamente siamo testimoni di tanti amici e conoscenti che grazie all’autoproduzione riescono a guadagnarsi lo spazio a cui aspirano.
P.L.C.: Non so fino a che punto le dinamiche dell’editoria musicale possano essere equiparate a quelle del mercato librario, per il semplice fatto che, se stai pubblicando un romanzo o un saggio, una casa editrice non valuta soltanto le potenzialità di vendita, ma si affida a una redazione, a dei referee o a degli agenti letterari che valutano anche la qualità scientifica o letteraria del “prodotto”.
Nell’editoria musicale temo, invece, che il fattore commerciale sia ormai da molto tempo quello preponderante (se non l’unico). Per il resto, non mi sento di consigliare niente a nessuno. Certo, nel campo della musica l’autoproduzione implica una fatica maggiore, ma forse riserva anche qualche soddisfazione in più. In letteratura e nell’ambito scientifico, invece… mi guardo bene da chi si autoproduce e si autopromuove. Insomma, qui sono d’accordo con il pensiero comune: il libro rilasciato tramite self-publishing è spesso l’inutile prodotto narcisistico di chi non sa aspettare.
B.M.: Fino a poco tempo fa ti avrei risposto che quello che dici vale molto più per l’editoria che per la musica. Per il semplice fatto che tutti possono scrivere, anzi…tutti scrivono, me compreso; per cui pubblicare tutto quello che viene scritto sarebbe impossibile per le case editrici. Ma, almeno fino a poco tempo fa, non tutti erano in grado di fare musica, per cui un disco auto-pubblicato aveva, un tempo, un altro valore, e non era necessariamente scadente, anzi… molte volte, anzi, se ne apprezzava l’artigianalità, e lo stesso fatto di essere slegati da case discografiche famose poteva essere addirittura un fattore di vantaggio. Ma adesso, con le possibilità offerte da internet e dai suoi infernali programmi, tutti sono in grado di fare tutto e di auto-pubblicare qualsiasi nefandezza a costo zero, per cui…
A.R.: Giocoforza, le vecchie realtà discografiche ed editoriali hanno nel web un competitor enorme. Ma mi auguro che si possa pensare a questo non come ad una dicotomia bella e buona, ma solo ad un ampliamento delle scelte. Non esiste un percorso identico all’altro e si trovano ottimi e pessimi prodotti dappertutto, anche nelle nuove produzioni per il web.
S.S.: Non saprei cosa dire. Una casa discografica oggi è qualcosa di molto diverso rispetto al passato. La crisi del settore musicale ha portato le major ad azzerare, o quasi, la ricerca di prodotti musicali alternativi e lanciarsi esclusivamente sugli artisti consolidati, e comunque a proporre contratti agli emergenti dopo che questi hanno già ottenuto un successo di pubblico importante. Insomma, nessuno scommette più sui giovani musicisti, a meno che non abbiano qualche milione di visualizzazioni su YouTube.
Nel campo della letteratura la situazione è abbastanza diversa… almeno, per quel poco che conosco il settore, così mi pare. Lì ancora il ruolo di una casa editrice è qualcosa che va al di là della semplice stampa del libro, e forse c’è ancora un filtro importante per valutare la qualità del prodotto che verrà stampato.
Per tornare alla musica, non me la sento di dire che chi si autoproduce lo fa per bypassare il filtro delle case discografiche, perché un vero filtro non c’è più. Mi sentirei pertanto di concludere che l’essere prodotti dalle etichette, piccole o grandi che siano, o autoprodursi non fa la differenza in termini qualitativi. Anche la percezione del pubblico credo che abbia ormai superato questa distinzione.
E qual è la vostra opinione sulla scena Progressiva Italiana attuale? C’è modo di confrontarsi, collaborare e crescere con altre giovani e interessanti realtà? E ci sono abbastanza spazi per proporre la propria musica dal vivo?
A.G.: Sarà la vecchiaia… ma quando sento la parola “prog” non posso fare a meno di pensare alle band che hanno caratterizzato i miei ascolti da giovane; inutile imbattersi in citazioni, qualcuno lo farà in mia vece. Mi piacerebbe che qualcuno si facesse carico di organizzare un festival del Prog Italiano in cui poter vedere sullo stesso palco le band storiche e le nuove realtà, anche per dare un segnale sul fatto che certa musica dovrebbe non morire mai. Sarebbe un sogno.
P.L.C.: Queste realtà, a dire il vero, ci sono. Penso ad esempio all’attivismo organizzativo di un nostro amico settentrionale, Loris Furlan della Lizards Records, o ad altri. Devo invece dire che a me… forse non piacerebbe partecipare a un festival di solo Prog. Mi sentirei dentro una riserva indiana!
Confesso poi di non essere particolarmente interessato alla scena Progressiva attuale. Sono decisamente affezionato alla old school: Area, Yes, King Crimson, i primi Banco. Per il resto, trovo che il Prog Italiano sia diventato eccessivamente nostalgico e stereotipato, a volte ai limiti del ridicolo. Gli unici musicisti Prog contemporanei che mi piacciono davvero sono, sia pure nel loro approccio indubbiamente “conservativo” e rétro, i norvegesi Motorpsycho. Nei loro album, obiettivamente, c’è sempre un che di già sentito, ma devo dire che loro sanno mescolare dosi e ingredienti vecchi sempre in maniera mirabile ed elegante.
Per il resto, devo dirti che l’epicentro della nostra musica è l’estrema parte occidentale di un’isola, la Sicilia, che nel nostro caso è bagnata dal mare a ovest, a nord e a sud. Nella città dove siamo nati – e dove ormai solo Salvatore è rimasto a vivere – c’è stata una scena vivissima negli anni ’90, quando non si dava molta importanza al tipo di musica che si faceva. Molte band – BraindeaD compresi – erano formate da musicisti che ascoltavano i generi musicali più disparati, e questo dava vita a fenomeni di speciazione ibrida particolarmente interessanti.
Per conto nostro, spesso ci troviamo a collaborare con altri, senza troppo stare attenti a quanto sangue Prog scorra nelle loro vene. Io, ad esempio, ho scritto dei brani in dialetto siciliano per il nostro amico Gregorio Caimi, che porta avanti con grande successo un progetto di world music chiamato I Musicanti. Poco prima della pandemia, Abele ha accompagnato in una tournée europea i Blessed Child Opera di Paolo Messere, che fra le altre cose è il proprietario della Seahorse Recordings, che ci ha pubblicati. Salvatore suona ormai da anni anche per una storica blues band della nostra città, i Kinisia. Io e Ambra, poi, abbiamo recentemente creato delle colonne sonore per il teatro e dato una mano al nostro amico Angelo Barraco nella realizzazione del prossimo album dei Mammut nel Caos, un progetto a metà fra post-rock, industrial, musica sperimentale e drone-music.
Quanto alla musica dal vivo, in Sicilia gli spazi sono ancora pochi, soprattutto per chi fa un certo tipo di discorso. Questo un po’ ci dispiace. Devo, però, dire che noi non siamo particolarmente interessati a… popolarli. Non disdegniamo di tanto in tanto di fare qualche comparsa dal vivo, ma noi siamo principalmente una band che compone e che immagina intrecci di narrazioni e percorsi musicali, e non tanto una band che si espone… fisicamente.
B.M.: Sul panorama Prog Italiano attuale non ho un’idea precisa, anche perché è molto variegato e ampio. Direi comunque che valgono lo stesso discorso e le stesse dinamiche della risposta precedente.
A.R.: Beh, in questo momento tutta l’industria della cultura e dello spettacolo sta letteralmente agonizzando a causa dei provvedimenti anti-covid. Questo crea una voragine che in qualche modo rientra appieno nel discorso de “L’enigma del capitale” e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. I circuiti ci sono sempre stati, più o meno in relazione fra di loro e più o meno sotterranei. Spero che questo momento di crisi ci aiuti tutti a relazionarci di più senza i soliti, vecchi schemi stantii.
S.S.: Francamente non saprei dare un’esatta delimitazione della scena Prog Italiana. Noi stessi, temo, non rientriamo più nel panorama Progressivo. Penso che il messaggio del Prog, inteso come gusto della sperimentazione, abbia intrapreso altre strade e che è necessario individuare in questi percorsi quello che stanno facendo alcuni giovani musicisti. Per una riscrittura degli stilemi del Prog, dunque, va esteso il concetto fino ad arrivare alla musica sperimentale e cercare in quegli anfratti quello che c’è di veramente nuovo. Purtroppo, ancora una volta ci scontriamo con il silenzio assordante dell’editoria musicale poco attenta ad individuare quanto di meglio c’è in giro. Certo, sarebbe bello potersi confrontare con gli artisti che cercano di rappresentare tutto questo.
I live, di questi tempi, sono un miraggio lontano, naturalmente, ma credo che in futuro, a causa della pandemia, si svilupperà un nuovo modo di concepire la musica dal vivo. Se mi si passa il termine, immagino un modo più “teatrale”… immagino, cioè, una commistione sempre maggiore tra performance recitative e musicali. Si va verso forme di intrattenimento artistico più articolate e interdisciplinari e credo che questo sia solo un bene per tutti.
Esulando per un attimo dal mondo il castello delle uova e “addentrandoci” nelle vostre vite, ci sono altre attività artistiche che svolgete nel quotidiano?
A.G.: Se l’ironia fa parte delle attività artistiche credo di poter dire di essere una sorta di giullare. A parte questo, in passato ho collaborato con alcune testate online e con un settimanale dove scrivevo di musica e di sport. Sì… ho fatto il giornalista, ma senza mai smettere di fare il musicista per lavoro.
P.L.C.: Mah… ho dedicato molto tempo della mia vita alla scrittura in versi, e qualcosa ho anche pubblicato (in proprio, da bravo scrittore di serie B… ma la poesia, di fatto, è TUTTA pubblicata in proprio!). Ho scritto anche un romanzo, che però tengo gelosamente nascosto nel mio cassetto (non mi convince un gran che, lo devo confessare). Dedico comunque ancora gran parte del mio tempo alla ricerca antichistica. Due frutti recenti di questa mia attività sono un saggio pubblicato con Il Mulino nel 2018, intitolato “Gli animali nel mondo antico”, e un Millennio Einaudi intitolato “L’anima degli animali”, che ho curato assieme al mio amico e collega Roberto Pomelli nel 2015. Direi che, se escludiamo il lavoro di insegnante, con cui porto il pane a casa, questa è la mia occupazione principale… assieme alle scorrerie musicali, che più passa il tempo più diventano la mia personale via verso la felicità.
B.M.: Sì, scrivo principalmente. Mi piacerebbe sapere dipingere, ma non sono capace.
A.R.: Chiedimi cosa non faccio… Scherzo, ma da brava figlia di Efesto son sempre stata così attiva e così trasversale che metto le mani quasi dappertutto! Oltre al teatro (al momento sto lavorando ad un testo per teatro ragazzi), sto progettando un’installazione outdoor per un concorso e sto lavorando un po’ la creta. Conto di cominciare un progetto di illustrazione presto!
S.S.: Oltre che musicista sono anche un fotografo amatoriale. Anzi, da un po’ di anni dedico decisamente più tempo alla fotografia che alla musica per dire la verità.
P.L.C.: Salvatore è più che un fotografo amatoriale, ormai! Gli scatti delle rovine nella sezione interna della cover del nostro CD sono suoi! E io li trovo meravigliosi!
E parlando, invece, di gusti musicali, di background individuale (in fatto di ascolti), vi va di confessare il vostro “podio” di preferenze personali?
A.G.: A parte i Queen, che sono quasi parenti, fare un podio sarebbe un’offesa a tante band che hanno dato tanto alla mia vita. Ci provo: Rush, Area, Pink Floyd.
P.L.C.: Difficilissimo! Il mio podio cambia di settimana in settimana… anche se la prima posizione rimane sempre fissa: i Led Zeppelin. Ma diciamo la verità: sono musicalmente onnivoro! Se mi metto a citare album che mi piacciono e mi hanno dato qualcosa, venti pagine non bastano. Forse, in questa fase della mia vita, subito dopo i Led Zeppelin metterei “Lift your skinny fists like antennas to heaven” dei Godspeed You! Black Emperor. Poi, forse, aggiungerei “Linea gotica” dei CSI. Mi fermo qui, però, potrei cambiare il secondo e il terzo posto del podio fra trenta secondi… ecco vedo già “Grace” di Jeff Buckley e “Badmotorfinger” dei Soundgarden che incalzano, per non parlare di “Red” dei King Crimson o di “Arbeit macht frei” degli Area!!!
B.M.: Musica internazionale: Tom Waits, The Smiths, The Cure, Massive Attack e tutta la musica dark e sperimental-rock anni ‘80 (Sisters of Mercy, Cocteau Twins, Dead Can Dance, Flying Lizards), ma anche un certo tipo di jazz, sempre anni ’80, tipo i Lounge Lizards, e poi The Church. Musica Italiana: Franco Battiato, Edoardo Bennato, Fabrizio de André, poi tutti i cantautori e molto degli anni ‘80/‘90 (CCCP, Litfiba, Franti, Almamegretta, Mau Mau, BandaBardò, Modena City Ramblers).
A.R.: Un podio? Tre? Ahi, ahi, ahi… direi Godspeed You! Black Emperor, King Crimson, Aphex Twin (e se permetti una seconda triade: Fela Kuti, Beirut, Thom Yorke) e… ho citato gli Area? Ma… no, devo fermarmi qui!!!
S.S.: Accidenti, anche per me non è semplice. Adoro il blues delle origini, quindi sul podio metterei Robert Johnson, ma anche B.B. King, ma anche Eric Clapton. Sicuramente uno spazio lo lascerei per i Black Sabbath, il mio gruppo hard rock preferito. E poi ci sono i Jethro Tull, i King Crimson, i Pink Floyd. Fra gli italiani ci metto Pino Daniele, i Banco prima maniera, gli Area, ma anche Francesco De Gregori e Lucio Dalla. Ma dai! Come si fa a costruire un podio? Impossibile!
Restando ancora un po’ con i fari puntati su di voi, c’è un libro, uno scrittore o un artista (in qualsiasi campo) che amate e di cui consigliereste di approfondirne la conoscenza a chi sta ora leggendo questa intervista?
A.G.: Calvino su tutti, ma ultimamente sto apprezzando molto Gianrico Carofiglio. E poi… consiglierei a tutti di leggere i lavori di un musicista contemporaneo di cui sentirete parlare molto, si chiama Pietro Li Causi!
P.L.C.: Come avrai capito, Abele è per me quello che la Bestia è per Salvini (ride)! Comunque, anche qui… Donato, tu vuoi sterminare la foresta dell’Amazzonia con i nostri elenchi! Per molto tempo ho divorato romanzi di scrittori contemporanei. Adesso, invece, guardo con sospetto ad ogni cosa nuova che venga pubblicata, e preferisco semmai rifugiarmi nei classici. A dire il vero, leggo prevalentemente saggi, per lo più di antichistica, di antropologia, di etologia, di sociologia. Se parliamo di letteratura, anche in questo caso il mio podio è mutevole, ma in cima a tutto metto sempre due scrittori completamente diversi fra loro, che sono Dostoevskij e Calvino. Fra i contemporanei, lo scrittore italiano che più mi ha colpito di recente è stato senza dubbio Nicola Lagioia. “Riportando tutto a casa” mi ha impressionato per la profondità, l’intensità, la scrittura affilata e dolente, la capacità di mettere le mani nel cuore profondo del marciume politico e antropologico dell’Italia. Avevo poi iniziato “La ferocia” la scorsa estate, ma confesso di averlo lasciato alla scena del funerale, che mi ha turbato quasi fino a portarmi al collasso. Per il resto, comunque, fra i viventi, amo molto gli americani, come Don DeLillo e Thomas Pynchon. E non riesco ancora ad accettare l’idea che sia morto Roberto Bolaño, di cui amo tutto ciò che ha scritto.
B.M.: Essendo uno a cui piace scrivere, amo anche molto leggere, e quindi leggo di tutto, da Wilbur Smith a Proust; ma se dovessi consigliare qualcosa direi senza dubbio la “Divina Commedia”, tutti i giorni, tre volte al giorno… e poi l’opera omnia di Charles Bukowski, quella di Gabriel Garcia Marquez e le poesie di Octavio Paz e Rainer Maria Rilke.
A.R.: Fra gli amori primordiali nell’arte, Duchamp e Kosuth; fra le mie conoscenze, amo moltissimo il lavoro da illustratrice di Cevì e le opere di Raffaele Fiorella. Fra i libri indispensabili adesso ho le opere di Riccardo Falcinelli (design) e Stefano Mancuso (neurobiologia vegetale), Anne Givaudan (terapie essene) e… sì, sto rileggendo “Auntie Mame” (romanzo di formazione di Patrick Dennis) e le poesie di Chandra Livia Candiani.
Voglio però segnalare anche il lavoro di un giornalista marsalese nostro amico: si tratta di Giacomo di Girolamo, di cui sto ascoltando – a proposito di nuovi media – il podcast di Audible original intitolato “L’isola di Matteo”, che racconta, grazie a Matteo Caccia, la storia di Matteo Messina Denaro e di Giacomo stesso, che negli anni ne è diventato praticamente il biografo. Nel suo genere, secondo me, è una vera e propria opera d’arte.
S.S.: José Saramago e Garbiel Garcia Marquez su tutti. Poi per me che sono un grande appassionato di gialli, Simenon e Vázquez Montalbán. Non disdegno Camilleri per una lettura più rilassante. Ma poi ci sono i grandi… Dostoevskij e Calvino, Queneau. Insomma, anche qui potrei continuare per ore… meglio fermarsi.
Tornando al giorno d’oggi, alla luce dell’emergenza che abbiamo vissuto (e che stiamo ancora vivendo), come immaginate il futuro della musica nel nostro paese?
A.G.: Personalmente credo che il ritorno sui palchi, in generale, possa dar vita a un nuovo modo di pensare la musica. C’è tanta di quella voglia che si può trasformare in energia positiva da poter far rivivere una nuova Woodstock. Di contro, però, non dimentico che il settore artistico, in generale, è stato relegato, come al solito, all’ultimo posto nella considerazione delle alte sfere dei governanti nel periodo di maggiore difficoltà degli ultimi settant’anni. Chi lavora nel mondo dello spettacolo non è un dopolavorista, è bene che qualcuno ai piani alti se ne ricordi.
P.L.C.: “In un futuro non troppo lontano, un algoritmo ad apprendimento automatico potrebbe analizzare i dati biometrici che fluiscono da sensori collocati sulla superficie e all’interno del vostro corpo, determinare il tipo di personalità e i mutamenti dell’umore e calcolare l’impatto emotivo che una specifica canzone – perfino una particolare combinazione armonica musicale – può avere su di voi”, il passo successivo potrebbe essere che l’algoritmo inizi “ad armeggiare con le stesse canzoni e melodie, facendo piccole e continue variazioni” diventando esso stesso creatore di musica e sostituendo del tutto i musicisti umani. Quelli che ho citato sono passi tratti da “21 lezioni per il XXI secolo” di Yuval Noah Harari. Quando l’ho letto per la prima volta mi era sembrata una follia visionaria. Adesso che conosco dal suo interno i meccanismi di Spotify e il modo in cui operano gli algoritmi per creare le playlist centrate sui gusti degli utenti, non sono più sicuro che sia così. Del resto, da un po’ di tempo con Ambra ci siamo messi a traccheggiare per un nostro progetto parallelo di musica elettronica, e abbiamo visto quanto sia facile affidarsi completamente ai parametri e ai preset casuali che ti forniscono certi plug-in. Devi fare uno sforzo enorme per gestire in maniera creativa i processi. La scelta più facile è quella di far fare tutto al computer!
B.M.: Come immagino il futuro della nostra musica? Sfolgorante, se devo essere sincero. Dopo aver toccato il fondo e cominciato a scavare, come la musica sta facendo adesso, non si può che migliorare. Sinceramente penso, come diceva Battiato, che anche noi siamo “sommersi da immondizie musicali”, il modo di cantare del 90% dei cantanti nostrani (ma anche di quelli stranieri), con quel birignao tra l’annoiato e lo scazzato, e con tutte le vocali oscenamente aperte, mi riesce davvero insopportabile.
A.R.: Usi un verbo interessantissimo: “immaginare”! Allora, io voglio immaginare il futuro più bello possibile, in cui si possano colmare i vuoti esistenti finora e creare sempre più spazi, in barba al Netflix della cultura!
S.S.: Credo che la mazzata che ci è caduta tra capo e collo lo scorso anno lascerà strascichi ancora a lungo. Immagino un futuro piuttosto lontano in cui le diverse forme d’arte si fonderanno sempre di più. Quali saranno i nuovi linguaggi sinceramente non saprei dirlo con certezza. Si vede troppo poco in giro per capirci qualche cosa. Mi sembra tuttavia interessante quello che è successo nell’ultimo Sanremo con le performance di diversi giovani autori che hanno trasformato l’interpretazione delle loro canzoni in qualcosa di diverso e più articolato. Credo che un autore come Achille Lauro, ad esempio, abbia qualcosa di nuovo e diverso da dire, e non mi affretterei ad etichettarlo come “fenomeno mediatico del momento”. Al contrario, credo che sia uno di quelli che veda un po’ più lontano degli altri e inevitabilmente finirà per tracciare una strada. Anche se a me sinceramente le sue canzoni non piacciono granché, tuttavia vedo in questo nuovo modo di interpretare una performance musicale una forma che avrà parecchi sviluppi in futuro.
Prima di salutarci, c’è qualche aneddoto che vi va di condividere sui vostri anni di attività?
A.G.: Gli aneddoti, tantissimi, di cui potrei parlare riguardano episodi esilaranti in cui abbiamo rischiato il soffocamento per le troppe risate. Vorrei lasciare un alone di mistero soprattutto… non voglio mica scalfire l’immagine seriosa e un po’ cupa che caratterizza i nostri lavori musicali!
P.L.C.: Uno solo??? Guarda che con Abele e Salvatore suoniamo insieme dal 1989! Ti stai inoltrando in un sentiero molto pericoloso e… lungo! Io ho tanti ricordi bellissimi della vita passata assieme ai miei compagni di viaggio del castello e, ancora prima, con gli altri membri dei BraindeaD, con cui siamo sempre in contatto. Attenzione, in trent’anni c’è stato anche qualche screzio, eh… ma sia i moltissimi momenti belli che i pochissimi momenti di tensione preferisco tenermeli per me! Già ti ho raccontato la miracolosa riapparizione di Benny nella mia… nella nostra vita!
B.M.: Gli aneddoti sono tanti, ma sarebbe troppo lunghi raccontarli… per cui mi astengo.
A.R.: Più che aneddoti, a me va di ricordare luoghi. Abbiamo la fortuna di vivere in una terra bellissima, e in questa terra ci sono i luoghi della nostra infanzia, che ci siamo come scambiati condividendoli negli anni: la casa della famiglia di Pietro, in collina, a Calatafimi, dove è stato fatto uno dei primi secret live del castello delle uova a cui ho avuto la fortuna di assistere… quando ancora non esistevano i secret live; la casa della famiglia di Abele in contrada Misilla, a Marsala, che è un osservatorio su una delle lagune più belle della provincia, terra dei Fenici. Poi c’è la casa dove attualmente vivo, che è ormai il quartier generale delle nostre prove. È un antico casolare rurale immerso negli uliveti e nei vigneti. Questi sono tutti centri del cuore che forse prossimamente saranno scenario di una nuova narrazione.
S.S.: Beh… ricordo una prova di una domenica di tanti anni fa, dei BraindeaD. Alle nostre prove, a volte, partecipavano curiosi e vicini di casa che ci venivano a vedere. Noi eravamo così, il pubblico ce lo portavamo anche alle prove. Ai tempi i telefonini ancora non esistevano per cui, quella domenica, ad un certo punto, arriva una telefonata. Risponde il padrone di casa, il nostro bassista Maurizio, e comincia a chiacchierare con una certa Maria. Naturalmente i nostri commenti su questa Maria cominciarono a farsi sempre più pesanti ed allusivi, un po’ come dire… goliardici, sulle virtù di questa Maria. Quando il buon Maurizio chiamò al telefono, appunto, uno dei nostri ospiti occasionali per dirgli che sua madre, Maria appunto, voleva parlargli. Il gelo è calato in sala prove. Insomma, per quel giorno fu impossibile continuare a suonare, avevamo ancora tutti in testa la signora Maria.
E per chiudere: c’è qualche novità sul prossimo futuro de il castello delle uova che vi è possibile anticipare?
A.G.: L’obiettivo primario è quello di tornare a guardarci negli occhi dal vivo e non attraverso una webcam. Potessimo farlo a breve significherebbe anche poter pianificare qualcosa, una prova, un live (me lo auguro) o, semplicemente, una mangiata: nessuno ha detto che i BraindeaD sono nati attorno al tavolo di una gelateria e i castellani hanno mantenuto negli anni la tradizione del convivio in maniera più che degna…
P.L.C.: Al momento abbiamo serie difficoltà a progettare. Nel momento in cui stiamo rispondendo a questa intervista Benny si trova a Brescia, Ambra a Petrosino, Abele a Trapani, Salvatore a Marsala e io a Palermo. Tutte le nostre città sono in zona rossa e noi non possiamo neanche uscire di casa. Ci siamo visti varie volte all’aperto e con le mascherine, ma non riusciamo a provare per come si deve da tempo. Al momento viviamo in un tempo sospeso, e anche solo progettare ci risulta difficile.
A.R.: Quello che è sicuro è che è dai luoghi, in accordo con i loro rispettivi genii, che continueremo a narrare.
S.S.: Beh, dai! Un secret live de “L’enigma del capitale”… e che cavolo! Dovrà finire prima o poi ‘sta pandemia!
Grazie mille ragazzi!
A.G.: Grazie mille, Donato, è stato un piacere e un onore!
P.L.C.: Ma grazie a te, davvero!
B.M.: Grazie a te, e grazie a tutti quelli che leggeranno l’intervista.
A.R.: Grazie a te, Donato. E grazie a tutti voi!
S.S.: Grazie di cuore, Donato. È stato un vero piacere.
(Maggio, 2021 – Intervista tratta dal volume “Dialoghi Prog – Volume 2. Il Rock Progressivo Italiano del nuovo millennio raccontato dai protagonisti“)








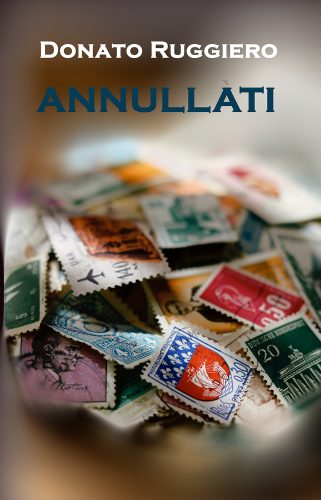
Lascia un commento